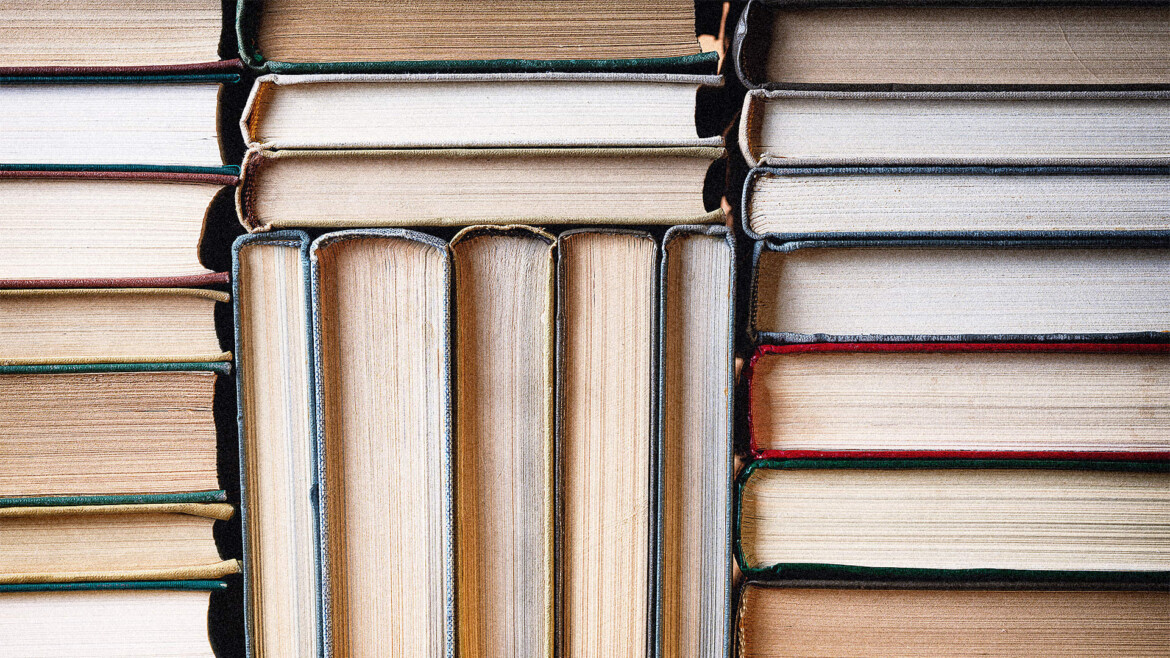Un quartiere torinese, quello di Pietra Alta, all’imbocco dell’autostrada che conduce a Milano: composto di palazzine a quattro piani costruite all’inizio del Novecento dai proprietari della vicina fabbrica di viscosa SNIA e dal cosiddetto Tossic Park, lambito dalla sponda del fiume Stura, occupato da tossici di vario genere per sgomberare i quali nel 2007 si richiede direttamente l’intervento dell’esercito. E un villaggio senegalese di botteghe, banchi al mercato, officine dove i maschi che hanno meno di diciott’anni crescono con il mito del calcio, della ricchezza, del successo oltremare. Che cosa hanno in comune due luoghi in apparenza distantissimi, la cui differenza risulta, a un primo sguardo, quasi ridondante, pleonastica? Nulla, se non che in entrambi convergono, in larga parte, le promesse disilluse di un presente storico privo di dialettica e di prospettive. È su questo filo teso tra dimensioni geografiche antitetiche eppure intrecciate che Paola Cereda ambienta L’unico finale possibile (Bollati Boringhieri, pp. 224, 18 euro): un ragazzo viene prelevato dal villaggio in cui vive con la madre e i sei fratelli da un uomo che si spaccia per il proprietario di un’accademia di calcio a Dakar, un mezzo per accedere alle squadre di calcio europee, ai grandi circuiti dei campionati.
E SI RIVELA INVECE un usuraio che costringe lui e altri a occupare temporaneamente una fatiscente baracca, a dormire per terra, a nutrirsi con due ciotole di riso al giorno e soprattutto a lavorare: smistando vetri dai metalli dentro un container. Un immaginario dickensiano, seppure ambientato in Africa, fondato sull’economia precaria, invisibile dello sfruttamento minorile, che rende il Senegal, al contrario di quanto ritenuto dalla comunità europea, un Paese rischioso e complesso dove, secondo i più recenti dati dell’Unicef, lavora quasi un bambino su dieci; senza considerare le frange sommerse, nascoste in cui finisce il protagonista del romanzo, per scappare dalle quali non resta che fuggire e accettare di sopravvivere per strada. Un paradossale racconto di formazione – o di deformazione, piuttosto? – alla Oliver Twist che lo vede a un certo punto essere caricato su un aereo diretto in Italia con l’illusoria promessa di un provino e poi a Torino, letteralmente abbandonato a se stesso, obbligato dalla fame a rubacchiare uno sfilatino di pane da un supermercato per essere poi braccato da una guardia, dagli spacciatori, da un gruppo di malviventi. E infine a chiedere asilo a una cooperativa d’accoglienza. Temporaneo ospite di una comunità allo scopo di non perdere il diritto ai documenti, viene preso in affidamento da una coppia di trentenni che abita in subaffitto e si arrabatta in mezzo a precarietà professionale, cronica insufficienza di denaro, sul sottile crinale dell’abbandono in cui versano le periferie delle ricche città del Nord del mondo.
QUELLO DI PAOLA CEREDA, già autrice di numerosi romanzi tra cui La figlia del ferro (Giulio Perrone Editore, 2022) è soprattutto il racconto di un’emigrazione nata da un fraintendimento; e di un tentato inserimento all’interno di una società in declino, del tutto incapace di fronteggiare le conseguenze di un viaggio che si spinge troppo al di là di sé. Simile in questo a Io capitano di Matteo Garrone: un’altra storia dove la terra che si lascia, che si vuole lasciare si rivela spesso più felice delle sorti catastrofiche a cui si va incontro per giungere in un’Europa fondata sul principio della mera sopravvivenza individuale, dove le iniziative sociali sono rimesse alla buona volontà dei singoli, delle cooperative, dei collettivi, dei centri d’accoglienza.