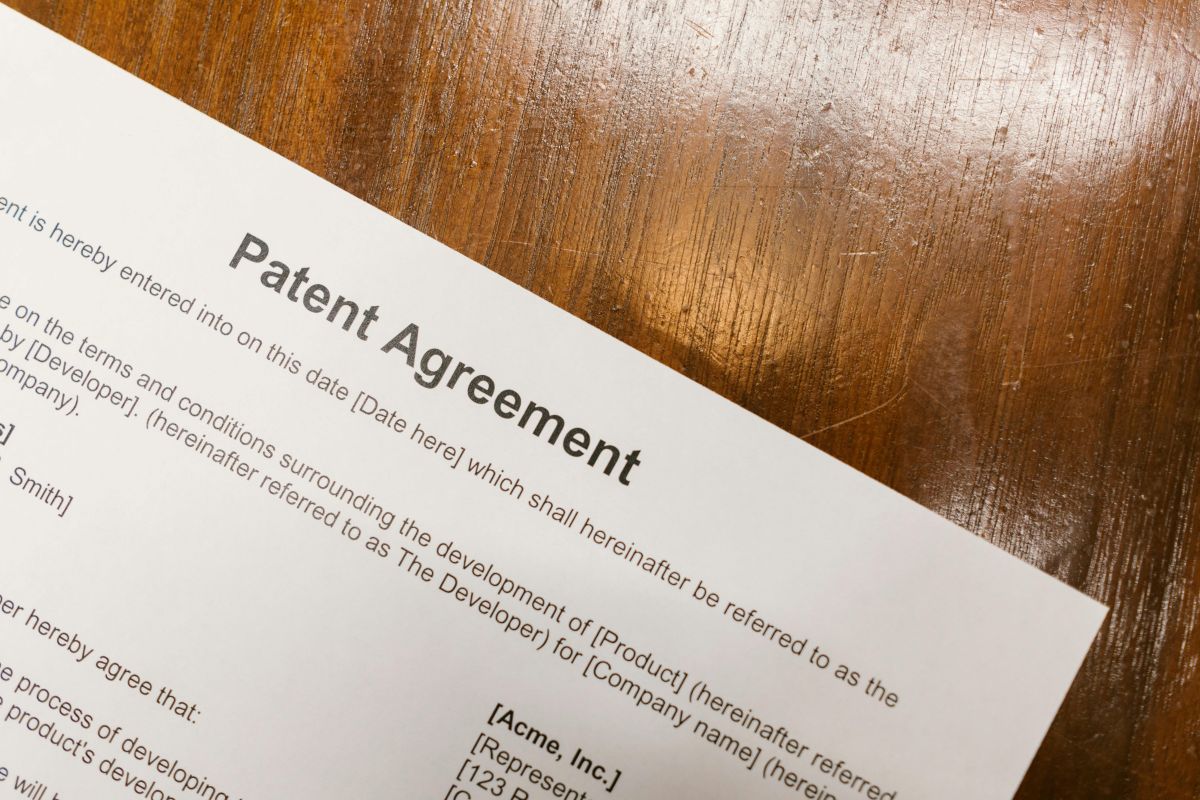L’analisi: università più attive e 12mila ricercatori con il Pnrr, ma dopo il 2026 rischiamo un vuoto. Svizzera e Svezia prime, Danimarca in volata. Serve trasformare ricerca in valore industriale.
(Foto: La documentazione per ottenere il brevetto in sede europea).
L’istantanea è netta: l’Italia resta nella parte bassa della classifica europea dei brevetti rapportati alla popolazione. In parallelo, crescono i depositi totali ma non chiudiamo il divario con i Paesi guida. Svizzera e Svezia continuano a macinare primati per domanda di brevetti rispetto agli abitanti, mentre la Danimarca si sta ritagliando un ruolo da outsider di lusso. Da noi il motore tradizionale tiene: meccanica, trasporti, ingegneria industriale.
Cosa dicono i numeri
Il valore c’è ma non basta: il portafoglio brevettuale italiano cresce, ma la spinta non si traduce ancora in leadership nelle aree che guidano la trasformazione industriale globale. È qui che si crea più valore, attrai capitali e costruisci filiere.
Dov’è la zavorra: digitale, biotech, ia
Digitale, biotecnologie, intelligenza artificiale: rispetto alla corsa mondiale, la nostra quota non accelera. Il risultato è una minore presenza nei mercati più dinamici e una dipendenza tecnologica crescente quando le grandi imprese trasferiscono all’estero ricerca e diritti IP.
Pnrr: avanzano assunzioni, non la sostenibilità
Segnali positivi: oltre 12mila nuovi ricercatori, bandi a cascata che hanno portato risorse alle imprese, reti tra atenei e industrie. Ma meno della metà dei fondi per il trasferimento tecnologico è stata effettivamente spesa e non esiste ancora una dote stabile post-2026. Il rischio è chiaro: spegnere il motore quando inizia a girare.
Chi innova davvero: poli accademici e centri
Università e centri pubblici di ricerca sono più presenti nella brevettazione. Il Politecnico di Milano guida la pattuglia accademica nelle registrazioni all’estero; Cnr e gli atenei di Bari, Bologna e Sapienza consolidano pipeline e risultati. Quando l’ateneo diventa piattaforma per l’impresa, il moltiplicatore locale aumenta: licenze, spin-off, occupazione qualificata.
La voce del Cnr
“L’innovazione non può restare una parola a effetto: va trasformata in trasferimento tecnologico, in prodotti, processi e servizi che arrivano sul mercato” — Andrea Lenzi (presidente Consiglio nazionale delle ricerche, Cnr).
Le mosse che servono adesso
Spostare incentivi sulle tecnologie abilitanti (IA, semiconduttori, life-science, robotica) e non solo sui settori maturi.
Stabilizzare i percorsi: tenure-track e percorsi industriali per trattenere talenti e ridurre l’esodo.
Raddoppiare il tech transfer: uffici brevetti con budget e competenze, fondi di proof-of-concept, co-investimenti pubblico-privati seed.
Mercato domestico come palestra: appalti innovativi, sandbox regolatori, standard aperti.
Dati e metriche pubbliche su tempi di brevettazione, licenze, spin-off e costi di transazione; benchmark europei trimestrali.
Il punto
Non è una crisi di talento, è una sfida di esecuzione. Senza continuità finanziaria e semplificazione della governance, il gap con i leader si allargherà. Con una correzione di rotta immediata, invece, possiamo trasformare lo scatto episodico in una vera traiettoria di leadership.