La frenata è uno dei tratti distintivi dello stile di guida di un pilota, le cui preferenze influenzano le scelte progettuali. La realizzazione dell’impianto frenante non è da meno, agendo sulla rigidezza del pedale e sulle caratteristiche del materiale d’attrito per restituire a chi guida le sensazioni desiderate. La risposta dell’auto in frenata però dipende anche da tanti altri fattori, rendendo il compito ancor più complicato. A spiegarlo ci pensa Andrea Algeri, responsabile clienti F1 per Brembo Racing, nella seconda parte dell’intervista concessa a FormulaPassion.
La risposta al pedale
Algeri spiega come siano essenzialmente due le sensazioni trasmesse al pilota strettamente dipendenti dai freni: “La prima è la rigidezza del pedale, che è data dal progetto dell’impianto, quindi dalla rigidezza delle linee freno, delle pinze e del materiale d’attrito, ossia il carbonio stesso. Si tratta di un parametro che varia a seconda delle geometrie e in base al se i componenti siano più o meno ventilati. Dalla rigidezza del pedale dipende la sua corsa quando il pilota lo aziona e questo è un primo feedback per chi guida”.
“Alcuni piloti prediligono una corsa maggiore che li aiuti nella modulazione della frenata, mentre altri preferiscono una corsa ridotta, così che appena azionino il freno si raggiunga subito la massima pressione. Dipende molto dalla capacità di gestire una corsa corta. Questa teoricamente permette di raggiungere il massimo della pressione nel più breve tempo possibile, il che si traduce in prestazione. Se però fosse esageratamente corta, si farebbe fatica a modulare la forza frenante. Si scadrebbe nel classico effetto on-off, alzando e affondando il piede. Ogni pilota ha il suo compromesso tra rigidezza e corsa”.

L’importanza dei materiali
“L’altro feedback è la sensazione di decelerazione che arriva dall’impianto frenante, nel dettaglio dal materiale di attrito”, prosegue l’ingegnere di Brembo Racing. “Questo ha delle caratteristiche specifiche a seconda della mescola, ossia del tipo di pastiglia e di disco impiegati. Tra fornitori diversi, ovviamente, abbiamo caratteristiche di attrito differenti, nel senso che quando il pilota applica una pressione al pedale, ne deriva una certa temperatura per via dell’attrito tra pastiglia e disco. La sensazione di decelerazione, quindi, può essere diversa a seconda delle condizioni di temperatura e del tipo di materiale. Ad esempio, applicando 100 bar di pressione, con due materiali si avrebbero due risposte diverse”.
Insieme, la rigidezza al pedale e le caratteristiche del materiale di attrito, determinano quanto un impianto sia pronto e reattivo o piuttosto dolce e modulabile. “Il materiale Brembo in genere è molto buono anche alle basse temperature”, spiega Algeri. “Diciamo quindi che ha un vantaggio di prontezza rispetto alla concorrenza, nel senso che anche in condizioni più fredde, come con la pioggia, garantisce già un buon attrito rispetto ad altri materiali che invece hanno bisogno di sviluppare pressioni e temperature più elevate per dare il massimo della prestazione”.
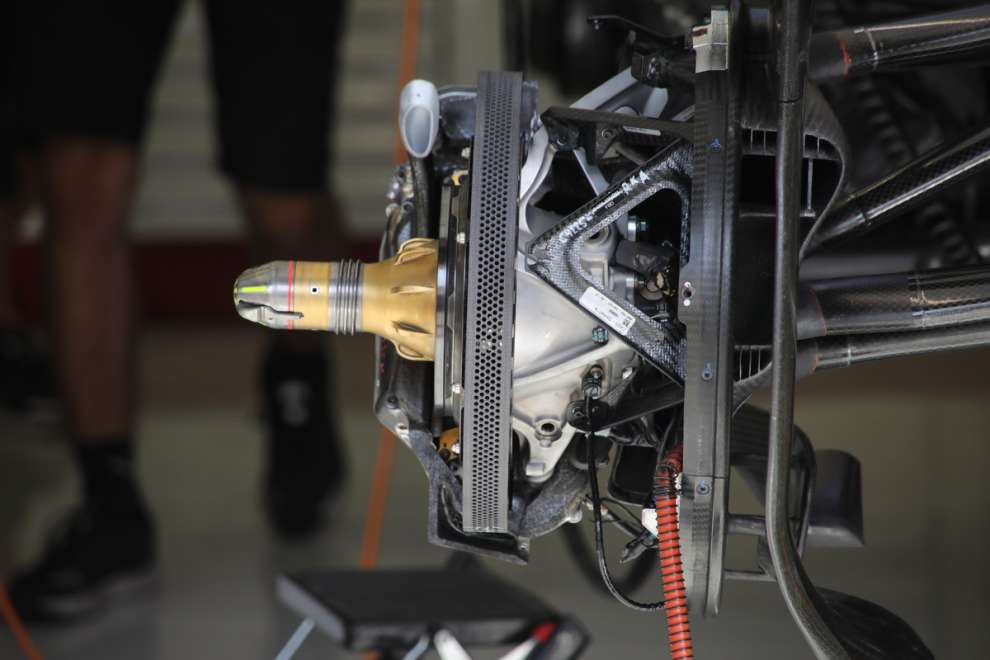
Le fasi di frenata
Il tutto si traduce in un determinato comportamento dell’impianto durante la singola staccata, una delle cui caratteristiche principali è la velocità di raggiungimento del cosiddetto bite. Prosegue Algeri: “Nell’arco di una frenata si ha l’evoluzione di quello che viene chiamato bite, ossia il massimo attrito che si raggiunge alla pressione più elevata. Durante la modulazione poi, l’attrito scende leggermente e questo aiuta il pilota a rilasciare il freno più tardi, prolungando la frenata fin dentro la curva. Sono degli equilibri abbastanza delicati”.
“È sempre una questione di compromessi, non si possono avere le massime prestazioni in tutti i momenti della frenata. Non si può raggiungere il bite alla massima pressione e poi avere lo stesso tipo di attrito anche a pressioni più basse. Bisogna trovare il giusto compromesso tra le varie fasi della frenata e questo lo si fa modificando dei parametri durante il processo produttivo del carbonio. È una scelta progettuale che si fa favorendo un certo tipo di caratteristiche a discapito di altre, andando a inseguire un po’ le preferenze dei piloti”.

Lo studio al simulatore
Come sottolinea l’ingegnere di Brembo Racing, durante lo sviluppo dell’impianto si tengono in considerazione le richieste del pilota, come per qualsiasi altra area dell’auto: “Il nostro lavoro è fornire qualcosa che secondo il nostro punto di vista garantisca la massima prestazione. Ovviamente sappiamo che i piloti e le macchine non sono tutti uguali, quindi cerchiamo di sviluppare il nostro materiale seguendo un po’ le richieste delle squadre, ma anche lasciando ai team libertà di scelta tra le opzioni che offriamo. Noi mettiamo sul tavolo un certo numero di alternative, con il pilota e/o la squadra che scelgono quella che più fa al caso loro. Da un lato quindi c’è un’evoluzione costante per migliorare e seguire lo sviluppo delle vetture, ma abbiamo anche più opzioni per condizioni, piloti e stili di guida diversi”.
Come per ogni area dell’auto, le soluzioni vengono prima valutate in ambiente virtuale, anche se nulla batte il riscontro della pista: “Il simulatore è molto utile da questo punto di vista, perché si possono simulare idealmente le massime prestazioni che il freno teoricamente dovrebbe garantire. Ovviamente poi bisogna tradurre una prestazione teorica in qualcosa che possa effettivamente verificarsi nella pratica. È una questione di correlazione, ma anche di compromesso. Al simulatore puoi dare in input un freno con una caratteristica molto buona ad alta o a bassa pressione, ma poi nella realtà ottieni o l’uno o l’altro dei due materiali, un compromesso. Il simulatore può dare una guida, ma non è sempre possibile ottenere il risultato desiderato”.
 Photo by ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images
Photo by ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images
Gli altri fattori
Andrea Algeri comunque ribadisce un concetto importante, ossia che le prestazioni in staccata di un’auto non dipendono esclusivamente dall’impianto frenante: “Nello scaricare a terra un certo tipo di decelerazione intervengono anche la gomma, l’aerodinamica e l’assetto della macchina a livello di sospensioni. La sensazione di decelerazione e la risposta a una certa pressione applicata passano da tutti questi componenti e non soltanto dall’impianto frenante. Banalmente, spesso in prova libera ci viene riportato che il bite non è quello desiderato, ma semplicemente perché la pista è ancora molto sporca. Man mano che si gomma poi, le sensazioni migliorano pur senza cambiare assolutamente nulla dell’impianto”.
Da qui l’importanza di contestualizzare le lamentele via radio dei piloti sul comportamento della macchina in frenata: “Quando noi sentiamo questo tipo di comunicazioni radio drizziamo sempre le antenne, perché ovviamente potrebbero riguardare un componente di nostra fornitura. Tuttavia, c’è anche altro che contribuisce alla frenata. Non è inusuale che dopo un team radio si faccia una verifica dei dati insieme alla squadra che poi ci dice che non dipende da noi, ma da una loro modifica all’assetto”.
 Photo Chandan Khanna/AFP via Getty Images
Photo Chandan Khanna/AFP via Getty Images
“La cosa più difficile è individuare un problema quando non è chiaro dai dati. Magari il pilota ha delle sensazioni che contrastano con i numeri, che invece non mostrano nulla. In quei casi si può andare a ritestare il materiale in un’altra sessione oppure verificarlo al banco, ma a quel punto verrebbe tolto dai componenti utilizzabili dal team per gli eventi successivi”. Conclude l’ingegner Algeri: “Non è automatico che una lamentela del pilota via radio corrisponda poi a un effettivo problema sui nostri componenti. La maggior parte delle volte, fortunatamente, non è così”.
