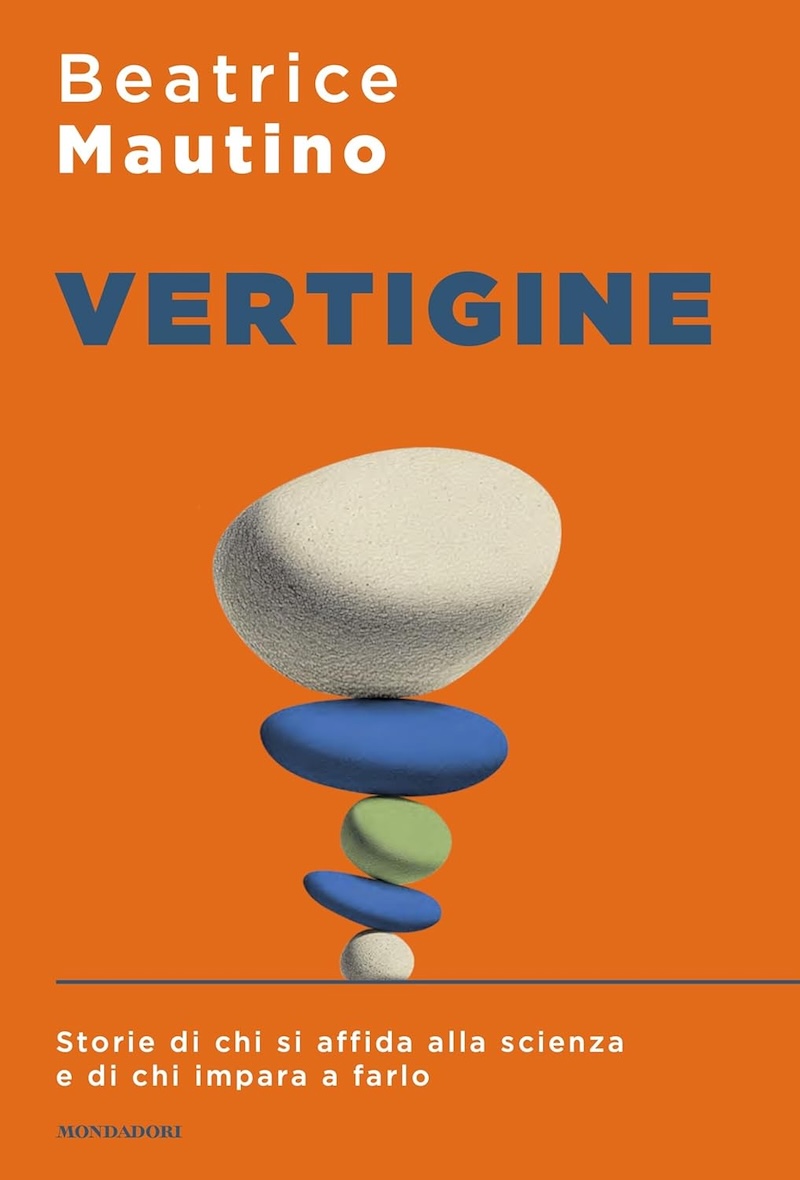Quando si riceve una diagnosi per una malattia difficile da trattare o per la quale non ci sono cure, non è sempre semplice affidarsi con convinzione alla scienza e averne fiducia. Beatrice Mautino – divulgatrice, biotecnologa e autrice con Emanuele Menietti del podcast del Post Ci vuole una scienza – lo racconta nel suo nuovo libro Vertigine, esplorando i molti casi in cui cambia il modo di percepire la ricerca scientifica: da argomento lontano, talvolta puramente teorico, a una pratica molto concreta e vicina dalla quale può dipendere la nostra sopravvivenza.
In Vertigine, Mautino intervista la prima persona nata grazie alla fecondazione in vitro, mostra le implicazioni nel concreto dei nuovi farmaci contro l’obesità e racconta uno dei centri più importanti al mondo per la terapia genica, in Italia. Parlando anche delle proprie esperienze personali e di una malattia che ha segnato la sua famiglia, mostra le opportunità offerte dalla ricerca e la spietatezza di alcuni suoi meccanismi, ricordando che la scienza cambia attraverso il metodo scientifico e non con la promessa di cure miracolose come avvenne per esempio alcuni anni fa col caso Stamina. Domenica 21 settembre alle 16, al Talk del Post a Faenza, Mautino parlerà del suo libro intervistata da Emanuele Menietti.
***
Il 21 dicembre 2020 l’Agenzia europea per i medicinali ha approvato l’utilizzo del primo vaccino contro il Sars-Cov-2, il primo a mRNA della storia, prodotto in tempi impensabili fino a poco prima grazie a uno sforzo economico e politico senza precedenti e, paradossalmente, proprio per questo al centro di paure e molta disinformazione che circolano tuttora. Ma quel giorno è stato autorizzato anche un altro farmaco, il Libmeldy, una terapia genica messa a punto dal gruppo dell’SR-Tiget per la cura di una malattia terribile, la leucodistrofia metacromatica. Questa malattia è fra quelle che Davide Vannoni diceva di poter curare con Stamina, attirando genitori che, all’epoca, non avevano ancora nessuna possibilità di cura.
«Una delle cose più difficili del nostro lavoro è dire a un genitore che non c’è soluzione per la malattia di suo figlio» scriveva sul «Corriere della Sera» nel marzo 2013 Luigi Naldini, che una soluzione per quella malattia la stava cercando. «Davanti all’incredulità di padri e madri, la tentazione di provarle tutte è forte: in quel momento scompaiono convegni, pubblicazioni scientifiche, si vorrebbe una bacchetta magica.» Ma, continuava Naldini, «non si può provare il tutto per tutto perché tanto non c’è altro da fare: la loro vita vale sempre e il tempo che rimane è prezioso». Per questo servono regole che «possono apparire fredde, ma che ci sforziamo di rispettare per tutelare i pazienti». Quelle parole mi sono rimaste impresse e le ho citate molte volte negli incontri pubblici in cui, in qualche modo, si finiva a parlare di Stamina, come esempio di rigore e di rispetto per i pazienti, ma le ho capite davvero solo frequentando l’SR-Tiget.
È proprio partendo da questa apparente contraddizione tra il rispetto per le regole e la spinta a trovare una cura, che ho cercato di capire come si possa convivere ogni giorno con questa spietatezza. «Come la gestite voi? Proprio umanamente» chiedo ad Alessandro Aiuti, perché è facile impostare un esperimento con tutti i crismi quando hai a che fare coi neutrini, è meno facile se l’esperimento lo devi fare con i bambini. «Non è facile» mi risponde, spiegandomi che proprio nelle settimane precedenti hanno dovuto comunicare a una famiglia che il loro bambino era finito nel cosiddetto «braccio di controllo», quella porzione di pazienti che, durante uno studio clinico, non riceve il trattamento da testare. «Per fortuna, per il tipo di terapie che facciamo qui,» mi spiega «non abbiamo il controllo con il placebo, quindi anche i pazienti che finiscono nel braccio di controllo ricevono quello che viene chiamato standard of care cioè la cura più efficace fino a quel momento». Però, continua Aiuti, «questo è giusto se la terapia da testare è completamente ignota, ma noi sappiamo già che la nostra terapia funziona meglio dello standard of care. Abbiamo già fatto altri studi in precedenza e abbiamo già i dati sullo standard of care». Mi racconta che questo approccio spietato è richiesto dagli enti regolatori e ha l’obiettivo di proteggere i pazienti. «Ci sono due elementi che credo di poter dire che ci guidano.» Il primo è «la consapevolezza che i dati raccolti serviranno per il futuro e tanto più ci si comporta in maniera corretta e rigorosa, tanto più l’obiettivo finale sarà raggiunto». Il secondo è che «stare nelle regole non è facile, ma possiamo provare a cambiarle».
L’esempio più emblematico di cosa significhi «provare a cambiarle» arriva proprio da Luigi Naldini, e riguarda la stessa malattia di cui parlava in quell’articolo sul «Corriere della Sera». «Con la terapia genica per la leucodistrofia metacromatica abbiamo sfidato il sistema» racconta Naldini. La prassi regolatoria tradizionale avrebbe richiesto di testare la terapia con bambini che avessero già i sintomi, ma Naldini e il suo team si trovarono di fronte a un dilemma etico e scientifico atroce. Sapevano, dagli studi preclinici, che la terapia avrebbe potuto fermare la malattia, ma temevano che negli stadi più avanzati non avrebbe fatto altro che prolungare le loro sofferenze senza apportare miglioramenti. «Non ci dormivo la notte» mi dice e non fatico a credergli. La soluzione che hanno proposto agli enti regolatori è stata tanto audace quanto complessa: anticipare la terapia, somministrandola a bambini che avevano già la diagnosi genetica ma non avevano ancora manifestato i sintomi della malattia. Significava trattare un bambino apparentemente sano, una decisione che, come ammette Naldini, «eticamente non stava quasi in piedi», perché si chiedeva a un genitore di acconsentire a una sperimentazione rischiosa per un figlio che, in quel momento, sembrava stare bene.
Riuscirono però a convincere l’Agenzia europea per i medicinali e avviarono gli studi trattando bambini molto piccoli che non avevano ancora manifestato i sintomi, ma che avevano ricevuto la diagnosi genetica perché fratelli minori di bambini con la malattia. I risultati dello studio furono sorprendenti. La terapia genica funzionava e, di fatto, bloccava la malattia prima che potesse manifestarsi. «Quando poi,» continua Naldini «osservando i risultati in un piccolo gruppo di bambini più grandi, che manifestavano già i sintomi della malattia, abbiamo visto che la terapia genica ha avuto un impatto minore o, nei casi che stavano progredendo rapidamente, nessun effetto.»
La conclusione di Naldini è lapidaria e rivela la posta in gioco: «Quindi se noi avessimo seguito la strada, diciamo, tradizionale, quella che il sistema consolidato raccomandava e avessimo effettuato la terapia genica con i bambini già sintomatici, avremmo dovuto concludere che non funzionava». Invece funzionava. Solo che per scoprirlo era necessario sfidare il sistema. Ma se si vogliono avere dei risultati che abbiano davvero un valore, la sfida al sistema deve essere fatta «standoci dentro, seguendo le regole e provando a modificarle sulla base dei dati e della conoscenza scientifica costruita nel tempo. Dobbiamo tracciare strade nuove, ma possiamo farlo davvero solo se lo facciamo con serietà e credibilità».
È un messaggio potentissimo, che ci racconta che l’avventura della conoscenza è fatta di esplorazioni e sconfinamenti in territori ignoti. Ma per far sì che quello che si scopre sia utile, è necessario procedere con serietà e rispetto, perché la vita dei pazienti «vale sempre e il tempo che rimane è prezioso».
© 2025, Mondadori