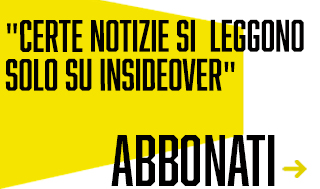Questa è la seconda puntata (di due) di un’analisi della situazione sul campo e dei risultati della guerra derivata dall’invasione russa del 2022. La prima puntata qui.
Due giorni fa, in una precedente puntata, abbiamo provato a spiegare perché quella in Ucraina, più che dalla vittoria di Kiev o di Mosca, è una guerra segnata dalle “non vittorie” dell’una con dell’altra. Dell’Ucraina abbiamo segnalato la più profonda delle “non vittorie”: non aver potuto impedire alla Russia di trasformare una guerra di movimento in una guerra di logoramento, che ha provocato le tre grandi emergenze ucraine attuali: il logorio territoriale, quello demografico e quello finanziario (dei partner). Questa volta proviamo a esaminare quella che, secondo noi, è la principale “non vittoria” della Russia sul piano strategico. Sul piano tattico, lo abbiamo detto nella prima puntata, la più evidente “non vittoria” è stata la mancata conquista di Odessa, che ha impedito la realizzazione del progetto Novorossija.
L’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio del 2022 non ha nulla a che vedere con il presunto imperialismo innato nella cultura politica russa o le altre farneticazioni con cui la politica e la cultura occidentale, comprensibilmente, hanno cercato di garantirsi il consenso ai sacrifici che il confronto con la Russia ha comportato. L’invasione e la guerra sono arrivate in coda a un processo degenerativo delle relazioni tra l’Occidente a guida Usa e la Russia durato molti anni e che, non volendo riesumare la famosa e mai chiarita questione delle presunte “promesse” fatte a Michail Gorbaciov all’epoca della caduta del Muro di Berlino (ovvero: la Nato non avanzerà verso Est “nemmeno di un centimetro”), ha un punto di svolta negli anni 2007-2008.
Nel 2007 Vladmir Putin, alla Conferenza internazionale sulla sicurezza di Monaco, ammoniva i vari Merkel e Hollande dell’indisponibilità della Russia ad accettare un mondo unipolare a guida americana. Nel 2008 l’amministrazione Obama firma un accordo con la Polonia per dispiegare in territorio polacco missili intercettori e un altro accordo con la Repubblica Ceca per un impianto radar-antimissile. Iniziative che cambiavano l’equilibrio di sicurezza in Europa, anche se Obama cercava di giustificarle come una difesa contro l’Iran (!!!), e che come tali furono prese al Cremlino. Nel luglio di quell’anno il ministero della Difesa russo emanava un comunicato per dire che “se l’accordo (con la Repubblica Ceca, n.d.r.) sarà ratificato saremo costretti a reagire non con mezzi diplomatici ma con strumenti tecnico-militari”. Prima mossa: il dispiegamento di missili Iskander a Kaliningrad. Seconda mossa: la guerra contro la Georgia di Mikhail Saakashvili, che annunciava l’intenzione di portare il suo Paese nella Nato e nella Ue.
Vuoi ricevere le nostre newsletter?
Il 5 novembre del 2008 Dmitrij Medvedev, nel suo primo discorso da presidente della Federazione Russa, disse: “Da quello che abbiamo visto negli ultimi anni, la creazione di un sistema anti-missile, l’accerchiamento della Russia con basi militari, l’incessante espansionismo della Nato, abbiamo tratto la chiara impressione che stiano mettendo. alla prova la nostra forza”.
E diciotto anni dopo….
E poi sappiamo quello che è successo. Nel 2016 Obama inaugura in Romania la base dotata di lanciamissili Mark 41 “Aegis”, sistema difensivo ma anche offensivo, capace di lanciare missili Tomahawk con testate nucleari e raggiungere Mosca. Nel 2014 l’Euromaidan in Ucraina, l’occupazione della Crimea da parte dei russi, la rivolta filorussa degli indipendentisti di Donetsk e Lugansk, la guerra nel Donbass e infine l’invasione. Non era prevedibile che tutto questo diventasse una guerra. E nulla di tutto questo giustifica chi ha acceso una guerra che drammaticamente scivola verso il quarto anno. Ma anche questa guerra ha una storia, non è certo frutto dell’impulso di un momento.
Una lunga introduzione che in realtà è un argomento. Perché la più grande “non vittoria” della Russia sta proprio in questo: la guerra (prima nel Donbass, poi in Ucraina) non è riuscita a cambiare la situazione rispetto a ciò che Putin vedeva crescere già nel 2007 e che denunciava alla Conferenza internazionale di Monaco. In altre parole il Cremlino non sembra più vicino a ottenere un diverso e più favorevole assetto di sicurezza in Europa di quanto lo fosse diciotto anni fa. Ed è proprio per questo che il tentativo di trattativa impostato da Trump sta abortendo: perché è arrivato al nocciolo politico della questione e non sa come affrontarlo.
Il lavoro di Petro Poroshenko
Ormai sappiamo ciò che, più o meno, chiede la Russia per arrivare a una tregua in Ucraina. Tutto il Donbass (la regione di Lugansk è tutta sotto il controllo di Mosca, quella di Donetsk tra il 75 e l’80%) e la Crimea, per quanto riguarda i territori. Ma soprattutto, e si torna appunto a quei diciott’anni, che l’Ucraina stia fuori dalla Nato (della Ue al Cremlino importa poco) e riduca il proprio esercito a una forza quasi simbolica. Da non trascurare, in connessione con quest’ultime condizioni, la richiesta di avere il russo come seconda lingua nel Paese e piena libertà di azione per la Chiesa ortodossa russa -Patriarcato di Mosca, due elementi considerati fondamentali per poter esercitare una certo soft power, almeno dal punto di vista culturale.
Che l’Ucraina, alla fine di qualunque percorso, stia fuori dalla Nato è altamente probabile. Agli Usa di Trump va bene così, l’hanno detto e ridetto. La Nato dice il contrario ma fa poco per tramutare in realtà il desiderio di Kiev. E all’interno dell’Alleanza Atlantica non sono pochissimi i Paesi che nutrono più di una preoccupazione all’idea che il famoso Articolo 5 della Nato («un attacco armato contro uno o più» Paesi dell’Alleanza «sarà considerato come un attacco diretto contro tutti»), quindi l’impegno a farsi coinvolgere in un conflitto, possa domani dipendere dalle bizze di qualche super-nazionalista di Kiev (o di qualche falco anti-kieviano di Mosca). Preoccupazione nutrita anche con l’interpretazione italiana, che prevede l’Ucraina fuori dalla Nato ma protetta dall’Articolo 5 come se ne fosse membra.
Nella Nato o con la Nato poco importa
Però quale sarebbe la differenza? Nessuno a Mosca è così ingenuo da credere che la Nato, domani, non sarà decisiva per gli assetti di sicurezza dell’Ucraina. Dentro o fuori che questa sia dall’Alleanza. Anche in questo caso, siamo in coda a un lungo processo. Già Petro Poroshenko, pochi mesi dopo l’elezione a presidente del giugno 2014, fece aprire a Kiev una sede diplomatica della Nato. Fu lui nel 2019, a inserire nella Costituzione ucraina l’obiettivo di entrare nella Nato. E fu lui, durante la sua presidenza, a investire il 6% del Pil (l’Ucraina era allora con la Moldavia il Paese più povero d’Europa) per rafforzare le forze armate del Paese e, soprattutto, renderle interoperabili con le forze Nato. È stata la preparazione di allora a rendere così fluida la collaborazione tra le truppe ucraine e i “consiglieri” Nato dopo l’invasione russa e durante la guerra.
D’altra parte basta seguire le iniziative che il Governo di Kiev prende proprio nel settore della Difesa. Ne ha ben parlato in queste pagine Andrea Muratore. Gli accordi con il colosso degli armamenti tedesco Rheinmetall o il Brave 1, l’incubatore tecnologico nel settore della Difesa, con cui gli ucraini si propongono, in sostanza, di diventare gli sperimentatori dell’industria internazionale degli armamenti, la dicono lunga su quanto voglia essere stretto il rapporto anche futuro tra l’Ucraina e i suoi sponsor militari. Soprattutto se dovesse tenere la linea Trump, ovvero: gli Usa vendono le armi alla Nato o all’Europa e questi le “regalano” all’Ucraina. Che qualcosa, prima o poi, dovrà pur fare per contraccambiare. O no?
E dunque la “non vittoria” russa appare piuttosto evidente. Dentro o fuori della Nato, l’Ucraina resterà comunque un “Paese Nato”. Armato, legato da un cordone ombelicale all’industria della Difesa occidentale, protetto dalla rete di intelligence occidentale (Starlink non è Nato, no?) e facilmente riarmabile in caso di ulteriori complicazioni. In più, l’Ucraina ha una qualità che gli europei, siano tedeschi o inglesi, italiani o lituani, devono ancora dimostrare: se costretta, ha voglia di combattere.
(2.fine)
Noi di InsideOver ci mettiamo cuore, esperienza e curiosità per raccontare un mondo complesso e in continua evoluzione. Per farlo al meglio, però, abbiamo bisogno di te: dei tuoi suggerimenti, delle tue idee e del tuo supporto. Unisciti a noi, abbonati oggi!