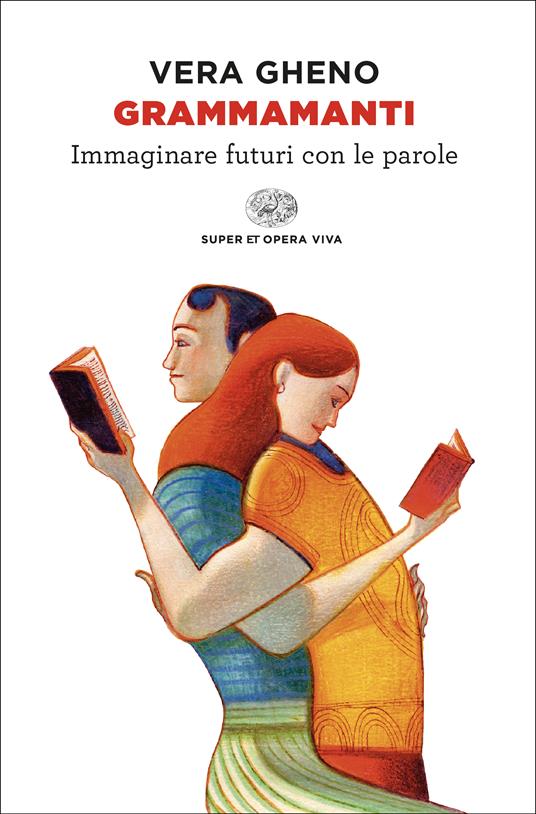23/09/25
Parole chiave: Conoscenza, Amore, Autobiografia linguistica, Carità interpretativa
Titolo: Grammamanti. Immaginari futuri con le parole
Autrice: Vera Gheno
Recensione di Patrizia Santinon
Dati sul libro: 2024, Giulio Einaudi Editore, Torino
Ho ricevuto in dono il libro di Vera Gheno dall’amica Monica Deevasis con una precisa dedica: “A te che aprirai lo scrigno delle parole”.
Monica aveva creato un premio di saggistica femminile, il premio Giuditta, che trasferitosi da Alessandria a Lesa ne aveva preso il nome rinunciando al suo primo, a proposito di deadname.
Vera Gheno ha vinto nel giugno 2025 la seconda edizione con Grammamanti.
L’autrice, sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca e oggi insegna all’Università di Firenze. Ci aiuta a riflettere come linguista su ciò che è normale – cioè su ciò che crea la norma e insieme corrisponde alla norma – e come attivista su ciò che tutto questo voglia dire con un’attenzione specifica al linguaggio così detto ampio più che inclusivo, qualificativo che ha come implicito l’inclusione tra i così detti “normali” dei “diversi”. Ci insegna nel suo ultimo testo ad amare la lingua, lasciando libera di mutare. Una modalità samaritana di accostamento all’altro che appartiene anche al nostro mestiere di facilitatori di cambiamento, nella convivenza delle differenze e nel superamento delle diffidenze, capaci di lasciare andare i nostri pazienti perché siano liberi di investire creativamente e soggettivamente il rapporto con la realtà, avviato il lutto della relazione analitica idealizzata.
Vera Gheno, protagonista del capitolo “La quarta storia d’amore: Io” in cui viene svelato il viaggio dell’autrice per diventare “grammamante” ci racconta molto bene come “la capacità di comunicare tramite le parole è imputabile a una qualche forma d’amore. Per questo mi sono inventata la parola grammamante, che serve a descrivere chi ha, con le proprie parole, una vera e propria relazione amorosa” ( XIV).
Ci parla divertita della putting the baby down theory per raccontarci lanascita del linguaggio per cui “queste povere madri, ad un certo punto, quando non sono più in grado di reggere l’infante con un solo braccio, in modo di avere l’altro libero per sfaccendare, si devono adattare e posare i loro bebé a terra” (cercando di) “ mantenere con i figli un contatto vocale in modo da rassicurarli” (pag. 7).
Alla nascita la voce della madre è per il bambino il primo strumento esterno a sé che produce suono e che garantisce una continuità all’esperienza ritmica precedente fatta di ritmi cardiaci, intestinali, respiratori della madre in scambio con i propri. Il respiro stesso, come primo atto di assunzione autonoma di un proprio ritmo alla nascita, è inerente alla vita vegetativa ma ha anche un valore di relazione come ci insegna Francois Dolto (1984).
Questa prima simpatica teoria che l’autrice preferisce alle altre mi ricorda l’utilizzo della voce nell’intervento di canto in un gruppo di mamme con depressione post-partum alla presenza dei bebé che abbiamo creato come dispositivo di cura nel reparto di ginecologia dell’Ospedale in cui lavoro*.
La comunicazione della diade madre-bambino è in un primo tempo preverbale, affidata al suono e al timbro della voce, fondante per i successivi tentativi di comunicazione delle emozioni.
Vera ci ricorda che lavorare insieme crea un gergo lavorativo che rassicura nei termini di un’appartenenza: nella sua esperienza all’Accademia della Crusca come sociolinguista con altri colleghi si era strutturato un rituale di congedo il cui “buona intredim” (edima è un termine obsoleto che significa settimana, intredim dunque può essere inteso come periodo che sta tra due settimane lavorative), invece che “buon fine settimana”, indicava una intimità propria del gruppo.
Capirsi o no distingue gli amici dai nemici, come i Greci che, parlando la lingua comune della penisola ellenica, chiamavano gli altri Barbari.
Le parole che usiamo possono diventare un baluardo, una difesa più che un ponte. Per questo come psicoanalisti potremmo sviluppare una tensione a fare nostra, con i pazienti e con i colleghi, una comunicazione, oltre che puntuale, pontuale.
“L’origine della conoscenza è l’amore. L’obiettivo della conoscenza che scaturisce dalla vita è la riunificazione e la ricostruzione di sé spezzati e mondi in frantumi. La conoscenza che scaturisce dalla compassione non mira a sfruttare e manipolare la creazione, ma a riconciliare il mondo con sé stesso. La mente motivata dalla compassione tende a conoscere, come il cuore tende ad amare. Così l’atto del conoscere si fa atto d’amore” (bell hooks, 2022, p.170), ricordandoci molto bene la curiosità epistemofilica come tensione alla conoscenza e manifestazione di Eros di heideggeriana memoria.
La lingua è politica, ci ricorda l’autrice. Sia per il politicamente corretto, percepito come un eccesso di maniera per chi non ha mai vissuto una condizione di minoranza o esclusione o di violenza epistemica, sia perché il linguaggio mette in luce le categorie sulla cui formazione e educazione si vuole investire e quelle che si vuole escludere. Se non si hanno le parole non ci sono le competenze linguistiche per esercitare la democrazia e per conservarla. La cura delle parole è un atto di resistenza democratica.
Tullio de Mauro, in una critica al sistema scolastico italiano tradizionale che insegnava “come si deve dire una cosa”, sottolineava l’importanza di una scuola democratica in cui si metta l’accento su “come si può dire una cosa”, al di là della conoscenza delle regole che consentono l’accesso ai codici comunicativi dalla comunità dei parlanti. Ci ricorda come una cosa possiamo dirla “in greco, in piemontese, in siciliano (…) con una sintassi semplice, per giustapposizione di proposizioni, o con una sintassi contorta e subordinante (…) possiamo dirla tacendo, purché abbiamo veramente voglia di dirla e purché ce la lascino dire” (2018). Aggiungerei io: purché qualcuno ci ascolti.
Nel nostro mestiere il ritorno al corpo sonoro della parola ne esalta la capacità di presentificare qualcosa con l’intonazione, il ritmo, il volume e le variazioni dinamiche. Se si perde di vista il significato se ne riapre il potenziale evocativo.
Il silenzio, il respiro, il suono riempiono la seduta come comunicazioni riconducibili ad una sensorialità pre-simbolica e ad esperienze sinestesiche preliminari alla strutturazione del linguaggio: proprio in virtù della loro qualità insatura facilitano l’emersione dall’immediatezza percettiva del sensibile la traccia di un senso nascosto e nuovo.
“Mi piace pensare al linguaggio come a una carta geografica aperta, nella quale la parte nota è circondata da uno spazio uncharted, sconosciuto, non ancora mappata; in quella terra incognita possiamo incontrare ogni tipo di novità, arricchendo gli orizzonti linguistici e cognitivi”, scrive l’autrice (pag. 94).
Questo ci ricorda quanto il viaggio delle rappresentazioni mentali e culturali crei rappresentazioni culturali meticce che attendono “le parole per dirlo” con un linguaggio che diremmo “ampio” più che “inclusivo”, termine poco gradito all’autrice. Ciascuno ha il suo idioletto, cioè l’insieme delle caratteristiche linguistiche personali, come anche un proprio patrimonio sonoro, che si stratificano nel corso del viaggio identitario.
Vera racconta di essere stata incoraggiata a scrivere una sua propria autobiografia linguistica da una professoressa di sociolinguistica: mi ha ricordato l’autobiografia che dovremmo autorizzarci a scrivere per i nostri colloqui di candidati al training che è molto più di un cursus honorum o di un curriculum vitae e dunque è d’impaccio perché dice molto di noi attraverso le parole che scegliamo.
Quale lingua può creare ponti diventa l’interrogativo di Vera a partire dalla lettura giovanile di un libro di Alessandro Duranti, Etnografia del parlare quotidiano, in cui secondo l’autrice si insegna la cultura del rispetto e una tensione a scrivere in modo non performativo (per far capire che cosa posso insegnarti dal mio vertice di soggetto supposto sapere) ma generativo (per vedere se ciò che so può essere utile anche a te).
Questa modalità generativa ci ricorda il nostro lavoro di analisti in transito tra sé e l’altro alla ricerca di una possibile sintonizzazione con l’emozione sconosciuta del paziente (la sua O). Questa sintonizzazione con O sta alla base di ogni conoscenza che passa attraverso un esercizio di decentramento dal proprio pensiero cosciente disponendosi in una condizione di tolleranza e ricettività alle produzioni consce ed inconsce, corporee e psichiche, proprie e altrui.
Vera parla di una “carità interpretativa”, cioè una disposizione d’animo “accogliente, comprensiva nei confronti di chi abbiamo di fronte (abbracciando) la possibilità che la cosa che ci ha fatto innervosire non è altro che un semplice fraintendimento” (p 120).
Per Bion lo psicoanalista deve venire in contatto con le emozioni sconosciute, senza interferire con la mobilità della mente vivente con parole che non spiegano l’emozione, ma permettono al paziente di viverla e conoscerla.
Il dialogo psicoanalitico è in buona parte costruito come violazione della conversazione consueta: la regola fondamentale delle “libere associazioni” è una violazione metodica del principio della ridondanza percepita (secondo le così dette massime di Grice) e insieme un rifiuto della reticenza ma anche rispetto alla pertinenza: chi può stabilire, a priori, che cosa è pertinente e cosa non è pertinente?
Salus per verba, la salute passa anche attraverso le parole.
Riferimenti:
hooks b., Insegnare comunità. Una pedagogia della speranza, Meltemi, Milano 2022, p.170
De Mauro T., “Il plurilinguismo nella società e nella scuola italiana” in L’educazione linguistica democratica,Laterza, Bari, 1975, pp. 84
Dolto F., L’image incosciente du corp, Seuil, Paris, 1984
*· https://www.epicentro.iss.it/materno/depressione-post-partum-progetto-music-and-motherhood
L’obiettivo dell’intervento “Music and Motherhood” è quello di sostenere il benessere emotivo delle neomamme, contrastando i sintomi della depressione post partum con il canto di gruppo.