Corrado d’Elia, al contempo, ha qualcosa di Mangiafuoco e qualcosa di Don Chisciotte. Suo è il genio del terribile: quando gli parli, impalca castelli in aria così concreti che sei pronto a imbarcarti con lui verso un qualsiasi nessundove. È il talento di chi maneggia il fuoco come un burattino e rende feconda la cova dei mulini a vento. In fondo, ama il pensare transoceanico, d’Elia: per me – anche per le sue movenze da saltimbanco, da imbonitore di leoni, da infallibile equilibrista – è il Philippe Petit del teatro italiano contemporaneo.
Milanese, uscito dalla ‘Paolo Grassi’, Corrado d’Elia somma strategia e umore lunare. Nel 1995 fonda Teatri Possibili – che è poi un inseguire l’impossibile – che oggi si chiama Compagnia Corrado d’Elia; da tempo, in particolare, Corrado d’Elia indaga i personaggi, gli uomini che al posto di lasciare il cuore a maggese l’hanno messo a fruttificare velieri, visioni, varchi. Ha messo in scena – con acume da entomologo del meraviglioso – Mozart e Beethoven, Van Gogh e Steve Jobs. Ora sta inseguendo Macbeth; ha da poco dato voce a Galileo. Ama i grandi libri, Corrado d’Elia, i libri che infiammano fino a forgiare in spada e in capodoglio l’anima di chi li legge. Così, con spericolata indole, ha riscritto l’Iliade e Moby Dick, Don Chisciotte, Le notti bianche, Il piccolo principe. Ha l’energia dell’ispirato – cioè: di chi sa ispirare.
A volte, le sue sceneggiature prendono la via del libro. Io, Moby Dick (Ares, 2024) è forse il più affascinante; Galileo, oltre le stelle (Ares, 2025), l’ultimo, è un tentativo di sconfinamento dai greti di una grande anima. Quali sono i legami tra scienza e fede, tra parola e calcolo, tra opportunità e opportunismo, tra sé e cosmo? Galileo è allo zenit dell’uomo – Galileo è figura che ha in Amleto un emblema nel mondo letterario: entrambi fondano la modernità, che è poi il discorso sull’essere e sul non essere, sulla possibilità di esplorare gli impossibili. Amleto crea un microscopio interiore per sondare i miraggi e i deliri dell’anima; Galileo forgia un cannocchiale per auscultare i mugolii dell’universo.
“È carne che trema di fronte all’infinito”, dice Corrado d’Elia di Galileo. Il libro comincia con una finestra e finisce con una marmellata. Sulla soglia dell’abiura e dell’umiliazione, il sapiente parla di fragole, limoni e lamponi; “Nessuno ha visto più lontano di me”, sussurra. Gli astri sono i frutti maturi dei nostri occhi.
Corrado d’Elia scrive in versi. La sua scrittura, però, ha poco a che fare con il teatro ‘poetico’ (o neomelodico) – che siano le scritture vertiginose di Mario Luzi o gli spettacoli ‘di parola’ di Mariangela Gualtieri. L’andar per versi è utile, qui, a creare il ritmo narrativo esatto. I versi sono uno ‘strumento’: cembalo e cetra, tamburo e corno; sussurri e grida. Come i canti attorno al fuoco: e il fuoco, di volta in volta, si fa volto e muraglia. Un fuoco argilla, intendo, in cui le ombre hanno la beltà di un corpo, di un torsolo d’uomo – innamorano.
Beethoven, Van Gogh, Galileo, Mozart. Mi pare di capire che ti piacciono i grandi uomini, che confidi nel ‘terribile’ genio dell’uomo. È così? Perché?
La parola “genio” porta con sé un’ambiguità affascinante. Genio non significa solo capacità tecnica o talento straordinario: implica una tensione, un’inquietudine, una ferita. Beethoven, Van Gogh, Galileo, Mozart – e potrei aggiungere Steve Jobs, figura altrettanto contraddittoria e perturbante – sono stati uomini che hanno vissuto in una sorta di scarto rispetto al mondo comune. Hanno visto più lontano, hanno pagato sulla propria pelle il prezzo di quella visione, e per questo hanno toccato vertici che noi possiamo soltanto sfiorare. Incontrare il genio significa entrare in contatto con l’ebbrezza di una grandezza che non è mai pienamente accessibile. È come camminare sull’orlo di un abisso: non possiamo appropriarsene, ma possiamo lasciarci colpire da quella vertigine. Galileo, in particolare, rappresenta per me questa condizione: uomo di scienza, ma anche poeta della visione, capace di scardinare dogmi e di aprire nuove prospettive sul mondo, pur pagando il prezzo dell’isolamento e della condanna.
 Lui è Corrado d’Elia
Lui è Corrado d’Elia
Iliade, Moby Dick, Divina Commedia. Mi par di capire che ti piacciano le grandi opere. È così? Che senso ha, oggi, una vita ‘epica’, una grande opera?
I classici sono la nostra archè, il nostro conio originario. Non appartengono al passato, ma al futuro. Essi non cessano mai di parlarci, perché custodiscono domande che restano aperte. Omero, Dante, Joyce, Dostoevskij, Melville non ci consegnano risposte definitive, ma ci offrono la vertigine di interrogativi che ancora oggi ci parlano e ci fanno riflettere. In un’epoca che sembra aver smarrito i propri maestri e che spesso rifugge dalle grandi domande, parlare di “vita epica” significa restituire al presente il senso di un orizzonte più vasto. Non è questione di eroismo in senso tradizionale, ma di profondità: l’epica oggi è la capacità di vivere con consapevolezza, di cercare un senso che vada oltre il consumo immediato. Una grande opera, nel nostro tempo, è quella che invece riesce a interrogarci e a resistere al logorio dell’oblio e della dimenticanza.
Qual è il libro che ti ha folgorato da bambino? E quello che ti ha folgorato da adulto?
Da bambino mi hanno colpito libri che mi hanno insegnato a guardare il mondo con stupore. Non era tanto un titolo preciso, ma il gesto stesso del leggere che apriva mondi. Ogni pagina era una porta. Da adulto, invece, ricordo come folgorazione Moby Dick: non solo per la potenza narrativa, ma perché in quell’ossessione vedevo riflessa la nostra sete inesausta, la tensione verso l’impossibile. Melville, come Dante, come Galileo, ci mostra che la conoscenza è anche naufragio, che non si può inseguire la verità senza rischiare di perdersi. Non è un caso che il mio Io, Moby Dick, inizi con un uomo seduto sulle proprie sconfitte.
Galileo. Perché?
Galileo è un simbolo del nostro tempo. Non solo perché ha incarnato la rivoluzione del pensiero scientifico, ma perché ha vissuto sulla propria pelle il conflitto tra fede e ragione, tra libertà di ricerca e potere istituzionale. È un uomo del passato che parla al presente: la sua vicenda interroga ancora oggi il rapporto tra scienza e coscienza, tra visione e resistenza. Portarlo in scena significa restituirgli la sua duplice natura: l’uomo forte e convinto delle sue idee, ma anche l’essere fragile, intimo, spesso solo, che si misura con i limiti propri e del proprio tempo. Galileo è il paradigma dell’artista e dello scienziato: colui che guarda oltre e che, proprio per questo, paga un prezzo altissimo.
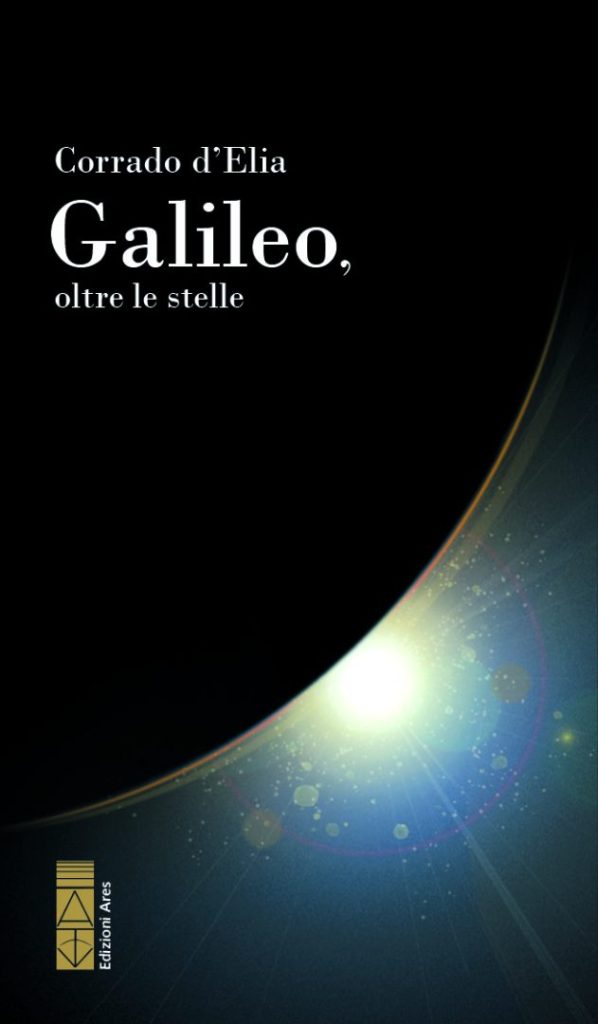
Come inizi a scrivere un testo, questa specie di biografia lirica, di monologare poetico? Da dove è iniziato Galileo?
La scrittura nasce sempre da una ferita, e quindi da un’urgenza. Non è mai un progetto meditato, ma piuttosto un incendio che divampa da una scintilla. Nel caso di Galileo, la scintilla è stata una conversazione con amici sul rapporto tra fede e scienza: un tema che, lungi dall’essere archiviato, resta bruciante e contemporaneo. Io scrivo ovunque: nei bar, negli aeroporti, sui treni, in camerino. La scrittura mi divora. Non è mai casuale la mia scelta di andare a capo: il verso è la forma naturale del mio pensiero. È un ritmo che segue il respiro. Galileo è nato proprio così: dal bisogno di dare voce a una tensione interiore, di unire la lirica al racconto, il pensiero alla carne viva del teatro.
Che rapporto c’è tra scrittura scenica e poetica?
Sono due forme sorelle. Entrambe vivono del togliere, dell’evocare più che del descrivere. La scrittura poetica genera immagini che vivono nella mente del lettore. La scrittura scenica deve invece incarnarsi subito, diventare visione immediata per lo spettatore. La differenza è nel tempo: la poesia si legge in solitudine, lentamente, e può essere riletta infinite volte. Il teatro vive nell’istante, chiede di catturare e trattenere un pubblico per un’ora o due, senza tregua. Ma in entrambi i casi si tratta di rendere visibile l’invisibile, di rivelare, di trasformare il silenzio in qualcos’altro.
Che senso ha l’arte in un mondo che rimanda soltanto orrore, morte?
L’arte è il braciere che deve restare acceso, anche quando tutto intorno è buio. Adorno nel ’49 scriveva che dopo Auschwitz fosse impossibile scrivere poesia, addirittura un atto di barbarie. Ma la poesia stessa ha dimostrato il contrario: proprio nell’abisso, la parola trova una ragione per esistere. Oggi più che mai l’arte è dunque resistenza. È atto politico, oltre che poetico. Non consola, ma tiene accesa una luce. Senza arte, senza cultura, senza educazione, la società resta prigioniera della violenza e dell’ignoranza. L’arte è la nostra forma di sopravvivenza.
Qual è la tua poesia del cuore?
È difficile dire. Probabilmente se devo scegliere, Forse il cuore di Salvatore Quasimodo, scritta nel 1947, nel dopoguerra, quando il mondo era allo stesso modo lacerato e le ferite sembravano insanabili. Si chiude con quei versi che non risuonano terribili nel dubbio: «forse il cuore ci resta, forse il cuore…». Io ci sento tutta la precarietà dell’umano, ma anche la sua possibilità. Ci offre una chiave che sta a noi prendere o rifiutare.
Qual è stato il personaggio più difficile da investigare?
Ogni personaggio porta con sé un abisso, ma se devo pensarne uno in particolare, cito il Caligola di Camus. Qui la caduta non ha appigli: è verticale, brutale, inesorabile. Camus non ci consegna solo l’immagine storica di un imperatore folle, ma ne fa un archetipo della condizione umana: un uomo che, perso l’amore e il senso delle cose, si spinge fino all’estremo, fino al capriccio assoluto, fino all’assurdo. La crudeltà di Caligola è profondamente umana. E tutto questo, questa frizione è terribile. Perché la puoi spiegare. La sua violenza non nasce da una ferita, da un lutto che si trasforma in ossessione metafisica: la ricerca di un’impossibile libertà assoluta. Nel suo delirio, Caligola non è lontano da noi: ci mostra che quando l’uomo smarrisce il senso, quando non accetta i limiti, quando non ha punti di riferimento, umani o spirituali può trasformarsi in mostro. È l’abisso del potere, ma anche l’abisso del vuoto interiore.
…e ora, quale nuovo uomo stai tenendo in agguato, vorresti agguantare?
Il prossimo incontro è con Macbeth, o meglio con la sua ombra. Non la tragedia shakespeariana in senso tradizionale, ma il suo incubo, il suo sogno più nero. Macbeth diventa per me un uomo intrappolato in un rito ancestrale, una vittima sacrificale in balia di qualcosa più grande di lui. Per questo, nel suo disorientamento è un uomo contemporaneo. Una dimensione rituale, alchemica, dove la parola si fa liturgia e il gesto invocazione. Uno spettacolo visionario a cui lo spettatore non assiste, ma attraversa.
**
Si pubblica per gentile concessione, l’attacco di “Galileo, oltre le stelle”, testo di Corrado d’Elia edito da Ares (2025).
Quando ero bambino,
come per istinto,
aprivo la finestra e guardavo il cielo.
Allora, tutte le volte,
lo stupore, il mistero,
per quel foglio immenso e nero,
mi avvolgeva.
Ogni stella era un enigma da decifrare,
ogni costellazione
una frase da indagare.
Cosa cercassi io non lo so,
ma già sentivo
che in quel vasto tacere,
in quel silenzio che sapeva di sapere,
un senso d’eterno c’era,
di assoluto,
un frammento di verità
che mi lasciava disorientato, incantato,
muto.
«Cosa siete, stelle?
E che cosa mi volete dire?
Siete solo lanterne accese nel buio
o una traccia da seguire?
L’universo è tanto vasto,
sembravate suggerire,
più di quello che pensi
più di quello che puoi capire
e la vita, la vita,
è un meraviglioso viaggio,
sempre in divenire».
E in quel parlare del cielo,
in quell’estasi in cui mi perdevo,
io leggevo una chiamata, un invito,
a esplorare
un disegno oltre il nostro,
un ordine nascosto
dietro quel velo d’infinito.
Così ogni notte lo facevo
e il cuore, guardando, piano piano si calmava.
La domanda ancora oggi è sempre la stessa:
che cos’è questo libro che mai si chiude?
Quest’oceano celeste sopra di noi
che ancora mi incanta
e mai mi delude?
Un’opera d’arte, certo, un capolavoro.
Un mistero.
Il riflesso dell’animo mio
inquieto.
L’eco di qualcosa
che ancora ci è segreto.
E davanti a voi, luminose stelle
la mia emozione si fa sempre meraviglia.
Un uomo così piccolo,
in mezzo alla sua grande famiglia.
