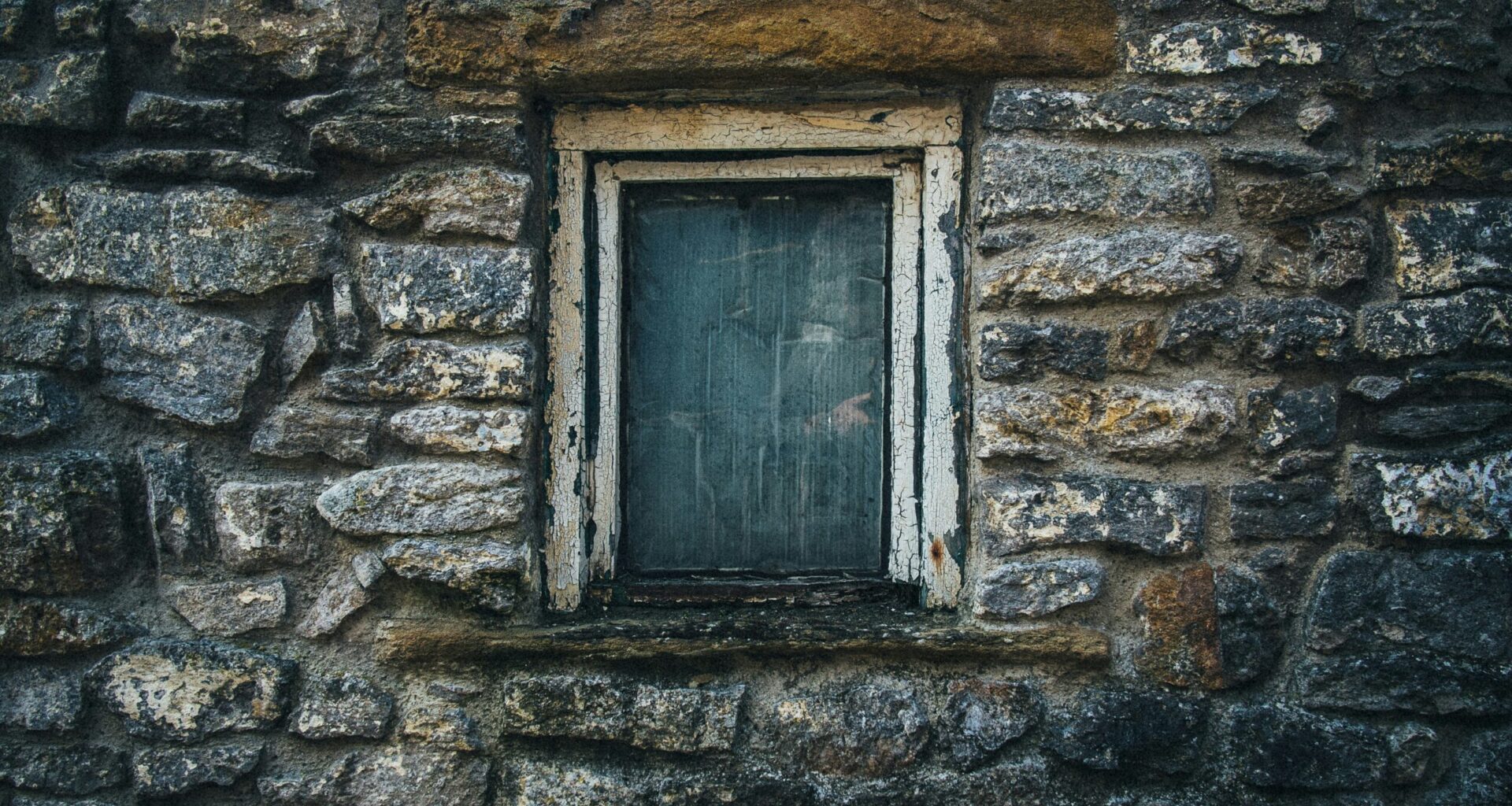Si racconta che Federico Guglielmo IV, re di Prussia, grande amatore della scienza, fosse solito chiedere al suo astronomo di corte: “Herr Argelander, c’è qualcosa di nuovo che accade nel cielo?”. E che un giorno l’astronomo, a corto di scoperte sensazionali da offrire al sovrano, rispose a sua volta con una domanda, tanto coraggiosa quanto profonda: “Sua Maestà conosce già tutte le vecchie cose?”. Questo l’interrogativo alla base di A spasso nella fisica moderna. Le idee e gli scienziati (Castelvecchi 2025), opera corale di Massimo Cencini, Andrea Puglisi, Davide Vergni e Angelo Vulpiani, esponenti di spicco della scuola romana di fisica e membri del gruppo di ricerca TNT: in un’epoca di divulgazione scientifica dominata dalla ricerca dell’“effetto wow”, gli autori hanno compiuto una scelta radicale e controcorrente, scegliendo deliberatamente di evitare i sentieri più battuti e spettacolari – buchi neri, stringhe, gatti di Schrödinger – per invitare il lettore in un viaggio ben più essenziale, un’esplorazione della fisica che governa il nostro mondo, quello più quotidiano, quello che Ennio Flaiano, in una folgorante battuta citata nel libro, definì “l’infinitamente medio”. Il libro è dunque non solo un testo di divulgazione, ma un vero e proprio manifesto metodologico, che tra le altre cose critica implicitamente un modello di comunicazione della scienza che privilegia la meraviglia momentanea a scapito della comprensione duratura: prima di guardare alle frontiere più estreme dell’universo, ci suggeriscono gli autori, dovremmo assicurarci di aver compreso le fondamenta su cui poggia la nostra realtà quotidiana.
 A spasso nella fisica moderna. Le idee e gli scienziati (Castelvecchi 2025)
A spasso nella fisica moderna. Le idee e gli scienziati (Castelvecchi 2025)
Per raccontare il groviglio di intuizioni, errori, vicoli ciechi, retromarce e connessioni inaspettate che è la scienza (molto più di quanto non sia la “linea retta” che i positivisti volevano farci credere), gli autori hanno scelto di organizzare il volume in 29 voci in ordine alfabetico, da “Atomi” a “Volterra”, pensate, come suggerisce il nome del libro, non necessariamente per una lettura sequenziale ma per una “passeggiata casuale”, termini che evocano il processo del random walk, una formalizzazione matematica molto usata nella fisica moderna. Più che un vezzo stilistico, questa architettura è uno strumento cognitivo che incarna una delle idee filosofiche più potenti sulla scienza, e cioè il fatto, per dirla con Henri Poincaré, che “la scienza è costruita con fatti così come una casa è costruita con pietre, ma una raccolta di fatti non è una scienza più di quanto un mucchio di pietre sia una casa”. Il libro fornisce allora le pietre – i concetti, le biografie, le equazioni – ma invita il lettore a diventare l’architetto della propria conoscenza. I “possibili percorsi di lettura” suggeriti in un grafico all’inizio del volume non sono sentieri obbligati, ma progetti per costruire connessioni tra le pietre.
Ma c’è anche dell’altro. Nell’era dei Big Data e dell’intelligenza artificiale, in cui spesso ci si sofferma troppo sulle correlazioni e poco sulle causalità, il libro ricorda con forza l’importanza delle ipotesi, delle verifiche, delle conferme e delle falsificazioni – un’ode alla riflessione che è alla base del vero pensiero scientifico. La scienza, ricorda Giuseppe Mussardo nella prefazione, “ha bisogno necessariamente dei suoi tempi, dei ritmi lenti dettati dalle discussioni, dal controllo accurato delle ipotesi, dal gusto di arrivare con chiarezza e pazienza fino al fondo delle cose”. Intraprendere la “passeggiata” significa allora imparare a vedere il mondo con gli occhi di un fisico, con un senso di meraviglia per l’ordine nascosto sotto l’apparente caos, un profondo rispetto per la complessità e una curiosità appassionata per le storie, umane e cosmiche, che la natura ha ancora da raccontare.
Immagine: Greg Willson/Unsplash