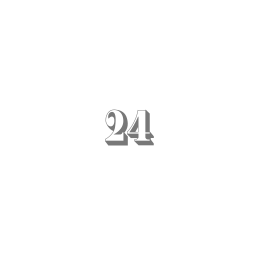Ascolta la versione audio dell’articolo
Mi hanno definito il fotografo che ha ritratto quasi tutti i protagonisti del nostro tempo. In realtà le star che vengono nel mio studio spesso sono miei amici. Molti li ho fotografati davvero tante volte, si lavora tranquilli, si pranza insieme, si chiacchiera». Così mi racconta Albert Watson, mentre camminiamo tra decine e decine di sue fotografie monumentali appese alle pareti. Siamo nelle sale del Palazzo delle Esposizioni a Roma, dove le immagini compongono la mostra Roma Codex, aperta al pubblico fino al 3 agosto. Roma è stata per lui come un altro pianeta: strade vuote, marmi luminescenti sotto la luce artificiale, fontane sospese nel tempo. Una città trasfigurata, perché è tra le tre e le cinque del mattino che Albert Watson, per mesi, ha catturato l’anima segreta della Città Eterna. «Le scalinate di Trinità dei Monti erano completamente vuote. Tutto sembrava leggermente surreale. Roma di notte è un luogo che si svela solo se hai la pazienza e la luce giusta per guardarlo», mi dice. Dopo oltre mezzo secolo di carriera, con innumerevoli copertine per Vogue, campagne pubblicitarie per Chanel, Prada, Levi’s e poster di film come Kill Bill e Memorie di una Geisha, Albert Watson ha firmato anche alcune immagini entrate nella storia: Alfred Hitchcock con un’oca sotto braccio, Steve Jobs nel suo iconico dolcevita nero, Kate Moss su un tetto a Marrakech. Eppure, alla soglia dei suoi 83 anni, resta più che mai un grande fotografo e soprattutto un uomo animato da una passione inesauribile per la vita e per tutto ciò che riguarda la creatività. Tanto da essere stato insignito anche dell’Ordine dell’Impero Britannico dalla regina Elisabetta II, un riconoscimento ufficiale che premia il suo straordinario contributo alla fotografia e alla cultura visiva in oltre mezzo secolo di attività.
Scozzese di nascita e naturalizzato americano, Albert Watson ha scelto Roma come teatro del suo ultimo progetto fotografico: il risultato di sette mesi di riprese e cinque di post-produzione, distribuiti in quattro viaggi intensi tra New York e la capitale italiana. Durante questo periodo, l’hotel InterContinental Rome Ambasciatori Palace è diventato la sua seconda casa. In segno di gratitudine, ha donato all’hotel alcune sue fotografie, due delle quali saranno esposte a fine mostra in cima alla grande scalinata dal tappeto rosso.

Più che un diario visivo, quello di Watson è stato un vero e proprio atlante antropologico su una Roma non osservata, ma vissuta: dopo la capitale la mostra viaggerà negli Stati Uniti, dove approderà a Washington al Kennedy Center, fortemente voluta da Paolo Zampolli, ambasciatore rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali. «Non volevo fare un coffee table book sui monumenti. Certo, ho fotografato il Colosseo, ma ero più interessato a ciò che succede tra i monumenti. Ai corpi, ai volti, alle storie. Sono entrato a Roma dalla porta sul retro, non dalla hall principale». Una dichiarazione d’intenti che diventa chiave di lettura: Watson cerca ciò che sfugge, ciò che si muove tra un punto e l’altro, dentro la Roma dei margini e delle contraddizioni. Tra le storie più sorprendenti, la donna dei rapaci incontrata a Cinecittà World. «Tutti i romani a cui ne ho parlato non sapevano neanche che esistesse. Eppure per me è stata importante quanto il Colosseo. Forse di più: ho più foto dei suoi uccelli che dell’Anfiteatro Flavio». Il progetto si costruisce così, per stratificazioni e contrasti. I giovani attori dell’Accademia e le ballerine diciassettenni cresciute nella disciplina. Le drag queen del locale notturno Muccassassina e i tifosi dell’AS Roma in curva. «Mi interessava mostrare la città sospesa tra storia ed edonismo. Tra il marmo eterno e le ombre fuggenti di una discoteca underground». Watson alterna la massa e la solitudine, la folla del club e il bacio furtivo di una coppia in strada, cinquemila tifosi in delirio e un volto anonimo sotto la pioggia. «Volevo lavorare sulla molteplicità e sulla singolarità. Due persone, otto, venti, cento, mille. Ma anche una. Un bambino, un passante, poi Paolo Sorrentino e Toni Servillo».
Albert Watson crea un dialogo continuo tra opposti: immagini dettagliatissime, lenticolari, che richiamano la precisione ossessiva dei dipinti fiamminghi, accostate a fotografie più grainy, sfumate, come memorie sbiadite. Questa alternanza non è casuale: è un gioco di contrappunti, una musica visiva fatta di temi che si intrecciano e si separano. Dal confronto di questi due universi nascono mondi sospesi, derive semantiche e fughe musicali che coinvolgono lo spettatore in una narrazione aperta e senza confini precisi. Watson stesso riflette sulla sua storia personale: «Mio padre era un pugile, poi diventato insegnante di educazione fisica. Mia madre era una parrucchiera. C’era già in famiglia una dialettica tra forza e grazia. Credo che questa dualità sia entrata nel mio modo di vedere e di fotografare il mondo». Ma ciò che contraddistingue Roma Codex non è solo il contenuto. È la forma. Watson ha una formazione ibrida, che unisce il cinema al graphic design: ha studiato regia cinematografica e design alla Duncan of Jordanstone College of Art & Design a Dundee, in Scozia, e poi al Royal College of Art. Una doppia matrice visiva che si riflette in ogni scatto. «Per me tutto finisce sempre dentro un rettangolo. Che sia un poster, una pagina di rivista o una fotografia: tutto è un rettangolo. Dentro, c’è sempre una composizione grafica. E anche una regia. Il soggetto è solo l’inizio». In mostra, una testa di Costantino dialoga con un pacchetto di sigarette schiacciato nel fango. Una moneta del 200 a.C. è accostata a un volto romano contemporaneo. «Mi interessa la combinazione tra livelli alti e bassi. Una statua iconica accanto a un oggetto banale, rovinato. Tutto ha valore. Come in una lingua: puoi dire Shakespeare o puoi dire ciao. È la stessa grammatica». La spontaneità, per Watson, è un’arte coltivata. «All’inizio della mia carriera cercavo di compiacere. Una volta stravolsi un’intera fotografia per accontentare un art director. Sembrava la cosa giusta. Però me ne pentii subito. Non ho mai più commesso quell’errore. Oggi, se vedo qualcosa per strada, grido “ferma la macchina!”. Perché magari, due ore dopo, non sarà più lì».
Istinto e rigore si mescolano nei suoi scatti. «È come andare in palestra. All’inizio reggi dieci minuti. Dopo sei mesi, un’ora. Così è la fotografia. L’istinto si allena, come un muscolo. Ma anche dopo cinquant’anni, puoi ancora sbagliare. E a volte, l’errore è una benedizione. Ricordo un giorno, in Nevada, presi per sbaglio una strada secondaria. Trovai un cartellone con scritto God Bless America. Tornai al tramonto, con il cielo rosso infuocato dietro. Era rimasta solo la parola God. Quello scatto non sarebbe mai esistito senza l’errore. Il caso ha sempre un ruolo».