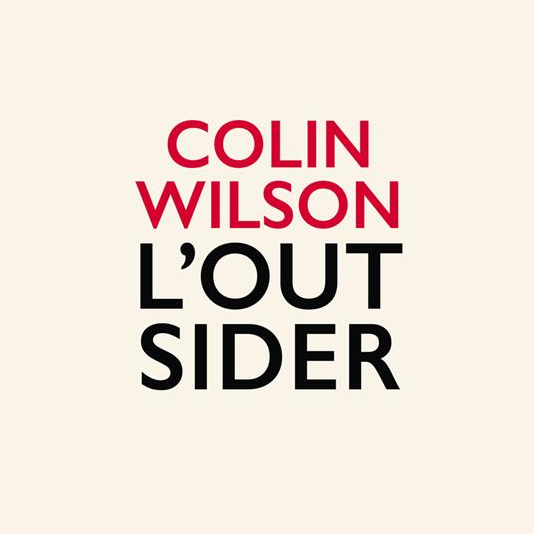Quando Colin Wilson pubblicò L’Outsider nel 1956, la critica lo collocò subito all’interno del movimento degli angry young men, quegli scrittori inglesi che con rabbia e ironia denunciavano l’ipocrisia e la vacuità della società borghese. Tuttavia, Wilson non può essere confinato del tutto in questa etichetta. Se John Osborne e Kingsley Amis rappresentano soprattutto il gesto demolitorio, Wilson sembra incarnare, per usare un’espressione di Mario Praz, la figura del “legislatore”: lo scrittore che, accanto alla critica radicale del presente, tenta di indicare anche prospettive costruttive, di proporre soluzioni nuove e audaci.
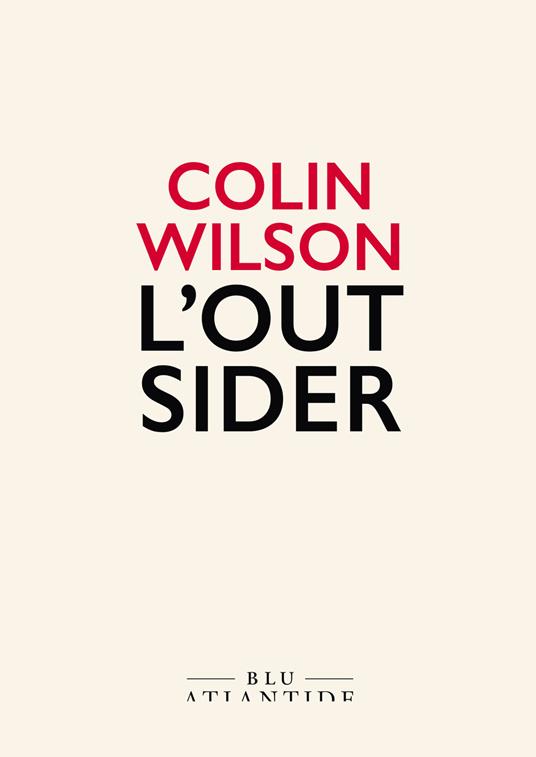 Il cuore del suo libro è il problema dell’outsider, figura centrale della cultura moderna. L’outsider è l’uomo che si accorge dell’irrealtà della vita quotidiana: un senso di smarrimento e di perdita di senso che affiora improvvisamente, come accade a un malato cronico che non trova più continuità tra un giorno e l’altro, o come se all’improvviso lo schermo cinematografico su cui si proiettavano speranze e desideri rimanesse senza immagini. L’outsider scopre di essere al cinema e si domanda: chi siamo? cosa stiamo facendo qui? A questo punto, spezzata l’illusione, si trova di fronte a una libertà assoluta e terrificante: per dirla con Sartre, è «condannato a essere libero».
Il cuore del suo libro è il problema dell’outsider, figura centrale della cultura moderna. L’outsider è l’uomo che si accorge dell’irrealtà della vita quotidiana: un senso di smarrimento e di perdita di senso che affiora improvvisamente, come accade a un malato cronico che non trova più continuità tra un giorno e l’altro, o come se all’improvviso lo schermo cinematografico su cui si proiettavano speranze e desideri rimanesse senza immagini. L’outsider scopre di essere al cinema e si domanda: chi siamo? cosa stiamo facendo qui? A questo punto, spezzata l’illusione, si trova di fronte a una libertà assoluta e terrificante: per dirla con Sartre, è «condannato a essere libero».
Wilson utilizza immagini potenti per descrivere questo stato. Se lo schermo era il mondo illusorio in cui ogni problema trovava una risposta, la sala cinematografica – il mondo reale – appare inquietante e priva di garanzie. Ma se anche questo nuovo mondo si rivelasse irreale? L’outsider vive allora il paradosso di Chuang-Tzu, che non sapeva se fosse un uomo che sognava di essere una farfalla o una farfalla che sognava di essere un uomo. È lo stesso spaesamento di Novalis, che scrive: «Quando sogniamo di sognare, siamo prossimi a destarci».
Questa esperienza di irrealtà è già stata descritta in figure letterarie precedenti: dall’outsider di Barbusse a Roquentin de La nausea. Per Wilson, ogni volta che tali interrogativi riaffiorano, è segno della presenza di un outsider. Se li consideriamo come domande ultime e insolubili dell’esistenza, allora l’outsider non è che l’annunciatore del problema senza risposta. Ma prima di concludere in questo modo, Wilson percorre un ampio ventaglio di tentativi, di voci e testimonianze che meritano di essere esaminate.
Un primo confronto significativo è quello con T.E. Lawrence. Egli incarna, secondo Wilson, una sintesi delle due tradizioni dell’outsider: quella di Roquentin e quella di Barbusse. Come il protagonista sartriano, Lawrence percepisce l’irrealtà delle cose: «Ero come gli altri… Dicevo come loro ‘il mare è verde; quel punto bianco, lassù, è un gabbiano’, ma non sentivo che ciò esisteva». E come l’eroe di Barbusse, Lawrence non può essere felice in società, perché «vede troppo e troppo lontano». L’esperienza della guerra gli offre, come a Barbusse, uno spioncino spalancato sul dolore umano, una violenza che, dissipando le contraddizioni di una civiltà fondata sul compromesso, lo mette a nudo di fronte alla realtà. Lawrence, infatti, aborriva il compromesso più di ogni altra cosa.
In questo percorso Wilson dedica grande attenzione anche a Hemingway, che colloca in dialogo con la tradizione esistenzialista. Nel racconto Una storia naturale dei defunti emerge con chiarezza la sua posizione: «gli uomini muoiono come bestie, non come uomini». È un rifiuto radicale della concezione umanistica della perfettibilità dell’uomo. Nei suoi scritti, l’unico valore è la vita stessa, mentre le idee risultano prive di sostanza. Ciò non significa che la vita sia priva di significato, ma che non possiede fondamenti assoluti.
A prima vista, potrebbe sembrare che il contributo di Hemingway al tema dell’outsider sia puramente negativo. In realtà, nota Wilson, c’è molto di positivo nella sua opera: l’onestà, l’amore profondo per la natura, la freschezza corporea e sensitiva delle sue prime opere, che ricordano una personale ricerca del tempo perduto. Il lettore, trascinato dalla forza della scrittura, prova spesso la speranza che questa ricerca conduca a un esito costruttivo. Ma dopo il 1930, con il successo commerciale e la celebrità, Hemingway sembra perdere la strada: né come artista né come pensatore riesce più a proporre una filosofia di vita coerente. Non è però soltanto colpa del successo: anche Sartre, con tutta la sua preparazione filosofica, non arriva a una risposta positiva più soddisfacente di quella che Hemingway già aveva intuito. La filosofia dell’engagement sartriano – scegliere una via qualsiasi e percorrerla fino in fondo, pur sapendo che non porta a nessuna verità ultima – era già stata anticipata da Hemingway, quando in Addio alle armi mostra come il protagonista Henry, gettandosi nel combattimento, riesca a dissipare il senso di irrealtà.
Questo ci riporta a una questione cruciale: l’outsider non è soltanto un problema sociologico, ma soprattutto metafisico. Non si tratta solo di esclusione sociale, ma di un’inquietudine radicale riguardo al senso della vita e alla sua forma. Camus e Hemingway insistono proprio su questo aspetto pratico: che forma dare alla vita, quale scopo riconoscerle. L’outsider non può accettare la vita così com’è: non la ritiene necessaria, né la propria né quella altrui. Vede troppo, guarda troppo lontano, e questa lucidità diventa una maledizione.
Il dramma dell’outsider è dunque sempre una questione di autoespressione. In The Secret Life vediamo un outsider separato dagli altri da un’intelligenza che distrugge spietatamente i suoi valori senza offrirgli alternative. È il problema della vanitas vanitatum dell’Ecclesiaste: nulla sembra valere la pena di essere fatto. Il romanticismo ha complicato ulteriormente il quadro: l’outsider romantico non è solo il disilluso dalla vita, ma colui che nel tentativo di incarnare un ideale superiore si scontra con il proprio limite. Hesse, in particolare, con il Lupo della steppa, mostra come la via sia quella di una continua autoanalisi, di un ripercorrere “molte e molte volte l’inferno del mio cuore”.
In questo contesto, Lawrence rappresenta un caso singolare. Non diviso in due come Haller, non odia solo una parte di sé, ma odia tutto se stesso: corpo, mente, emozioni. Questa sofferenza, ben nota ai mistici, non è stata ancora compresa appieno dai suoi biografi. Lawrence stesso, nei Sette pilastri della saggezza, aveva già intuito che l’uomo non è un’unità ma una pluralità, e che solo diventando unità la vita acquista senso. La guerra di Lawrence contro la personalità divisa era quindi anche una guerra contro la civiltà occidentale, colpevole di aver alimentato questa frammentazione.
Per Wilson, l’outsider non è un malato, ma un uomo più sensibile, dotato di una percezione più elevata. È mosso da tensioni interne che l’uomo comune non conosce. La risposta facile – «mandatelo da uno psichiatra» – non basta. Occorre invece trattare la sua condizione come un problema filosofico: come risolvere queste tensioni?
Il punto di partenza, suggerisce Wilson, è che l’outsider vuole essere libero. La sua condizione di schiavitù è l’irrealtà, perciò la via d’uscita deve consistere in una percezione più autentica della realtà. Ed ecco che Wilson interroga vari outsider: per Barbusse la realtà è la conoscenza dei recessi più profondi dell’animo umano; per Wells è lo schermo del cinema, rivelazione della nullità dell’uomo; per Roquentin è la nuda esistenza; per Meursault è l’indifferenza magnifica dell’universo, nella quale anche l’anima umana è immersa. Hemingway, dal canto suo, vi vede un momento di necessità pratica, quando l’uomo fa ciò che deve fare, smettendo di essere una pedina insignificante. Per Lawrence, invece, la realtà è inconoscibile, un lampo che spezza la banalità senza offrire alternative. Per Van Gogh è infelicità prometeica, per Nijinsky una tensione eterna tra Dio e dolore.
Queste voci diverse convergono nel delineare la condizione dell’outsider: nato in un mondo senza valori, deve darsene di propri o sarà condannato a rimanere un reietto. È qui che Wilson introduce Nietzsche, che risolve l’equazione di corpo, sentimenti e intelletto e vede nell’outsider un profeta mascherato. La sua missione è scoprire lo scopo più profondo della propria vita e dedicarvisi con tutte le forze. Non basta, dunque, l’engagement sartriano: serve una missione vera, capace di gridare all’umanità un risveglio.
Il problema, però, resta quello dell’identità. L’outsider ha trovato un io, ma non è il suo vero io. Deve rintracciare la via di ritorno a se stesso, ma non è un cammino semplice. Occorre conoscere a fondo la propria prigione interiore, altrimenti si rischia di scavare cunicoli, come l’abate del Conte di Montecristo, solo per ritrovarsi nella cella accanto.
La tradizione letteraria, da Dostoevskij con Memorie dal sottosuolo a Hesse con Il lupo della steppa, ha descritto questa condizione come un continuo oscillare tra disperazione e momenti di lucidità. Dostoevskij mostra che dietro l’uomo c’è l’abisso del nulla, ma il compito dell’outsider è quello di afferrare la vita con più forza dei borghesi, di costruire nonostante l’assenza di fondamenti.
Alla fine, per Wilson, l’outsider vuole cessare di esserlo: cerca equilibrio, intensità, autoespressione. Vorrebbe percepire il mondo con vividezza sensoriale, come Van Gogh o Hemingway, ma anche comprendere l’anima umana, come Barbusse o Dostoevskij. Vuole fuggire dalla trivialità e vivere una maggiore abbondanza di vita. Il suo problema è, in definitiva, quello di imparare a esprimersi: solo così può conoscersi davvero e scoprire le proprie potenzialità.
Dalla via dell’outsider emergono due lezioni fondamentali: che la salvezza non sta nella moderazione ma negli estremi, e che l’uscita dall’irrealtà si presenta attraverso momenti di intensità, visioni improvvise, lampi che squarciano il velo delle illusioni. L’Outsider non è dunque solo un saggio letterario, ma un manifesto filosofico ed esistenziale: un’opera che mette a nudo l’inquietudine dell’uomo moderno e lo invita a guardare in faccia l’abisso, per costruire nonostante tutto.
Colin Wilson, L’Outsider, traduzione di T. Fazi, Atlantide, Roma 2020, pp. 400.