Lei è una fisioterapista irruente e allergica alla polvere, una che agli appuntamenti importanti non si siede finché l’interlocutore resta in piedi. Lui è un vescovo, viso squadrato e occhiali tondi di metallo, sguardo lungo ma non ostile. Sono i protagonisti, umanissimi, di Dio della polvere, il nuovo romanzo di Mariapia Veladiano. Un dialogo a tappe, sempre più ravvicinate, li vede impegnati anima e corpo «per salvare una vita, forse due». Al centro, una storia di abusi e pedofilia, una parola su cui l’autrice non indugia ma su cui nemmeno fa sconti, «nel nome di tutte le storie vere che ci nascondono», si legge nell’esergo.
È un libro che richiede una buona dose di coraggio: da parte di chi scrive e da parte di chi legge. È intriso di rabbia e di bisogno di giustizia. È un inno al potere della verità, quando riesce a superare la negazione del dolore (e delle colpe) degli altri.
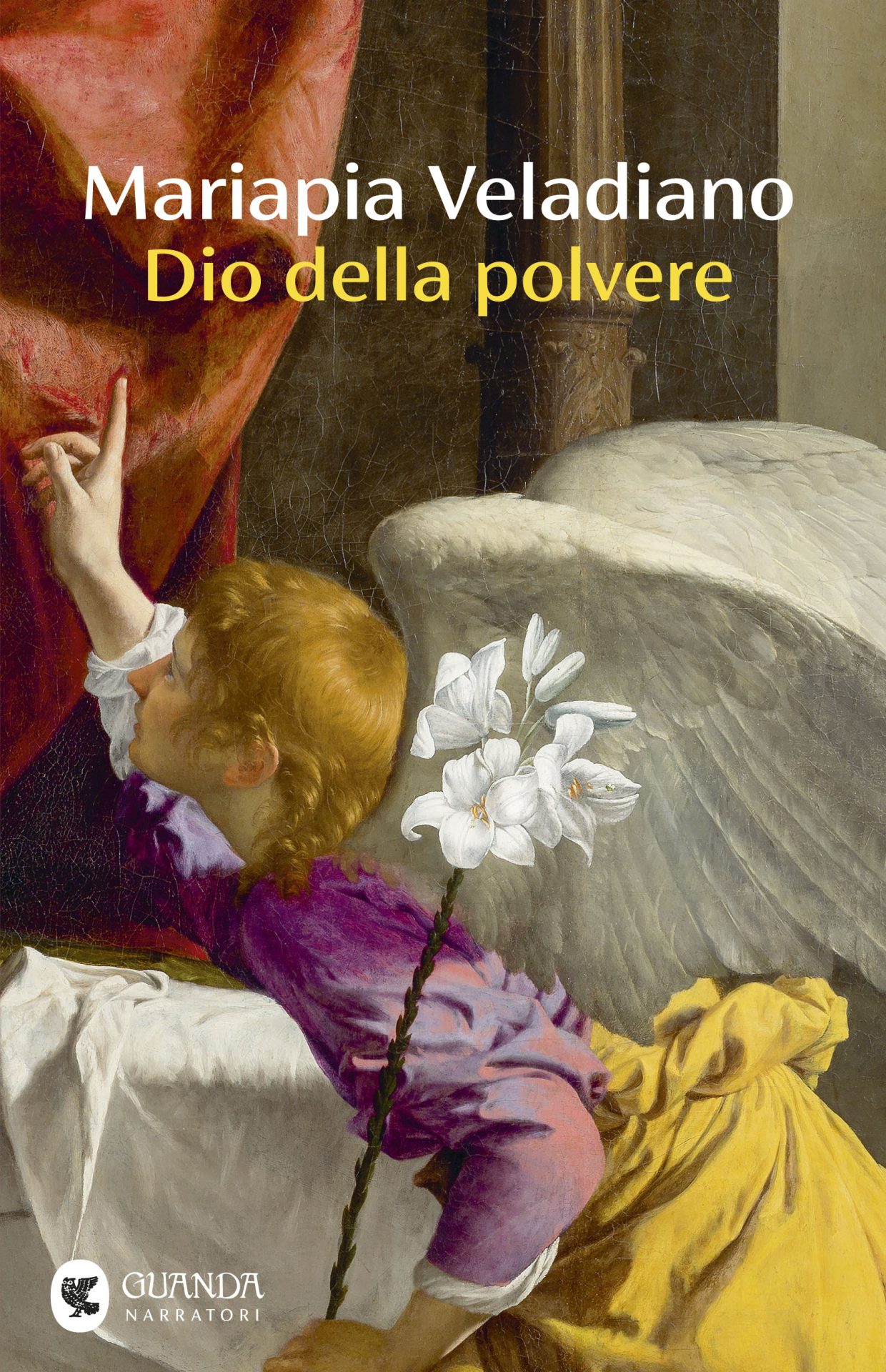 La copertina del libro
La copertina del libro
Partiamo dal fondo. C’è un ringraziamento accorato, nell’ultima pagina del libro, nei confronti della rivista Il Regno, che da più di 30 anni tiene una sorta di archivio di tutti i casi noti, le inchieste, i documenti delle Conferenze episcopali e dei singoli vescovi e i report sul tema della pedofilia ecclesiastica. Lei da tempo collabora con questa rivista. Nasce da qui il suo desiderio di affrontare il tema?
Mi ha aiutato a capire che si tratta di un tema grave e serio, che provoca un mare di sofferenza nelle vittime di violenza, rovina le loro vite e devasta le loro famiglie. Ma che può devastare anche la Chiesa, se non lo si affronta in modo trasparente. In Italia la pedofilia del clero viene rappresentata nella forma di singoli isolati fatti di cronaca. Lo scandalo di un giorno, raro e subito pronto a sparire. Il Regno ha seguito le vicende americane, irlandesi, francesi, tedesche, cilene. Si è visto che per conoscere la verità è necessario affidarsi a indagini esterne, che la Chiesa come istituzione si autoprotegge minimizzando e insabbiando. Servono trasparenza e giustizia.
I racconti di chi ha subito violenza ci dicono che spesso l’esperienza è scotomizzata, cioè la mente la allontana, non la ricorda proprio per niente. Il corpo invece ricorda
Mariapia Veladiano, scrittrice
Lo scambio a tratti duro tra una fisioterapista e un vescovo nasce dalla vicenda di Luna, una ragazza giovanissima arrivata nello studio di lei. È stata vittima di una violenza, non ne vuole parlare, ma il suo corpo comunica. Chi è Luna? Che cosa rappresenta per lei, credente e teologa?
Chiara, la fisioterapista che parla per conto di Luna, un poco alla volta, dialogo dopo dialogo, fa capire al vescovo che si tratta di una persona vera e non di un fastidioso episodio di debolezza da parte di un prete. Gli mette davanti la realtà di un corpo devastato, di una famiglia distrutta. E soprattutto gli mostra la assoluta necessità di giustizia, unica possibile parziale riparazione al crimine. Per una persona credente, Luna rappresenta la necessità di posizionarsi o riposizionarsi accanto a chi è stato oggetto di violenza. Chiara non vuole distruggere la Chiesa con il suo chiedere ostinatamente giustizia: vuole che la Chiesa sia migliore.
Quanto c’è di Mariapia Veladiano nelle domande che Chiara, la fisioterapista, pone al vescovo? E nel modo in cui il vescovo risponde?
Ci sono le mie domande e quelle di tanti credenti che non possono pensare che la Chiesa continui a minimizzare e insabbiare. Lo ripete sempre il gesuita Hans Zollner, fra i massimi studiosi al mondo sul tema. Nella Chiesa la pedofilia è un problema sistemico perché coinvolge diverse componenti: c’è il clericalismo degli apparati che difendono se stessi, ma c’è anche quello dei laici che tacciono, minimizzano, nascondono. Quanto al vescovo, posso dire di aver riportato quasi alla lettera parole o espressioni o posture difensive che ho visto e sentito in tanti colloqui con preti e persone di chiesa.
La professione che ha scelto per Chiara è emblematica. Nelle parole con cui descrive l’incontro con i corpi altrui, emerge il ruolo cruciale del lavoro di cura. Che cosa ci dice del lavoro sociale? E perché ha scelto proprio quel mestiere?
I racconti di chi ha subito violenza ci dicono che spesso l’esperienza è scotomizzata, cioè la mente la allontana, non la ricorda proprio per niente. Il corpo invece ricorda. Nel romanzo Chiara tocca con professionalità e partecipazione i corpi che portano la memoria del dolore per essere stati usati come oggetti e questa esperienza permette alle persone vittime un recupero del desiderio di vita. A volte anche del ricordo.
 Mariapia Veladiano, foto di Andrea Lomazzi
Mariapia Veladiano, foto di Andrea Lomazzi
In entrambi i personaggi c’è una fessura che conduce alla speranza. Speranza di salvare la Chiesa e speranza di salvare la vita di una ragazza.
Sì, attraverso la giustizia. La giustizia è un percorso di riconoscimento dei fatti e delle colpe che permette di non moltiplicare il male. La violenza sui bambini è male enorme. Quella commessa dai preti è ancora più drammatica perché chi la commette si presenta ed è percepito dalla comunità credente come eletto, come interprete autorizzato della Parola di Dio. La sua violenza sgretola la fiducia e anche la fede. Se la Chiesa istituzione non sta immediatamente e senza tentennamenti accanto alla vittima e non le dice “Io sono con te per ottenere giustizia”, si fulminano tutti, dice Chiara nel romanzo. Il bambino, la Chiesa, la comunità.
È impensabile il passaggio dalla violenza subìta al perdono. Prima e/o insieme ci deve essere la giustizia
Mariapia Veladiano, scrittrice
Perché il titolo Dio della polvere?
La polvere della menzogna che copre i casi di violenza sessuale del clero impedisce lo splendore della fede in un Dio che sta sempre dalla parte dei poveri e dei piccoli. Le moltissime realtà buone e belle dei credenti sono confuse nel calderone di questi crimini e non brillano. A un certo punto il vescovo chiede a Chiara: “Ma perché crede ancora?” e lei risponde: “Non siete così importanti sa, vescovo? Potete togliermi il sonno, non la fede”. È la fede – che è relazione col Signore – che le permette, cci permette, di non avere paura: nemmeno delle bugie della Chiesa.
Non volevo scrivere un romanzo morboso e la materia si prestava ad esserlo. Ma la morbosità non aiuta il pensiero, lo involve, lo ingarbuglia nello sdegno, nel fastidio e non offre invece percorsi lucidi di azione
Mariapia Veladiano, scrittrice
Il suo romanzo toglie un velo, anche attraverso la scelta delle parole, mai abusate né negate. È stato difficile sceglierle? E ora che il libro è uscito, come è stato accolto?
Sì, è stato complicato perché non volevo scrivere un romanzo morboso e la materia si prestava ad esserlo. Ma la morbosità non aiuta il pensiero, lo involve, lo ingarbuglia nello sdegno, nel fastidio e non offre invece percorsi lucidi di azione. Ci sono parole anche tremende dentro la discussione fra Chiara e il vescovo, ma sono quelle che servono a descrivere la verità e a cercare la giustizia. È impensabile il passaggio dalla violenza subìta al perdono. Prima e o insieme ci deve essere la giustizia. In questo senso il linguaggio è importante. Ad esempio per la pedofilia bisogna usare la parola violenza, non la parola abuso. Un abuso è l’uso eccessivo di qualcosa che ha anche un uso buono e legittimo. L’abuso di potere è l’uso eccessivo del potere, ma esiste anche un buon uso del potere. Invece non c’è un buon uso della sessualità agita su un bambino o una bambina, quella è violenza e basta. Così come qui non si tratta tanto di un peccato del clero, ma di un reato. Ovvio che c’è anche il peccato, per chi crede, ma intanto è un reato e quello lo è per tutti.
In apertura, una veglia di preghiera in Portogallo per le vittime degli abusi sessuali agiti da rappresentanti della chiesa cattolica, in Portogallo. Foto Armando Franca, Associated Press/LaPresse.
Vuoi accedere all’archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
