C’è un treno che parte dall’Ucraina e arriva in Polonia. E poi c’è un pullman che da lì riparte e arriva in Italia, prima al nord e poi giù, fino a Napoli. A bordo c’è un bambino che ha 10 anni e non sa stare fermo: viaggia da solo, in tasca una foto e un numero di telefono. “Corre corre corre”, fugge dalle bombe, cerca salvezza. Fa quello che gli ha detto di fare “Tato”, suo padre, più grande di lui ma solo per età, perché adulto non è mai diventato. Suo padre è ancora un figlio che dà pensieri a una mamma lontana, partita quando lui ancora era bambino per lavorare nelle case italiane.
Kostya è il bambino, Tato – Roman – è il papà, Irina è la donna che ha lasciato l’Ucraina anni prima: mamma, nonna e colf (ma più che altro custode) di Vita, una donna che a dispetto del nome non ha più voglia di vivere.
Di là l’Ucraina, con le bombe e le macerie, i soldati e i disertori, gli uomini che non possono andare via e le donne che invece partono, prima in cerca di fortuna, ora in cerca di salvezza. Di qua Napoli, dove Vita ha tutto e niente: ha la fortuna della pace e del benessere, ma è lacerata da un lutto e da una perdita che l’hanno fatta sprofondare nella solitudine e nel letto, nella malattia e nei farmaci che dovrebbero curarla, ma che nulla possono contro quelle ferite che non sanno rimarginarsi. Saranno proprio la vecchia e disincantata Irina e il piccolo e incantato Kostya a tirarla su da quel letto, per tornare a essere quella madre che non è più: di figli che non sono suoi, ma che sono vivi. E che vogliono esserlo, pur con la guerra che li insegue, insieme al suo carico di morte.
 Viola Ardone
Viola Ardone
Viola Ardone compone un affresco ricco e variegato, nel suo ultimo libro edito da Einaudi, Tanta ancora vita. Un libro che commuove, perché è pieno di dolore. Eppure che strappa più di una risata.
Perché raccontare la tragedia della guerra, della morte e del lutto con la leggerezza dell’ironia?
Io penso che lo sguardo ironico non sminuisca, anzi amplifica la realtà anche nel momento del dolore e della perdita. Irina, Vita e Kostya sono personaggi drammatici, ciascuno con un pezzo mancante, in corsa verso qualcosa, ma sono anche personaggi che fanno sorridere. Vita che dà un nome alla sua depressione, per esempio: la chiama Orietta, per darle un’identità che sia diversa dalla sua, in modo da non confondere se stessa con la sua malattia. Irina parla male l’italiano, ma cita Dante a memoria.
Il libro si apre con un treno e un bambino che sale in carrozza. Cosa ha in comune con il “treno dei bambini” (altro romanzo di Viola Ardone, da cui è stata tratta l’omonima serie tv di Cristina Comencini, ndr)? E cosa, invece, rende Kostya diverso da Amerigo, protagonista dell’altro libro?
Entrambi sono treni che portano, almeno in teoria, verso la salvezza: con la preoccupazione e la paura, certo, soprattutto nel dopoguerra, quando il treno evocava le immagini della deportazione. Ma sono due treni di speranza. Sul “treno dei bambini”, però, si saliva e si scendeva tutti insieme. Ed erano treni organizzati, pensati dagli adulti per i bambini. Qui non ci sono adulti, perché oggi in effetti gli adulti spesso mancano, o sono inadeguati. Il papà di Kostya lo ha fatto salire su quel treno, ma non è veramente un adulto. Vita, la donna presso cui Irina (la nonna di Kostya) lavora a Napoli, non è un’adulta neanche lei. E anche Irina non lo è fino in fondo: non sa se sentirsi ancora madre oppure no. Sarà il bambino, che riporterà i grandi a fare gli adulti, come se dicesse loro: «Pensatemi, o non potrò crescere»
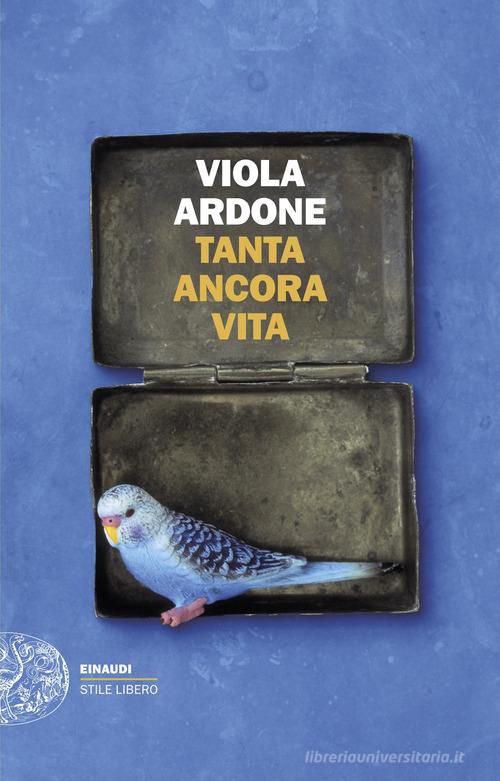 La copertina del libro
La copertina del libro
Nel libro ci sono tre madri, ma sono tutte e tre “spezzate”: una ha abbandonato il figlio, l’altra lo ha perso per sempre, l’altra lo ha lasciato per lavorare lontano da casa. Cosa vogliono dirci queste figure femminili?
Che la funzione materna e genitoriale non è solo genetica: ci sono donne senza figli che sono molto materne con figli che non hanno partorito, così come ci sono donne che hanno figli ma non sanno essere madri. E allora sorgono tutte quelle domande che Vita e Irina si pongono: una donna che non ha più un figlio si può ancora chiamare madre? Quando un figlio è lontano, continua a essere figlio? Irina deve compiere la scelta drammatica tra veder crescere un figlio e nutrirlo: una scelta capestro nei Paesi poveri, che esportano l’unica cosa che hanno in abbondanza, la manodopera. Anche Kostya si fa tante domande sul suo essere figlio oppure orfano. Il denominatore comune è la questione che mi interessava mettere dentro il libro: cosa significa essere genitore geneticamente e cosa significa invece vivere una genitorialità estesa, diventando madre e padre di figli altrui?
Kostya fugge dalle macerie dell’Ucraina e poi ci torna, mostrando con queste una certa dimestichezza: sa come muoversi, sa come proteggersi. Che ruolo hanno i bambini nella guerra? Sono solo vittime o hanno anche una “competenza”?
I bambini hanno una risorsa fondamentale: il tempo. Se restano vivi, hanno dalla loro parte il lato lungo della vita, che è la speranza. In questi giorni a Gaza vediamo scene drammatiche di migliaia di persone che tornano nelle loro case e trovano solo macerie. I bambini sono quelli che sanno, più di tutti gli altri, che su quelle macerie si può costruire. Lo sanno i bambini ucraini, lo sanno i bambini gazawi, lo sanno i bambini di tutte le guerre. E questo li rende luminosi. Vedere tornare Kostya in Ucraina, o i bambini palestinesi a Gaza, ci mette davanti agli occhi, anche in mezzo alla distruzione, il filo lungo della speranza.
I bambini sono quelli che sanno, più di tutti gli altri, che su quelle macerie si può costruire. Lo sanno i bambini ucraini, lo sanno i bambini gazawi, lo sanno i bambini di tutte le guerre. E questo li rende luminosi
C’è chi dice che i bambini nati e cresciuti sotto le bombe – come Kostya, o come i bambini di Gaza – saranno pieni di odio e di rancore, perfino possibili futuri terroristi. È così?
Se così fosse, tutti i bambini del dopoguerra sarebbero dovuti diventare terroristi. Invece, hanno fatto l’Italia. Tutto dipende dal processo di pace che viene organizzato e vissuto: se si riproporrà la stessa condizione di oppressione e ingiustizia in cui questi bambini hanno vissuto finora, allora non sarà la guerra a renderli cattivi, ma l’ingiustizia, la diseguaglianza, l’apertheid.
Anche la malattia mentale è un tema che ritorna nei suoi libri: in questo caso, Vita ci fa tornare un po’ nei corridoi dell’istituto del dottor Meraviglia. Perché parlarne?
Perché credo che ci sia un’Orietta (il nome che Vita dà alla sua depressione, ndr) acquattata in ciascuno di noi. Quando siamo adulti, diventa più invadente, è sempre pronta a scattare. Chi non ha un disagio psichico, spesso ha paura che questo si manifesti, condizionandone la quotidianità. Orietta non va da Irina perché lei è una madre in guerra, con un figlio sotto le armi, abitata dalla speranza. La depressione, come dice Vita, è la malattia dei popoli in pace, dove non si rischia la vita sotto le bombe, ma il peso dell’esistenza si fa sentire comunque.
C’è un’Orietta acquattata in ciascuno di noi. Quando siamo adulti, diventa più invadente, è sempre pronta a scattare. Chi non ha un disagio psichico, spesso ha paura che questo si manifesti, condizionandone la quotidianità
Irina è una donna migrante. Immagini che, finita la guerra, ritorni nella sua Ucraina?
Penso che il desiderio di ogni migrante sia quello di tornare, di rimettersi in contatto con le proprie radici. La comunità ucraina, così come altre comunità, è molto numerosa in Italia: sono soprattutto donne, che in una sorta di lotta di classe al contrario hanno contribuito all’emancipazione delle donne italiane, le quali hanno delegato a loro – anziché ridistribuire i compiti all’interno della famiglia – la cura dei figli, degli anziani, della casa. Sono donne spesso molto colte, ma questo non viene percepito, per via del gap linguistico, che appiattisce tutte le relazioni: una persona che non parla bene la nostra lingua per noi è una persona “semplice”, bidimensionale, poco più di una macchietta. Irina, con la sua profondità e la sua filosofia, smentisce questo luogo comune.
Cos’è che fa finalmente rialzare Vita dal letto e la rimette in moto?
Kostya: quel bambino che le arriva in casa e la prende per mano, ha bisogno di lei. Quando la vita viene a prenderti a casa, allora non puoi più nasconderti. E poi c’è Roman, il figlio di Irina e padre di Kostya, che ha l’età che avrebbe suo figlio, se fosse ancora vivo: non importa che non sia suo, l’importante è che quel figlio sia vivo. Così Vita alza e parte, in modo del tutto irrazionale, per aiutare il figlio di un’altra. Forse lo fa perché sarebbe stata contenta se qualcuno lo avesse fatto per suo figlio. L’altro da te potrebbe essere te: è questa sensazione che la fa rialzare in piedi.
C’è un altro treno in partenza, pronto per essere raccontato? Chi c’è a bordo?
Ho davanti agli occhi, soprattutto in questi giorni, un treno che non c’è e che non c’è stato: il treno dei bambini palestinesi e di tutti i bambini costretti a diventare esperti di sirene e di macerie.
Foto in apertura Unsplash (Taras Chuiko). Foto interna dell’autrice
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.
