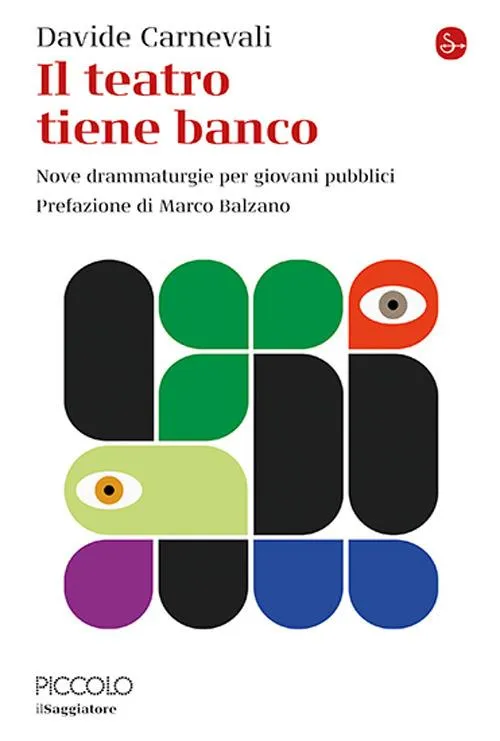Partiamo dal titolo, che è quanto mai azzeccato: Il teatro tiene banco. Azzeccato perché lucidamente ambiguo: da una parte allude al banco di scuola, e infatti è di teatro per le scuole che il volume tratta; dall’altra è una piccola, puntuta provocazione al mondo dei grandi, grandissimi media planetari, facendo balenare il sospetto che, anziché ridotto al rango di nobile decaduto, come ritenuto dai più, il linguaggio teatrale conservi una forza in grado di tenere banco anche al presente, primeggiando per vitalità e capacità di rivolgersi in maniera non stereotipata agli adolescenti, in grado di trasformare il piccolo – non abbiamo milioni di follower… – in profondo. Eccola qui, l’antologia di testi teatrali firmata da Davide Carnevali, che in seguito a svariati premi nazionali e riconoscimenti internazionali, si situa con felice autorevolezza nel panorama della drammaturgia italiana, tradotto e pubblicato in diverse lingue, dalla Francia all’Argentina alla Romania. Eccetera. Ora questo bel libro, edito dal Saggiatore con la prefazione di Marco Balzano, raccoglie nove opere teatrali nate all’interno del progetto omonimo del Piccolo Teatro dedicato alle scuole e realizzato dal 2022 al 2025, dove la sfida è stata quella di presentare, durante tre stagioni, tre spettacoli differenti all’anno: uno pensato per le scuole elementari, uno per le scuole medie e uno per gli istituti superiori. Ed è evidente che, fatta salva la limpida autorialità di Carnevali i testi siano il frutto di un processo collettivo in cui hanno giocato la loro parte la più importante istituzione del teatro italiano e la guida illuminata del suo direttore Claudio Longhi, gli attori Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Diana Manea e Giulia Trivero, a pieno titolo co-autrici e co-autori dei “copioni”, e di tante altre significative figure (organizzatrici, scenografi, costumiste, fonici, macchinisti, sarte e attrezziste), tutte preziose per il loro apporto, come sottolinea lo stesso Carnevali nella sua introduzione al volume: “Il testo era pre-scritto”, ci informa, “ma non doveva essere pre-scrittivo: è in prova dunque che si sono andate costruendo queste opere, da un lavoro comune che ha coinvolto in alcune occasioni anche Virginia Landi, come assistente di regia, e Micol Jalla, come assistente volontaria. Lo spettacolo non è mai la semplice messa in scena di un testo, ma il frutto di un lavoro di ensemble, che comprende tutte le maestranze; e dunque è rimasta la loro traccia all’interno di questi testi.”
Parole sante, soprattutto perché pronunciate dall’architetto primo di questo polittico drammaturgico. E d’altronde, che cosa di più esaltante, in tempi di individualismo malato, di un autentico processo collettivo? Della scommessa di costruire cattedrali nel piatto deserto che ci attornia? Siamo schiacciati tra il superficiale essere massa anonima, milioni di followers che cliccano e cliccano e cliccano, e il non-essere di sterminate solitudini depresse. Che cliccano e cliccano e cliccano. Qui c’ è invece un noi, il teatro, che divertendo e divertendosi interroga e richiede l’alleanza di un altro noi, la scuola. Attrici e attori, drammaturghi, insegnanti, studentesse e studenti: tutti insieme. Mescolati. E tale alleanza viene richiesta all’insegna del gioco, una delle cose più serie che ci siano al mondo. E cosa intendiamo per gioco? Chiamiamo a confortarci alcuni tra i massimi pensatori dell’Occidente. Platone: “L’origine del gioco è nei saltelli dei cuccioli di animali.” Splendida. Saltelli, corpi. E Sant’Agostino: “Nutre l’anima solo ciò che la rallegra.” Siete d’accordo, cari insegnanti? Non potete non esserlo, visti i giganti in questione. Entrambe le definizioni hanno un forte retrogusto dionisiaco, quel dio del teatro che, secoli e secoli orsono come nel terzo millennio, celebra i suoi misteri “intrecciando cose gravi e cose buffe”. E la citazione è di Aristofane, un altro monumento, uno che iniziò a scrivere a diciotto anni. Contro la guerra. Un adolescente infuriato, come tanti oggi nelle piazze d’Italia. Come quelli per cui sono state scritte queste nove drammaturgie, la cui varietà e ricchezza si evidenzia già dai titoli, e trame sottintese. Carnevali si aggira con maestrìa nel labirinto dei classici, siano essi fiabe, poemi epici, letteratura o teatro, attraversandoli come si attraversa un fiume, nuotandoci dentro. Sprofondando e riemergendo.
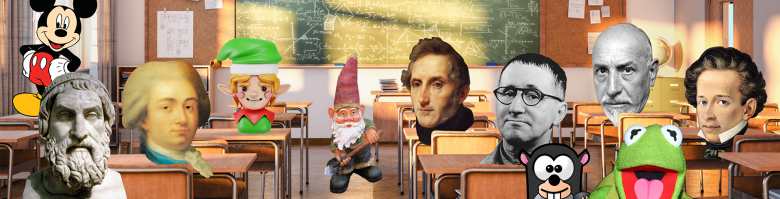
Elaborazione immagine © Riccardo Frati.
Si comincia con La favolosa battaglia dei topi e delle rane, liberamente tratta da Omero, da Leopardi e dalla cronaca della guerra in Ucraina. Che fissa, diciamo così, i paletti che sorreggeranno l’intero triennio: il teatro è invenzione di una realtà altra, è una “scatola magica” dove se io dico – con le parole, con un cartello appeso al collo, usando i linguaggi che mi sembrano più convincenti – che un attore è un topo e un’attrice una rana, i due umani diventano davvero, per magia, un topo e una rana. Si fissa il principio brechtiano dello stare sul crinale tra incanto e disincanto, principio che sta come emblema di tutta questa avventura, dove anche i piccoli spettatori sono coinvolti a esprimere un giudizio nel finale, a diventare essi stessi attori: ricordandoci tutti che le invenzioni di Bertolt Brecht (lo straniamento, il coinvolgimento del pubblico, il post drammatico etc.) non le ha inventate lui, le ha solo ripresentate a tutti noi. Tali invenzioni nascono con Aristofane e Plauto e il teatro comico antico, verranno portate avanti dalle sacre rappresentazioni medievali, saranno poi sviluppate da Molière e Shakespeare, dal teatro didattico dei gesuiti e dalla Commedia dell’Arte, fino appunto al drammaturgo tedesco. Fino a noi. Orlando hater e Angelica furiosa porta in scena lo stesso Ludovico Ariosto: l’epica cavalleresca viene reinventata mescolando poesia e linguaggio dei social, e Orlando, in preda ai sentimenti tipici degli adolescenti, fatica a riconoscersi nei panni dell’eroe: nel confronto con un’Angelica lei sì furiosa… affronta le questioni legate alla parità di genere e agli stereotipi della mascolinità. Il primo triennio si chiude con Antigone in cattedra: la tragedia prende vita durante l’ora di supplenza di Creonte, un professore ad interim nella classe dei Tebani, e la sua protagonista fa i conti con le ferite aperte della società patriarcale. Nel corso del triennio gli spettacoli per gli istituti superiori si sono sempre svolti nelle scuole milanesi, scelta significativa in grado di creare magia nei luoghi stessi della realtà, con gli attori e le attrici sedute tra i banchi insieme agli studenti, chiamati in causa sui nodi che affliggono la loro quotidianità.
Il secondo anno La meravigliosa avventura di Ciàula nella caverna intreccia la novella di Pirandello alle suggestioni platoniche del mito della caverna: per far percepire ai bambini le profondità della “scatola magica” – che qui ritorna – li si fa passare attraverso le gallerie sotterranee che uniscono il Teatro Studio Melato al Teatro Strehler: e sempre più evidente diventa quel che si diceva dianzi, ovvero che in questo progetto la scrittura drammaturgica è inseparabile da quella scenica, che lo spazio scelto o un’intenzione registica ispirano i dialoghi, così come il pubblico a cui ci rivolge, come le tecniche utilizzate, in questo caso il teatro d’ombre. Dante Alighieri, nella Guida pratica per orientarsi nella selva oscura, è un adolescente disorientato che si rivolge alla psicologa della scuola: è lei che, insieme all’amata Beatrice e all’amico Virgilio, lo invita a non fuggire davanti alle difficoltà e a proseguire quel cammino complicato ma affascinante che è la vita. Se Ezra Pound affermava, con una definizione insuperata, che “Dante is the everyman”, ovvero che Dante siamo tutti noi, in qualsiasi luogo e qualsiasi tempo, la figura smarrita nella “selva oscura” può legittimamente e doverosamente incarnarsi in un ragazzino di oggi, aiutandolo a investigare le sue paure. I Sei personaggi in cerca di followers ritornano fisicamente a scuola, nelle classi del liceo, è ancora Pirandello a essere preso di mira e a farci prendere la mira: i sei personaggi infatti entrano in aula cercando non l’autore, ma dei followers che diano conferma alla loro esistenza partendo da un like.
Viaggio fantastico nel (sotto)suolo apre il terzo anno con uno spettacolo sui generis, nato all’interno di un progetto europeo e dalla collaborazione con il Politecnico di Milano e il professor Paolo Pileri. Oggetto della ricerca era il suolo, la sua fragilità e la sua importanza nell’ecosistema. Qui si prendono come spunto le Operette morali di Leopardi conducendo i bambini e le bambine a mettere in discussione l’antropocentrismo malato della nostra epoca, a ripensare una più armonica convivenza con tutte le specie che abitano il nostro pianeta, per arrivare a “sentire”, come dice in chiusura il folletto-guida, “il battito della Terra.” In Quel ladro del lago di Como i bravi manzoniani sono dei maranza che bullizzano all’entrata gli spettatori e le spettatrici: “questo spettacolo non s’ha da fare.” Tutto nasce da un “cappellino rubato”: e sono certo che Alessandro Manzoni non possa che essere felice nel vedere il suo capolavoro smembrato e fatto a pezzi e poi fatto resuscitare per una storia di vittime e di violenza che, in omaggio alla sua immensa e spesso mal compresa ironia, “finisce bene”. Il teatro comico goldoniano e la sua trilogia per la villeggiatura vengono invece utilizzati e rovesciati per stabilire un rapporto più vero con il pubblico: togliersi la maschera è il primo passo per aprirsi e condividere ansie e timori, soprattutto in un periodo complesso come quello tra la fine del ciclo scolastico obbligatorio e l’ingresso nel mondo del lavoro.
Una volta terminata la lettura delle nove drammaturgie, emerge, come da uno sguardo panoramico dall’alto, la varietà di spunti e l’unità profonda di concezione e prassi che le legano: non c’è mai, in questi testi, un furore iconoclasta contro la tradizione, semmai un affettuoso riabbracciarla, non allontanandosi affatto dai monumenti. Utilizzando senza timore il linguaggio quotidiano degli adolescenti, quello dei “raga” e degli instagram, mettendo in opera i dispositivi del metateatro, la scrittura stratificata e sapiente di Davide Carnevali semmai ci avvicina a quegli amati antenati, come se suggerisse, a noi e ai giovanissimi a cui si rivolge: e ora andatevele a leggere nell’originale, quelle antiche, preziose storie che qui vi abbiamo ripresentato. Vedrete, non sarà tempo perso.