“Le transizioni energetica e digitale, pur rappresentando opportunità per un futuro più sostenibile e innovativo per le singole economie e l’intera umanità, segnano forti discontinuità col passato e richiedono una gestione attenta, pena il rischio di acuire tensioni economiche o geopolitiche e diseguaglianze esistenti, con l’effetto di ridurre anziché aumentare il benessere collettivo”. Come ogni libro, anche questo scritto da Luca Dal Fabbro può piacere o non piacere, ma abbiamo estrapolato questa frase contenuta nella sua Premessa per evidenziare che si tratta di un testo ritagliato su misura per i tempi difficili in cui stiamo vivendo.
“Proteggere il futuro – Sicurezza energetica, resilienza economica e ambientale nell’era delle tre transizioni globali” è il titolo di un’opera (edizioni Rubbettino, 233 pag.) che mette davvero molta carne al fuoco. Del resto, l’autore è quel che si dice una persona informata dei fatti, come attesta il suo curriculum. Luca Dal Fabbro è un ingegnere chimico e manager italiano dalla lunga esperienza internazionale. Attualmente è alla guida di IREN, la multiutility che figura tra i principali operatori italiani per quanto riguarda l’energia, il gas, l’efficientamento energetico, nonché la gestione dei servizi idrici integrati e ambientali.
Non solo decarbonizzazione e digitalizzazione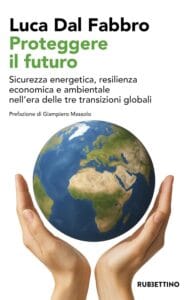
Nella visione di Dal Fabbro, dunque, tutto ruota intorno alle tre grandi transizioni attualmente in atto nel pianeta. Quest’ultime sono ampiamente descritte nell’Introduzione del libro: “Le trasformazioni che investono gli ambiti economico, sociale e ambientale delle nostre società sono legate ai tre processi descritti nella premessa: decarbonizzazione, digitalizzazione e avvio a fenomeni di deglobalizzazione. Fino a oggi il dibattito pubblico e scientifico si è focalizzato sugli effetti dei primi due elementi nella trasformazione delle economie attraverso il concetto di twin transition. Con questo si intende il complesso dei cambiamenti, radicali e pervasivi, richiesti dalle transizioni green e digital sia nei modelli di produzione che in quelli di consumo di beni e servizi, la cui portata investe tutti gli aspetti della vita quotidiana delle persone, delle aziende e delle istituzioni pubbliche”.
Tuttavia, l’autore spiega che emerge sempre più chiaramente una terza trasformazione, che interessa le relazioni internazionali e incide in modo determinante sulle scelte che i governi e gli attori economici sono chiamati a prendere in questa fase storica. Questa trasformazione, che viene definita come geopolitics transition, sta portando al fenomeno sempre più evidente della deglobalizzazione, ovvero una riduzione dell’interdipendenza economica e commerciale tra le nazioni, che sono tornate a focalizzarsi maggiormente sulle proprie economie nazionali, e tutt’al più sulle macroaree regionali nelle quali dette economie si inseriscono.
Cambiano i termini della transizione energetica…
Ma se la deglobalizzazione rappresenta una sorta di novità, anche un’altra transizione, ben nota da molti anni, sta in qualche modo cambiando faccia: “Sebbene siano essenziali per limitare gli effetti catastrofici del cambiamento climatico, la transizione energetica e la decarbonizzazione non sono prive di problematiche per le economie. Le loro fondamenta sono costruite su risorse scarse e disuguaglianze geopolitiche che rischiano di creare nuovi cicli di dipendenze e conflitti.”
Si stanno formando nuove catene di dipendenza, legate da un lato alle materie prime critiche, che sono estratte e raffinate in poche aree del mondo e spesso controllate da regimi instabili o autoritari, con rischio di sfruttamento degli ecosistemi e dei lavoratori, e dall’altro lato alle tecnologie per la generazione e il consumo di energia rinnovabile. “In entrambi gli ambiti, la Cina ricopre un ruolo predominante, mentre l’Europa e l’Italia si trovano in una posizione di scarsissima autonomia”.
… e digitale
Quanto alla transizione digitale, nel libro si sottolinea come si è entrati in una nuova fase, con l’introduzione degli strumenti di Intelligenza Artificiale che hanno il potenziale, ancora largamente inesplorato, di trasformare radicalmente numerose attività, produttive e non solo.
Ma anche in questo caso non mancano le problematiche: “Tra i rischi, il primo è la cyber-vulnerabilità. Infrastrutture critiche – come energia, trasporti, finanza – sono sempre più interconnesse e dipendenti da sistemi digitali. Un singolo cyberattacco può così paralizzare un’intera economia. Il secondo è la centralizzazione dell’influenza: le grandi piattaforme tecnologiche dominano i dati e la comunicazione globale, mettendo in crisi la sovranità degli Stati e riducendo la concorrenza economica. Il terzo è la dipendenza: i Paesi che non producono tecnologie digitali avanzate rischiano di divenire subalterni a quelli che le controllano, amplificando le disuguaglianze globali. Infine, esiste un rischio di obsolescenza accelerata: la dipendenza da tecnologie in continua evoluzione lascia aziende, governi e individui sempre un passo indietro, intrappolati in un ciclo infinito di aggiornamenti e vulnerabilità”.
Le tre transizioni in otto capitoli
Disposte le carte in tavola, l’autore si preoccupa di spiegare negli otto capitoli del libro come si potrà evolvere il “gioco” delle tre transizioni nel futuro:
- Governare la triplice transizione
- Energia: elemento chiave nelle sfide globali della triplice transizione
- Le grandi economie mondiali verso il net-zero?
- Il sistema e la politica energetica dei Paesi europei
- Il sistema energetico italiano: opportunità e rischi dell’assetto attuale e futuro
- Le sfide verso un’economia italiana net-zero e competitiva
- Un approccio di sistema per la soluzione del trilemma
- Le condizioni abilitanti per l’approccio sistemico proposto

E di sicuro interesse è il ragionamento che sviluppa Dal Fabbro in relazione al posizionamento dell’Italia di fronte al cambiamento: “L’insieme dei fenomeni della triple transition richiede all’Italia di adottare una serie di complesse trasformazioni nel proprio sistema energetico ed economico. Il percorso verso un’economia digitale, decarbonizzata e resiliente nel contesto internazionale, è ricco di sfide per il sistema energetico, per quello produttivo e per tutta la collettività. Proviamo ad analizzare queste sfide attraverso la chiave di lettura del trilemma esteso, per evidenziare le tre dimensioni su cui agire – sicurezza, resilienza ambientale e competitività – e declinandole, dove opportuno, per gli ambiti dell’energia, della tecnologia e delle materie prime”.
Il ruolo fondamentale delle fonti rinnovabili
Le complesse trasformazioni richieste al nostro Paese non possono prescindere da un elemento, ovvero la crescita dell’impiego di fonti rinnovabili, elettriche e termiche nei consumi energetici.
Una conversione green del sistema energetico nazionale che risulta essenziale per rispondere a tutti e tre gli obiettivi sopra citati: “Sotto il profilo ambientale garantisce una riduzione delle emissioni di carbonio e di sostanze inquinanti; sotto il profilo economico, può portare alla riduzione e alla stabilizzazione dei costi per l’energia pagati dagli utenti finali; dal punto di vista della sicurezza, contribuisce a una maggiore autonomia energetica poiché l’energia ricavata da fonti rinnovabili va a sostituire le importazioni di combustibili fossili”.
Tre elementi per la sicurezza energetica
Ma con l’avanzare della transizione energetica, insieme al mix energetico cambieranno anche le priorità in termini di sicurezza. E l’autore spiega che per arrivare pronti alle sfide future occorre innanzitutto porsi una domanda: da che cosa dipenderà la nostra sicurezza energetica ed economica in un sistema (quasi) interamente decarbonizzato? La risposta che viene formulata è basata, allo stato attuale, su tre elementi:
- L’adeguatezza del sistema elettrico, che avrà un peso più rilevante rispetto a oggi. Per garantirla servirà una grande capacità di stoccaggio, possibile grazie a tecnologie power-to-gas, e una maggiore capacità di interconnessione coi sistemi energetici limitrofi, non solo verso l’Europa ma anche verso i Paesi del Nord Africa affacciati sul Mediterraneo.
- La capacità di produrre, importare e stoccare quantità abbondanti di vettori energetici puliti diversi dall’elettricità, quali biometano, idrogeno verde, biocarburanti. Questi saranno essenziali per garantire la continuità della produzione nei settori hard-to-abate e per bilanciare il sistema elettrico dominato dalle rinnovabili non programmabili.
- Il controllo di una quantità strategica di capacità produttiva per le tecnologie e le materie prime critiche in un’economia digitalizzata e decarbonizzata. In un sistema energetico dominato dalle fonti rinnovabili, la componentistica necessaria per la costruzione e manutenzione di questi impianti avrà un ruolo centrale: moduli fotovoltaici, rotori eolici, batterie, elettrolizzatori, saranno beni essenziali.
Tenere sotto controllo tutti gli aspetti
Si arriva così alle Conclusioni del libro nelle quali Dal Fabbro evidenzia come il concetto di resilienza ambientale, per quanto ampio, non può essere l’unico driver strategico in questa grande fase di cambiamento. “Nel contesto che ci attende – si legge –, dominato dalle forze della triplice transizione, ovvero instabilità politica internazionale, competizione per le risorse strategiche, impatti del cambiamento climatico, impegni per la decarbonizzazione e avvento dell’Intelligenza Artificiale, gli operatori privati e le istituzioni pubbliche necessitano di un approccio che permetta di semplificare e tenere sotto controllo tutti gli aspetti vitali, che sono molti”.
Da qui un rinnovato invito ad agire nella logica del trilemma esteso: “Investire sulla sicurezza degli approvvigionamenti strategici rompe le dipendenze esclusive da fornitori esteri (siano essi di energia, tecnologie o materie prime) e permette di cambiarli in tempi rapidi in caso di crisi diplomatiche; adottare infrastrutture resilienti dal punto di vista ambientale limita gli impatti delle crisi meteorologiche; avere un’economia competitiva con un certo grado di autonomia nazionale nelle produzioni più sensibili è più resiliente agli shock esterni di diversa natura”.
