La vicenda dei minori “cresciuti nel bosco” ha suscitato un’ondata emotiva e politica che ha rapidamente offuscato i contorni reali del caso, trasformando una decisione giurisdizionale in un simbolo e un nucleo familiare in una metafora. Nel dibattito pubblico si sono sovrapposti commenti sommari, letture ideologiche e un immaginario quasi fiabesco, mentre i dati giuridicamente rilevanti rimanevano sullo sfondo. Eppure, per comprendere il senso del provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, occorre ricostruire i fatti senza precomprensioni e ricondurre la decisione all’interno dell’unico perimetro che le conferisce razionalità: la tutela dei diritti dei bambini, letta alla luce dei parametri costituzionali e sovranazionali che da decenni orientano l’azione del giudice minorile. In questo contesto – come conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza minorile e civile – il riferimento al best interest of the child non è una formula di stile, ma un criterio di equilibrio volto a guidare le scelte pubbliche quando sono in gioco soggetti giuridicamente fragili.
I fatti essenziali sono noti. Tutto ha avuto origine dal pronto soccorso, dove i minori erano stati condotti per l’ingestione accidentale di funghi. La prassi sanitaria impone che, in presenza di elementi potenzialmente critici, il personale medico informi i servizi sociali, che a loro volta attivano il protocollo ordinario e trasmettono una relazione alla Procura minorile. In quel documento si descriveva un’abitazione ritenuta insalubre, l’assenza di istruzione formalmente verificabile e una situazione sanitaria non accertabile. Elementi che, nel loro complesso, hanno reso necessario l’avvio del procedimento ex artt. 330 e 333 c.c., senza alcuna iniziativa autonoma del Tribunale, che non può mai intervenire sua sponte.
Dall’ordinanza in esame (testo in calce) emerge poi un aspetto decisivo, spesso ignorato nel dibattito pubblico: la difficoltà, per i servizi coinvolti, di effettuare una compiuta verifica della situazione familiare. Durante la fase istruttoria – come riportato nel provvedimento – gli operatori non hanno potuto accedere all’abitazione; alcuni accertamenti sanitari sui minori non sono stati eseguiti o sono stati subordinati a condizioni estranee al procedimento; non è stata prodotta documentazione sulla sicurezza dell’immobile; diversi colloqui programmati non si sono svolti. L’ordinanza chiarisce che tali elementi non vengono letti in chiave di responsabilità o colpevolezza – categorie estranee al diritto minorile – ma quali indicatori della difficoltà oggettiva di verificare il contesto e, dunque, del rischio che eventuali pregiudizi non fossero rilevabili. Si tratta, in altri termini, di un rischio derivante dalla stessa impossibilità di accedere alle informazioni necessarie per tutelare il minore.
A ciò si aggiunge la questione dell’istruzione, che non è un dettaglio formale ma un obbligo giuridico volto a garantire lo sviluppo della personalità del minore. In caso di istruzione parentale, la legge impone la presentazione di una dichiarazione del dirigente scolastico, indispensabile per valutare l’idoneità del percorso educativo. L’assoluta mancanza di tale documento impediva ogni verifica. L’ordinanza specifica comunque che il provvedimento non è stato adottato sulla base di una lesione del diritto all’istruzione, ma in relazione al rischio di compromissione della vita di relazione, ritenuto pregiudizio primario nel caso concreto.
È su questo quadro che il Tribunale ha fondato la propria decisione, ritenendo che l’isolamento relazionale dei minori, l’assenza di coetanei, la mancanza di socializzazione e l’impossibilità di verificare condizioni abitative e sanitarie configurassero un rischio concreto per la crescita affettiva, educativa e fisica dei bambini. Dall’ascolto è emersa inoltre la scarsa conoscenza della lingua italiana, circostanza che ha reso necessaria una nuova audizione con interprete per garantirne la piena spontaneità. Non si tratta di un giudizio culturale sullo stile di vita dei genitori, bensì della valutazione tecnica di un periculum che rendeva necessaria una misura temporanea di protezione. La motivazione sottolinea il diritto dei minori alla relazione e alla costruzione dell’identità attraverso il confronto con l’altro, ormai riconosciuto come componente della dignità personale ex art. 2 Costituzione.
Un ulteriore elemento, spesso omesso nelle ricostruzioni mediatiche, riguarda la diffusione pubblica – tramite televisione e social network – delle immagini dei minori durante il procedimento, quando le valutazioni erano ancora in corso. Le fotografie e i video sono stati utilizzati per illustrare la vicenda all’opinione pubblica, in violazione del diritto alla riservatezza del minore, tutelato dall’art. 16 della Convenzione ONU del 1989, dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Si tratta di un diritto indisponibile, sottratto alla disponibilità dei genitori, la cui lesione impone allo Stato obblighi positivi di protezione.
Si è discusso anche del perché l’intervento sia avvenuto in questo caso e non in altre situazioni di abbandono o degrado. Il quesito è comprensibile, ma poggia su un equivoco strutturale: il Tribunale per i minorenni non esercita un monitoraggio generale del territorio. La giustizia minorile interviene esclusivamente quando riceve una segnalazione da chi opera sul campo – ospedali, scuole, servizi sociali, forze dell’ordine. Il vero problema, semmai, è che molte situazioni non emergono perché nessuno le intercetta. Aspettarsi che il giudice intervenga anche dove non vi sia alcuna segnalazione significa travisare l’architettura del sistema di protezione.
Va però soggiunto che il provvedimento del 13 novembre non ha carattere definitivo: dispone la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale, non la decadenza. Prevede incontri protetti con entrambi i genitori, supporto psicologico e misure volte a evitare rischi di sottrazione. È un provvedimento cautelare, modificabile o revocabile al mutare delle condizioni di fatto che lo hanno determinato. La finalità non è punitiva ma protettiva, in conformità al principio del favor minoris che permea il diritto minorile.
La forte reazione politica – culminata nell’annuncio di ispezioni e in critiche aperte al provvedimento – mostra quanto il terreno della tutela dei minori sia divenuto, negli ultimi anni, sensibile alle pressioni identitarie e ideologiche. Ma quando sono in gioco bambini in carne e ossa, con una storia e una vulnerabilità proprie, il diritto impone un passo indietro dal clamore. Ubi maior, minor cessat: quando entra in gioco l’interesse del minore, ogni altra valutazione – politica, ideologica, mediatica – deve arretrare.
Questa vicenda ricorda, forse più di altre, che la protezione dell’infanzia non può essere piegata al racconto pubblico del momento. La giurisdizione minorile opera in un terreno in cui la parola pesa, l’esposizione ferisce e la retorica confonde. Per questo richiede uno sguardo lucido e un linguaggio sobrio: non una semplice prudenza formale, ma un’autentica cultura della misura istituzionale. È la misura che si deve a chi, non potendo parlare, affida la propria voce alle garanzie che l’ordinamento ha costruito proprio per lui.
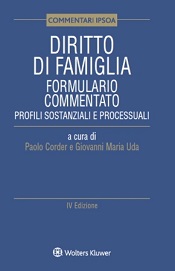 Diritto di famiglia – Formulario commentato, AA.VV., a cura di Corder Paolo, Uda Giovanni Maria, WOLTERS KLUWER ITALIA. Profili sostanziali e processuali. Oltre 300 formule di maggior uso nella pratica, corredate da commenti dottrinali e richiami di giurisprudenza.
Diritto di famiglia – Formulario commentato, AA.VV., a cura di Corder Paolo, Uda Giovanni Maria, WOLTERS KLUWER ITALIA. Profili sostanziali e processuali. Oltre 300 formule di maggior uso nella pratica, corredate da commenti dottrinali e richiami di giurisprudenza.Scarica un estratto gratuito
Tribunale per i minorenni di L’Aquila, ordinanza 13 novembre 2025

