La selezione di Elledecor.it dei libri da leggere a luglio 2025 aggiunge nuove ‘sfumature’ alle proposte editoriali dedicate a progettisti e non, allargando lo sguardo su temi attuali, affrontati in modo particolare. Ecco dunque un volume ‘transgenarazionale’ che è per metà fiaba per bambini e per l’altra racconto scientifico pensato per cambiare il nostro modo di vedere la natura. E ancora un saggio espone l’idea, nell’era attuale dell’Antropocene, di un’architettura in risonanza con le persone, attraverso la quale è possibile prendersi cura del presente, dei luoghi che abiteremo e delle risorse che serviranno a realizzarla. Le letture di luglio si espandono in ambito artistico con una raccolta di interventi dedicati a uno dei più importanti critici e storici dell’arte italiana, ma anche con la riedizione di un testo ‘storico’ di un curatore tra i più influenti al mondo. Tra le novità editoriali di questo mese spicca una rilettura dell’opera di una architetta italiana del Novecento, e un volume incentrato sui trattati che più hanno influenzato il pensiero architettonico e la storia delle costruzioni, dal Rinascimento a oggi. Una pubblicazione si interroga su cosa sia o cosa possa rappresentare il doppio di una disciplina, di un’azione nel mondo che possiamo definire progetto, ‘sfuggendo’ a ciò che normalmente intendiamo o vogliamo considerare design. Infine, i titoli di luglio includono un libro fotografico che esplora le fratture del mondo, tra inferno e paradiso.
Down Under: The Curious Fall of a Child Who Knew Nothing and Became Everything, di Formafantasma
Una fiaba per bambini nella prima parte e una serie di contributi scientifici e critici, su cui si fondano le basi del racconto, nella seconda: sono le due anime del progetto editoriale di Formafantasma pubblicato da NERO e C-mine. “Down Under: The Curious Fall of a Child Who Knew Nothing and Became Everything” è un libro illustrato “creato con l’intento di diventare un oggetto transgenerazionale, un’opera che può essere rivisitata in diverse fasi della vita, offrendo nuovi spunti a ogni incontro”, come scrive lo stesso studio di design all’interno del volume. L’idea è di contribuire a cambiare il modo in cui i bambini e la società vedono la natura. L’obiettivo non è di presentare una visione semplicistica del rapporto dell’umanità con la Terra, quanto di promuovere la consapevolezza della profonda interconnessione tra gli esseri umani e il resto del mondo naturale, dove nessuna specie è isolata. “È una visione che sfida la convinzione che la natura sia una risorsa da estrarre e che gli esseri umani siano separati dalle creature con cui condividono il pianeta”, si legge ancora. Oggi il concetto di estinzione, solo qualche secolo fa impensabile, è divenuto una realtà che dobbiamo affrontare, ed “è con questa consapevolezza che speriamo di cambiare il nostro modo di vedere il mondo”, scrivono i Formafantasma. Il libro, infatti, è commissionato e nasce da un programma di residenza del museo di Genk C-mine orientato a indagare la natura e il valore dei territori postindustriali del Belgio. Lo studio di design si è focalizzato, in particolare, sui terril, termine locale riferito a cumuli di scorie, roccia di scarto, scisto e arenaria, lasciati a cielo aperto dopo l’estrazione mineraria sotterranea del carbone, colline locali, artificiali ma naturali, che disegnano paesaggi dinamici, in continuo mutamento anche senza l’intervento dell’uomo, icone del nostro tempo e della nostra società. “Down Under” fa riferimento all’ampio corpo di lavori che designer italiani, come Enzo Mari e Bruno Munari, hanno dedicato al ruolo del design nell’ambito della formazione, della sperimentazione e della ricerca pedagogica. Ma l’approccio al design di Formafantasma differisce da quello espresso da Mari nella sua ‘Serie della Natura’, un processo creativo che mirava alla “forma perfetta” in una ricerca quasi ossessiva di riduzione e chiarezza, nel raggiungere una semplicità idealizzata attraverso l’astrazione. I Formafantasma riconoscono il valore della chiarezza formale, ma credono “che non possa essere separata dalle più ampie complessità e contraddizioni del mondo in cui esiste. Gli oggetti con cui viviamo sono permeati dalle storie delle persone, dei materiali, degli animali e di tutte le specie che hanno contribuito alla loro creazione”. “Down Under”, nella sua parte iniziale, è quindi un racconto scritto appositamente per i bambini, completato dalle bellissime illustrazioni di Clément Vuillier. I suoi disegni sono stati sviluppati prendendo spunto dalle immagini microscopiche ad alta risoluzione di campioni di materiale provenienti da un terril a Genk, una forma oggettiva di rappresentazione basata sulla prospettiva scientifica mirabilmente “hackerata” dalla straordinaria immaginazione di Clément”, commenta lo studio. La seconda sezione del libro presenta una serie di interviste di Formafantasma a scienziati ed educatori, a Natalie Beenaerts, Roland Dreesen, Dirk Maes e François Rineau, che approfondiscono le condizioni territoriali, geografiche e biologiche dei terril di Genk. Contiene, inoltre, un saggio critico della storica dell’arte Teresa Castro.
Down under. The curious fall of a child who knew nothing and became everything
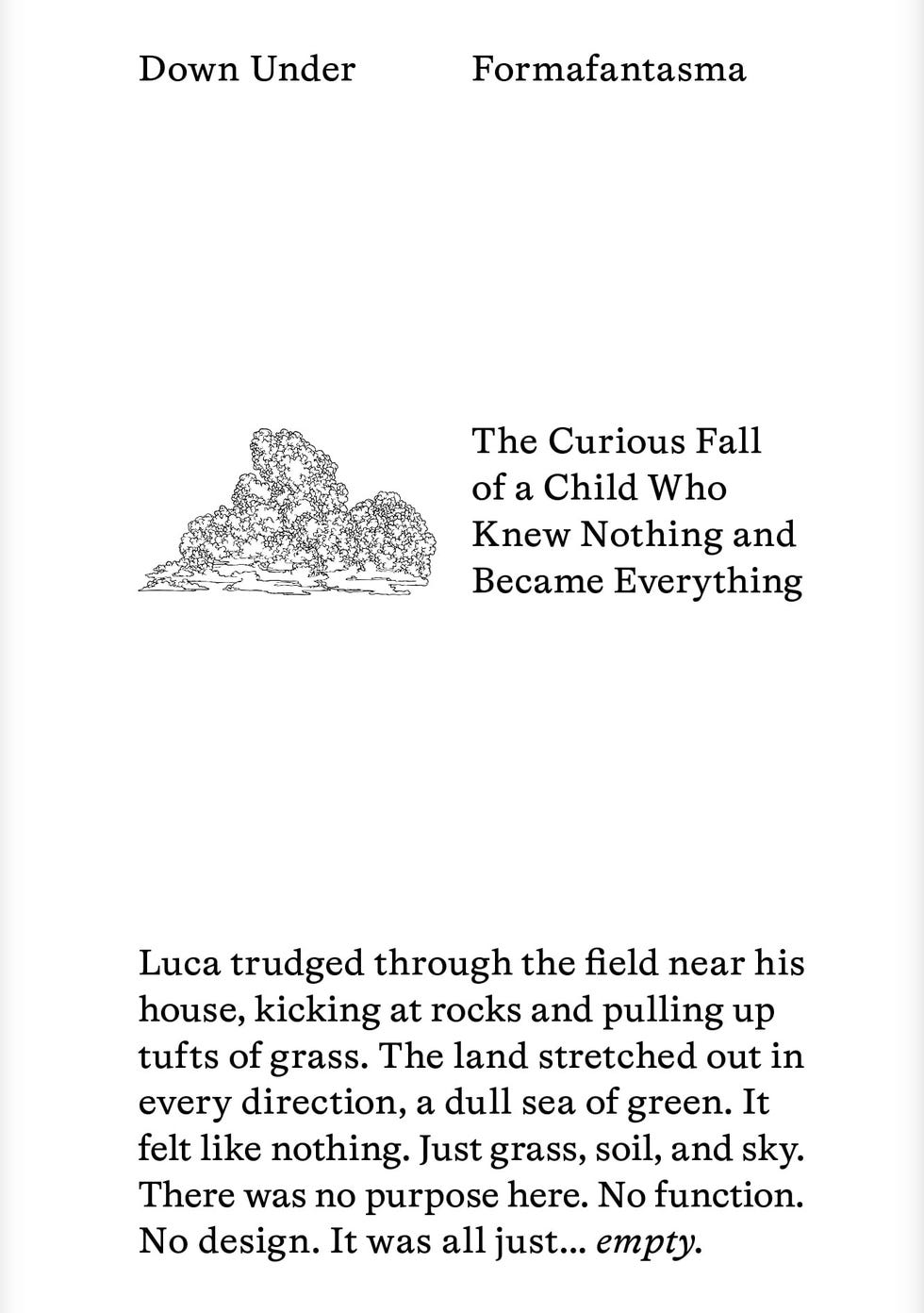 Napoli nei progetti di Stefania Filo Speziale, di Mattia Cocozza
Napoli nei progetti di Stefania Filo Speziale, di Mattia Cocozza
Il libro, pubblicato da Quodlibet, propone “una rilettura attenta, originale e scevra da pregiudizi dell’opera di Stefania Filo Speziale”, scrive Andrea Maglio nell’introduzione. In effetti, il percorso professionale dell’architetta è stato accidentato, “costellato di successi e oggetto di violente polemiche (la vicenda del grattacielo di Napoli l’ha posta al centro di una vera e propria ‘tempesta mediatica’ ), ma forse anche per questo capace di restituire nella maniera più vivida la stagione della ricostruzione postbellica napoletana”, prosegue Maglio. L’autore Mattia Cocozza, parlando di “Napoli città-teatro”, può indagare la capacità di Filo Speziale di “radicarsi al luogo” interpretando le peculiarità del paesaggio e del territorio napoletano, una propensione, per altro, strettamente legata anche all’attività didattica svolta nelle aule della Facoltà napoletana di Architettura, “capace di lasciare un segno ben più di quanto si sia finora voluto ricordare”. Il contributo dell’architetta, prima donna a laurearsi in architettura a Napoli, è stato rivalutato considerando alcuni specifici studi dedicati a singole realizzazioni. In particolare, l’autore ha scelto la Porta Nord della Mostra d’Oltremare, il Palazzo Della Morte e il Palazzo / villa Filo, opere che rimandano a fasi diverse della carriera di Filo Speziale, lasciando emergere il suo ruolo nella progettazione di edilizia sociale e nell’edilizia residenziale borghese, e che sintetizzano un percorso professionale autonomo e originale, sganciato dalle categorie formali e stilistiche di quei decenni. Attraverso un’analisi priva di filtri ideologici, il libro dimostra come, “al di là di ogni giudizio morale, politico e storico, indubitabili siano l’attualità e l’utilità di quel lavoro di Filo Speziale”, è il commento di Maglio.
Napoli nei progetti di Stefania Filo Speziale
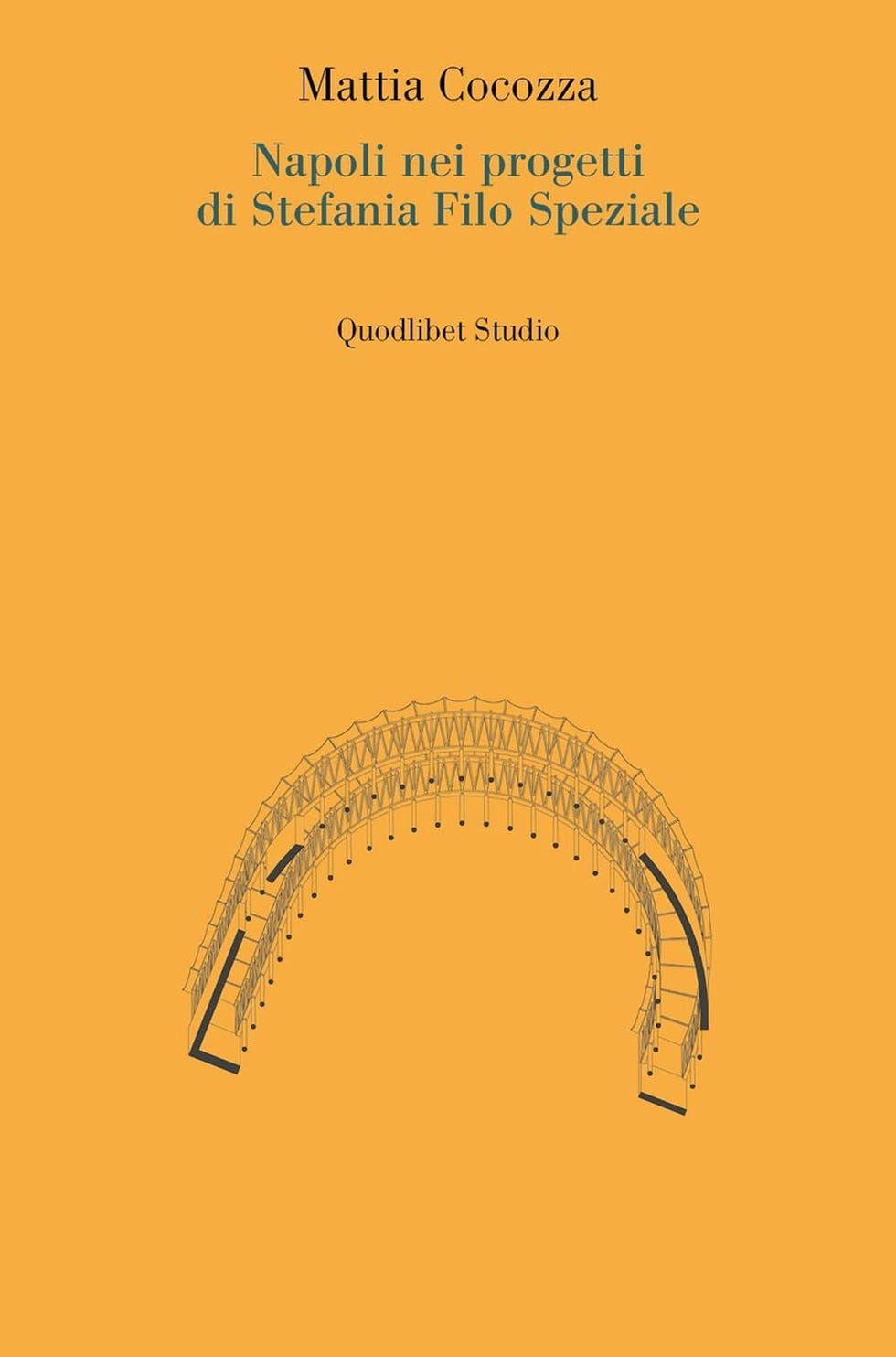 Germano Celant. Cronistoria di un critico militante, a cura di Studio Celant
Germano Celant. Cronistoria di un critico militante, a cura di Studio Celant
Un contributo dovuto a Germano Celant protagonista di primo piano della scena artistica italiana e internazionale, nella veste di critico, curatore di mostre che hanno fatto storia, studioso, ideatore e autore di centinaia di pubblicazioni, cataloghi e monografie, ma anche quale responsabile di importanti istituzioni internazionali negli Stati Uniti e in Italia. A lui è dedicato il volume, edito da Skira, una raccolta degli interventi degli artisti, degli storici dell’arte, dei curatori, degli architetti, dei fotografi e dei designer che hanno partecipato alle giornate tematiche ideate dall’Accademia Nazionale di San Luca e a cura dello Studio Celant e che si sono svolte in alcune delle principali istituzioni artistiche italiane. Strumento critico di studio, spazio di confronto e approfondimento, il volume ripercorre l’attività e la vasta carriera di Germano Celant e si propone come strumento di analisi e riflessione sul percorso del critico grazie anche ai contributi di artisti, critici, architetti, collezionisti, curatori, direttori di istituzioni con cui Celant ha collaborato nel corso di oltre cinquanta anni di lavoro. Da un lato lo sguardo attento e innovativo del critico ha contribuito ad allargare l’orizzonte culturale, oltrepassando i confini tra le discipline creative, dall’altro “la sua attività si è distinta per la capacità curatoriale di tradurre in forma concreta le visioni degli artisti, spesso anticipandone o superandone le aspettative. Il suo approccio si è contraddistinto per una spiccata proattività nell’ideare e realizzare progetti espositivi di rilevanza culturale”, si legge nelle pagine introduttive. E ancora, il volume arriva a delineare differenti letture e diversi punti di vista relativi alla figura di Celant, a volte anche contraddittori, oltre a individuare le traiettorie da lui indicate, l’attualità e l’eredità della sua visione, si legge ancora nell’introduzione.
Germano Celant. Cronistoria di un critico militante
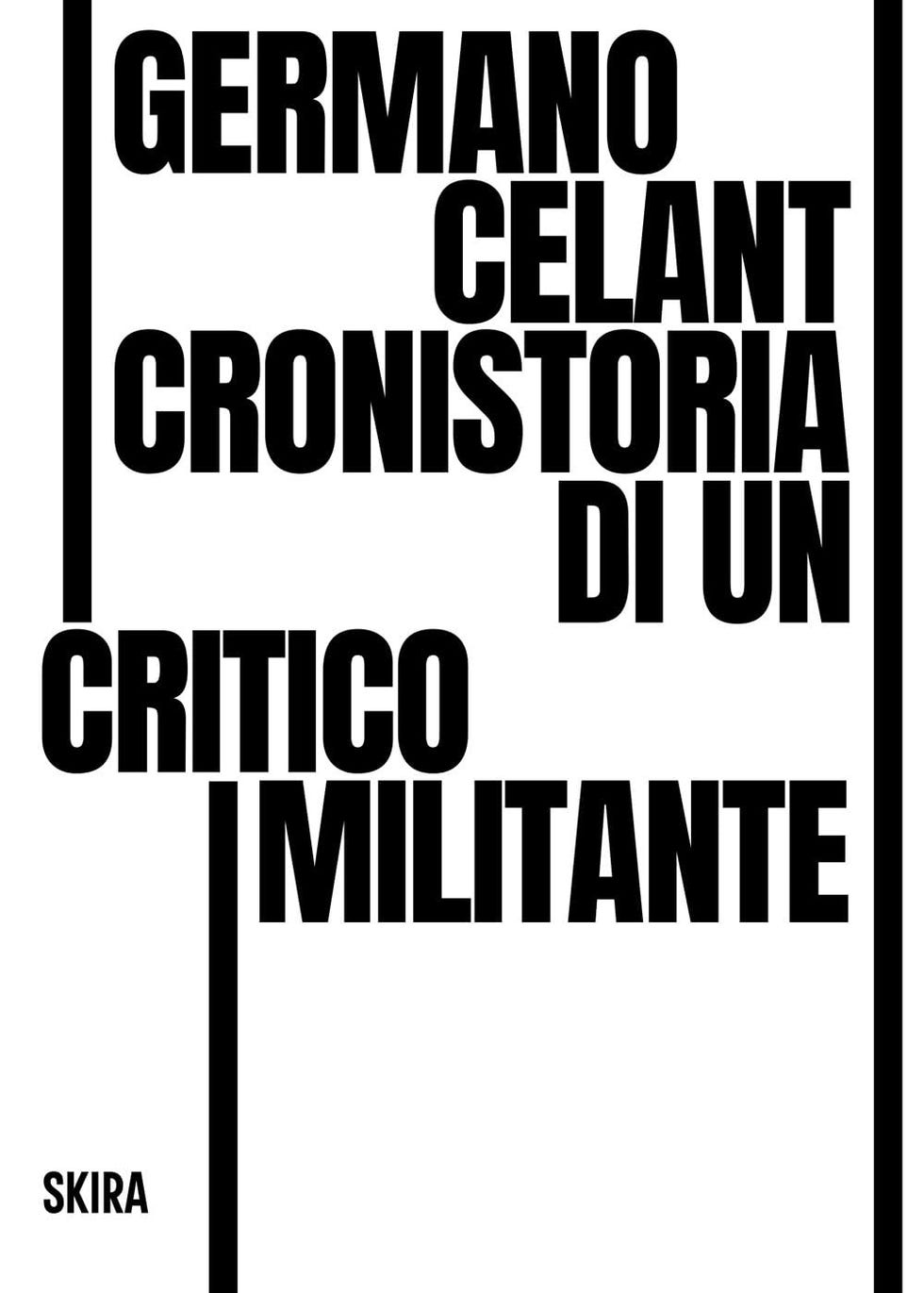 Architetture del noi, di Raul Pantaleo
Architetture del noi, di Raul Pantaleo
Entrati nell’epoca dell’Antropocene, l’era in cui l’umanità può compromettere il proprio e l’altrui futuro, diventa fondamentale agire, consapevoli di avere a disposizione risorse e tempo limitati. Sono le premesse da cui prende avvio la riflessione di Raul Pantaleo sull’architettura di questa era, supportata dal progetto dello studio di architettura TAMassociati, da lui fondato, e dall’esperienza sul campo di Emergency, una tesi ben delineata e approfondita nelle pagine del libro pubblicato da Elèuthera. “Architetture del noi” è “la cassetta degli attrezzi composta attraverso processi di distillazione e semplificazione, lavorando nella scarsità, nell’incertezza, nel bisogno, in luoghi complessi come Afghanistan, Susan, Iraq, Sierra leone, Repubblica Centrafricana, Siria, Palestina. Ha l’ambizione di mostrare come attraverso ‘architetture del noi’ è possibile prendersi cura del presente, dei luoghi che abiteremo e delle risorse che serviranno a realizzarli”, scrive il progettista. Lo studio di architettura ènato nella prospettiva di “dare forma a un altro ‘mondo possibile’ sperimentando architetture del noi che fossero rappresentazione di economie non monetarie e che superasse un’ottica individualistica in favore di una visione cooperativa. Architetture in risonanza con le persone che le avrebbero abitate, attraverso relazioni non gerarchiche e collaborative capaci di trovare modalità di intelligenza collettiva. Per anni siamo stati ai margini, minoranza politica e culturale nel mondo dell’architettura”, prosegue Pantaleo. Ma la contemporaneità richiede un modello corale, che utilizzi un approccio progettuale cooperativo incentrato sul noi, abbandonando l’io individualista e autoriale. Ecco, dunque, che il racconto procede delineando parole chiave e concetti come comunanza, partecipazione, attivismo, azione, riconciliazione, parsimonia, pareidolìa, parlamentare, bellezza. Ma soprattutto dono: il futuro potrà essere realizzato anche e in particolare attraverso una ritrovata cultura del dono, una delle poche azioni rivoluzionarie del nostro tempo e, poiché privo di uno scopo commerciale, in grado di scardinare l’imperante logica del profitto. Il libro racconta architetture del noi intese come azioni di servizio e dono. È politica, collaborativa e libertaria, azione per creare luoghi di riconciliazione e giustizia. “L’unico investimento che dobbiamo al nostro futuro”.
Architetture del noi
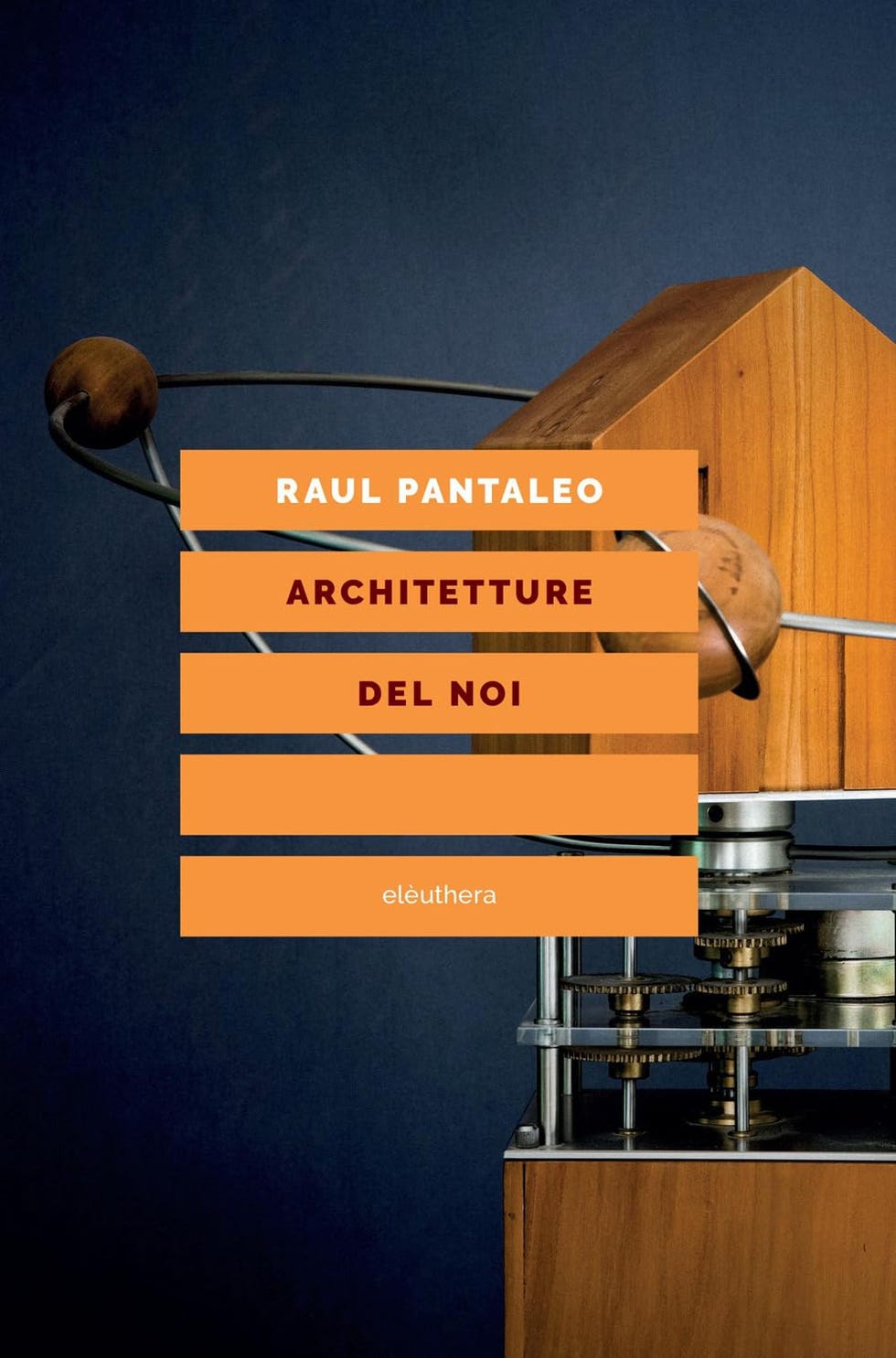 Alfredo Jaar – Inferno & Paradiso
Alfredo Jaar – Inferno & Paradiso
Il libro fotografico, edito da L’Artiere, è dedicato al progetto espositivo “Inferno & Paradiso” di Alfredo Jaar, presentato al festival internazionale di fotografia ‘Cortona On The Move’, rivolto a esplorare le fratture del mondo: “rivela esplicitamente ciò che ci divide (Inferno) e ciò che ci unisce (Paradiso). Quando impareremo a vivere insieme?” è la riflessione dell’artista. Jaar ha chiesto a 20 dei più influenti fotoreporter di oggi di selezionare due immagini dal loro archivio, la più terrificante che avessero mai scattato, “quella che aveva procurato loro degli incubi”, e un’immagine che avesse invece restituito grandissima gioia. Immagini di crudeltà impensabili compongono la sezione ‘Inferno’ seguite da rari scorci di speranza che si svelano nel capitolo Paradiso, mostrando lo scenario del nostro tempo, abitato dal conflitto e dall’ipocrisia. La serie di immagini raccolte “dimostra che non abbiamo bisogno di cercare l’inferno e il paradiso su un altro pianeta o in un tempo in cui il mondo scomparirà. Inferno e paradiso non sono luoghi, ma forme, modi di essere in questo mondo e la Terra oscilla costantemente tra questi due opposti, si legge nell’intenso contributo di Emanuele Coccia. Richiamando la missione dell’arte, “Inferno & Paradiso è un esercizio di equilibrio impossibile, tra il mondo che è e il mondo che potrebbe essere. È un’illusione. Ma questo è il compito dell’artista: creare modelli per reimmaginare il mondo”, scrive nell’epilogo Jaar. Contributi fotografici di: Samar Abu Elouf, Lynsey Addario, Motaz Azaiza, Maxim Dondyuk, Véronique de Viguerie, Abdulmonam Eassa, Ghouta Orientale, Donna Ferrato, Olivier Jobard, Johanna-Maria Fritz, Bülent Kilic, Alice Martins, Finbarr O’Reilly, Lorenzo Meloni, Darcy Padilla.
Inferno & Paradiso. Ediz. inglese
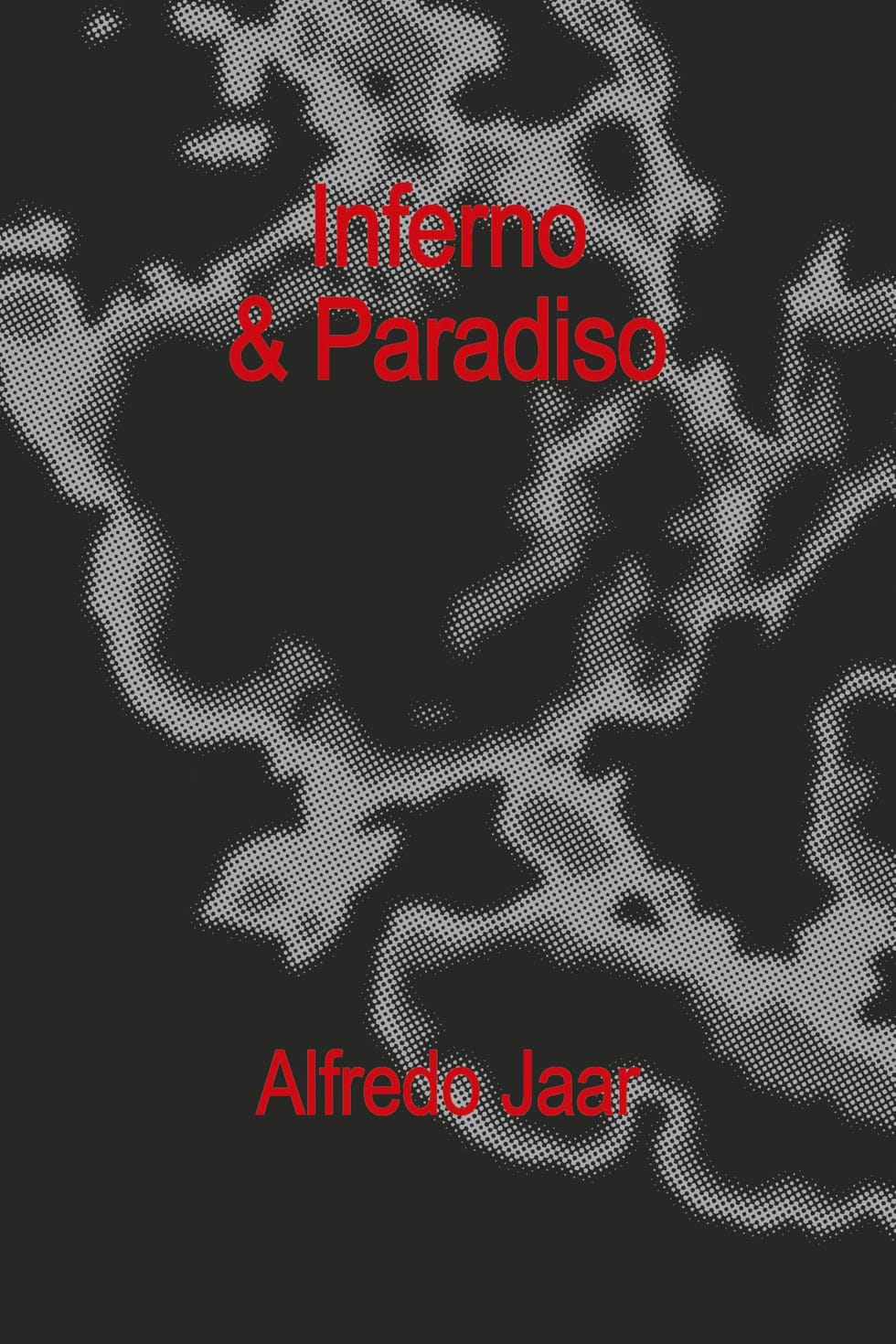 Architectural Theory. Pioneering Texts on Architecture from the Renaissance to Today
Architectural Theory. Pioneering Texts on Architecture from the Renaissance to Today
Da inserire assolutamente nella biblioteca di ogni progettista. L’elegante volume rilegato, edito da Taschen, ripropone i trattati che più hanno influenzato il pensiero architettonico e la storia delle costruzioni, dal Rinascimento a oggi. Scorrono nelle pagine, completate da un ricco apparato iconografico e organizzate cronologicamente per paese, le teorie dei più grandi maestri dell’architettura, italiani e non, da Leon Battista Alberti ad Andrea Palladio, da Iacomo Barozzi da Vignola a Giovanni Battista Piranesi fino al lavoro di Rem Koolhaas, ognuno accompagnato da un saggio che lo pone in relazione con il contesto storico e ne delinea il significato.
Architectural Theory. Pioneering Texts on Architecture from the Renaissance to Today
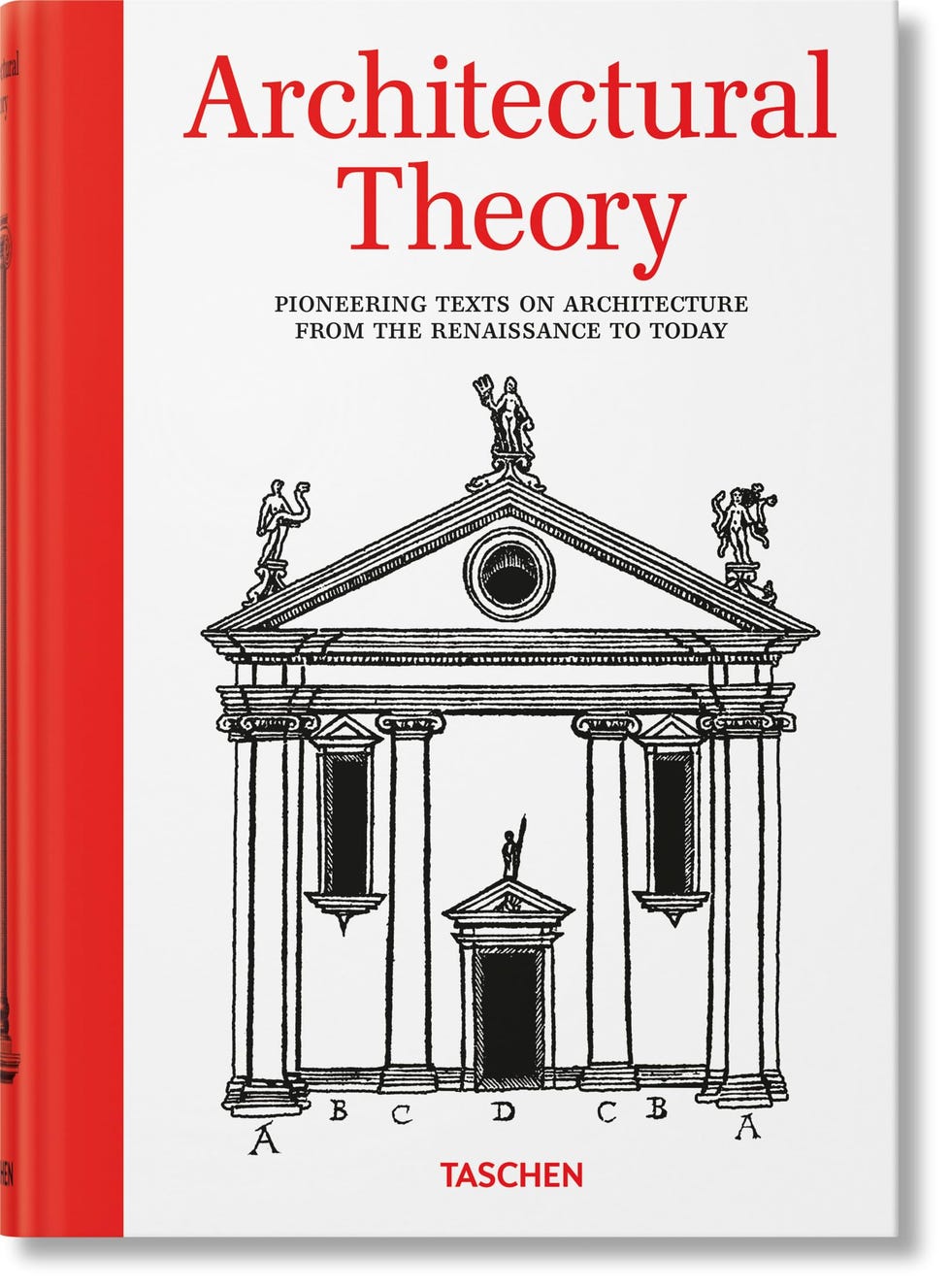 Fare una mostra, di Hans Ulrich Obrist
Fare una mostra, di Hans Ulrich Obrist
Utet ripubblica “Fare una mostra”, un testo uscito nel 2014 (traduzione di “Way of curating”) di Hans Ulrich Obrist, critico e storico dell’arte, direttore artistico della Serpentine Gallery a Londra, considerato tra i curatori d’arte più influenti al mondo. Il volume è un racconto autobiografico, appassionato e concreto, che intreccia ricordi personali e professionali inerenti la sua attività nel campo dell’arte, esprime teorie, pratiche e incuriosisce con esperienze e aneddoti che ruotano attorno all’attività di curatela e al fare mostre. Per l’autore, il mestiere del curatore combina in un unico ruolo attività ancora ben espresse dal significato della sua radice latina, curare, prendersi cura di, e “compito del curatore è fare in modo che elementi diversi entrino in contatto fra loro, un tentativo d’impollinazione fra culture, o un modo di disegnare mappe, che schiude percorsi nuovi attraverso una città, un popolo o un mondo”, scrive Obrist nelle pagine del libro. Così come collezionare è un metodo per produrre conoscenza. Ma “Fare una mostra” riprende anche la formazione culturale e l’evoluzione professionale dell’autore, gli incontri e le conversazioni, brillanti e mai convenzionali, con gli artisti, gli scrittori e gli intellettuali con cui Obrist è entrato in contatto, i suoi modelli e ispiratori (come l’impresario teatrale Sergej Djagilev, fondatore dei Ballets Russes, e Robert Walser, scrittore modernista: “due eroi” per Obrist), tutti tasselli dell’intenso suo percorso artistico. Dalla prima visita agli artisti Fischli e Weiss – è proprio nel loro studio dove è “nato”, lì ha deciso che voleva diventare curatore, iniziando a sviluppare una coscienza critica – all’incontro con Alighieri Boetti, che subito gli trasmette come il senso del mestiere di curatore possa essere quello di rendere possibili cose impossibili. “È stato una rivelazione perché mi ha fatto capire che nel lavoro con gli artisti c’erano tanti orizzonti ancora da esplorare”, e dalle conversazioni con Boetti derivano i primi tentativi di integrare le esposizioni d’arte esistenti creando format nuovi. A questo proposito, nel volume si parla della prima mostra del 1991, World Soup (The Kitchen Show) realizzata nella sua cucina di San Gallo, così come di “Do It Yourself”, un progetto espositivo dove le opere non avevano un carattere statico, ma mutavano a ogni nuovo allestimento. L’ultimo capitolo è dedicato ai giovani, ‘curatori del futuro’, mentre chiude il volume un ritratto di Hans Ulrich Obrist di Gianluigi Ricuperati. Traduzione di Marina Astrologo.
HANS ULRICH OBRIST FARE UNA MOSTRA
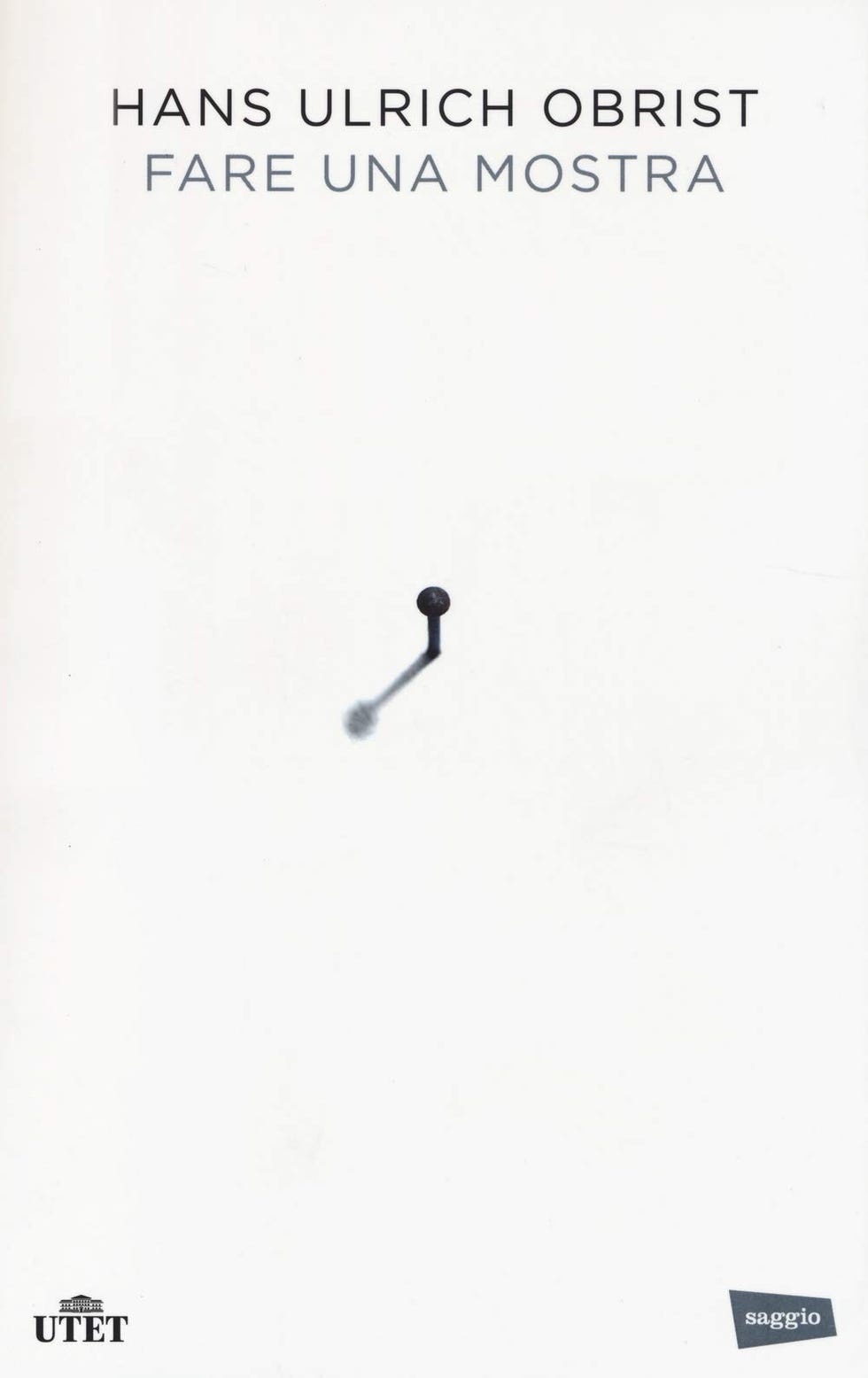 Il design e il suo doppio, a cura di Giovanni Innella e Marco Petroni
Il design e il suo doppio, a cura di Giovanni Innella e Marco Petroni
“Provare l’attraversamento, l’essere dentro e allo stesso tempo fuori. Stare nel progetto ma anche nel suo doppio, o forse essere positivi ma anche negativi, nessuna dualità, nessuna ambiguità, solo essere, stare, fare nel mondo, ai margini e al centro”. Usa queste parole Marco Petroni, nell’introduzione a “Il design e il suo doppio” pubblicato da Posmediabooks, un libro che ha la “forma di un soffio, di qualcosa che tenta di s-fuggire da ciò che normalmente intendiamo o vogliamo considerare design”, un tentativo di provare a rispondere alla domanda su cosa sia o cosa possa rappresentare il doppio di una disciplina, di un’azione, nel mondo che possiamo definire design, progetto, desiderio di trasformazione. “È un modo di attraversare una poetica, una forma di essere designer nel 2025”, spiega bene Petroni. Per farlo in modo concreto ecco allora che il testo si focalizza sulla produzione, la progettazione, l’essere di Giovanni Innella, un designer del nostro tempo strambo, un archetipo in crisi e in radicale trasformazione. È una figura di progettista atipico, con un’attitudine che cerca di sfuggire a classificazioni e a gabbie concettuali, confermando la scelta di volere essere dentro le cose, dentro un’idea di design, di progetto che si alimenta di musica, di letteratura, di cinema. Innella vede “il progetto come ecosistema simbiotico e coagulante dove far convivere strane alleanze tra i linguaggi e le discipline”, abbraccia una moltitudine di potenzialità espressive, che siano fisiche o concettuali, quindi attraversa sentieri, intrecci, ipotesi che si ritrovano a prendere la forma di un oggetto, di una mostra, di un articolo, di una collaborazione, di un percorso educativo. Ed è proprio questa complessità di sguardi e visioni a essere restituita ne “Il design e il suo doppio”, tentativi aperti al coinvolgimento di una potenziale comunità che progetta il proprio modo di stare al mondo. Le pagine, quindi, svelano mondi, paesaggi, persone, sguardi con cui Giovanni Innella ha avuto modo di confrontarsi in maniera più o meno profonda. Sono tre i capitoli del libro in cui varie voci commentano, tracciano assonanze e peculiarità che emergono dalla produzione di Innella. Il primo capitolo “ha la funzione di inquadrare il percorso educativo e le iniziali ricerche , sottolineando come è l’idea stessa di design a essere messa in questione attraverso un’analisi approfondita delle sue componenti creative e comunicative”, scrive ancora Petroni. Il secondo capitolo è la presa d’atto, di fronte all’era dell’Antropocene, di nuove questioni, di nuovi problemi da attraversare con gli strumenti del progetto. E negli oggetti, performance, installazioni di Innella si possono cogliere le nuove traiettorie progettuali. Il terzo capitolo è una raccolta di product design, progetti di oggetti, di elementi d’arredo in produzione, una genealogia di testimonianze che possono essere raccontate come un processo di emancipazione. Contributi di: Louise Schouwenberg, Gijs Bakker, Craig Bremner, Elio Caccavale, Justin McGuirk, Silvio Lorusso, Barbara Visser, Martina Muzi, Zoë Ryan, Emanuele Quinz, Noora Abdulmajeed, Rim Albahrani, Vittorio Venezia, Domitilla Dardi, Bianco-Valente, Elena Dellapiana, Paul A.Rodgers, Katharina Mischer, Thomas Traxler, Tommaso Bovo
Il design e il suo doppio

