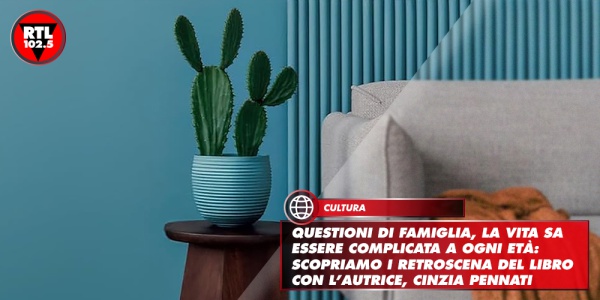Si apre un nuovo fine settimana tra le pagine web di RTL 102.5, e si rinnova l’appuntamento con il mondo dei libri. Un universo fatto di storie che si muovo in tanti modi diversi, e che solleticano il palato di tantissimi lettori pronti a immergersi negli ecosistemi narrativi confezionati da autori e autrici.
Se la domenica su queste pagine trova spazio la rubrica dedicata alle novità più interessanti in fatto di libri, il sabato ci concentriamo su una singola storia specifica, grazie alle voci di chi a quei racconti ci ha lavorato. Come nel caso de “La fortuna del principiante” di Valerio Marra, o ancora di “Figlie Selvagge” di Cinzia Giorgio, giusto per citare gli ultimi due approfondimenti.
Oggi sotto la lente d’ingrandimento ci finisce “Questioni di famiglia”, il romanzo di Cinzia Pennati edito da Sperling & Kupfer. E proprio con lei abbiamo fatto un’interessante chiacchierata che ci ha permesso di saperne di più della storia e dei personaggi che si muovono tra le pagine del libro.
QUESTIONI DI FAMIGLIA, LA COMPLESSITÀ DEI RAPPORTI INTERPERSONALI
Ciao Cinzia, aprirei le danze dandoti subito la parola per introdurci al mondo di “Questioni di Famiglia”: cosa troviamo all’interno del libro?
“Troviamo una storia che parla di relazioni, di coppia, di rapporti genitoriali e filiali ma anche di rapporti intergenerazionali. Troviamo la narrazione di una famiglia, la famiglia De Santis– come ce ne sono tante –piena di contraddizioni e di dubbi. Una famiglia i cui componenti, nonostante si vogliano bene, devono cercare di fare i conti con la verità e, soprattutto, con il proprio passato, per poter capire come amarsi davvero. La ricerca della felicità è sempre un viaggio, lungo e difficile, ma comunque un viaggio che vale la pena di essere vissuto, ognuno con la propria storia da raccontare.
“Questioni di Famiglia” è, prima di tutto, un romanzo che parla di realtà, di quelle verità che troppo spesso restano chiuse tra le mura domestiche, dietro sorrisi stanchi e ruoli imposti. Dentro il libro troviamo vite imperfette, relazioni complicate, ma anche un’enorme forza: quella dell’amore, appunto, che non è mai semplice o lineare, ma è ciò che ci tiene in piedi, anche quando tutto sembra sfaldarsi. Ma dentro ci sono anche tanta tenerezza, ironia, e quella sorellanza che non è solo legame di sangue, ma scelta quotidiana di alleanza tra donne. Ci sono le piante grasse che diventano un simbolo potente di resistenza e adattamento. Ci sono i figli, che con i loro occhi obbligano gli adulti a rivedere tutto. E ci sono le madri, con la loro presenza a volte schiacciante, a volte salvifica.”
Si può dire che nella storia ci siano quattro generazioni di personaggi a confronto, ognuno con il proprio modo di essere e con il proprio vissuto. Quanto lavoro è stato necessario per dare ogni sfumatura a tutti i personaggi?
“Sì, nella storia si intrecciano effettivamente quattro generazioni. Dare voce e profondità a ogni personaggio ha richiesto un lavoro stratificato, perché ciascuno porta con sé un vissuto specifico, un sistema di valori e una propria battaglia interiore. Amanda, con la sua irrisolutezza e il bisogno di affermarsi, vive il conflitto tra aspettative sociali e desideri personali. Sua madre Anna, figura silenziosa ma centrale, incarna un’altra generazione, cresciuta nel sacrificio e nel silenzio, in un contesto in cui il dovere verso la famiglia veniva prima di tutto, anche a costo di reprimere sé stesse.
Le sorelle, pur diverse da Amanda, servono a rafforzare il senso di inadeguatezza che lei prova, rappresentando modelli apparentemente riusciti secondo i canoni familiari o sociali. Infine, i più giovani, come Teo, incarnano un nuovo modo di relazionarsi al mondo: più diretto, più emotivamente sincero, meno intrappolato nelle convenzioni e più reale proprio perché raccontato nella friabilità dell’adolescenza. Il lavoro sui personaggi è stato quindi soprattutto un lavoro di ascolto: delle loro voci interiori, che sono le voci delle persone che incontro, delle donne che hanno costruito una comunità intorno al blog e alle mie pagine. Ogni personaggio è stato costruito con cura per riflettere la complessità dei legami familiari e delle identità femminili in diverse fasi della vita.”
UNA STORIA, DUE VOCI
La storia vive attraverso due narrazioni che si sviluppano in parallelo, con eventi che vengono inquadrati da prospettive diverse. È stata una decisione maturata per parlare a un pubblico di ogni età? In questo modo è relativamente facile riconoscersi in uno dei due personaggi…
“Desideravo far comprendere che, a volte, all’interno delle relazioni famigliari, nonostante si abiti la stessa storia si hanno delle percezioni diverse, dei vissuti diversi e che, entrambi debbano avere la stessa dignità. A volte non c’è un giusto e sbagliato ma semplicemente come abbiamo percepito quella data esperienza…La scelta di costruire la storia attraverso due narrazioni parallele – quella di Amanda e quella di sua madre – è stata pensata proprio per creare un ponte generazionale che potesse parlare a lettori di età diverse. Ogni voce offre uno sguardo unico, ma complementare, sugli stessi eventi, sulle dinamiche familiari e sulle ferite, esplicite o silenziose, che attraversano il tempo.
Amanda rappresenta una generazione “di mezzo”, sospesa tra il peso delle aspettative ereditate e la difficoltà di affermare un’identità propria. È una donna che cerca di trovare un equilibrio tra maternità, carriera e relazioni, in un contesto emotivo spesso caotico. Sua madre, invece, è il volto di una generazione cresciuta nel sacrificio, nel dovere e nel silenzio: una figura solida, ma attraversata da un passato mai davvero elaborato, che continua a farsi sentire anche nel presente.
Mettere a confronto queste due voci permette al lettore non solo di vedere la complessità della storia da prospettive diverse, ma anche di riconoscersi più facilmente in una delle due protagoniste – o magari in entrambe, a seconda della propria età, esperienza o sensibilità. C’è chi potrà sentirsi vicino al senso di smarrimento di Amanda, chi invece comprenderà profondamente la malinconia sommessa e i rimpianti della madre. E in questo gioco di specchi tra generazioni, si apre uno spazio di riflessione universale, che parla della difficoltà di essere madri, figlie, donne, persone. Come scrivo nel romanzo: ci si accorda all’esistenza solo venendo a patti con il passato.”
Nel libro hai dato molta importanza al mondo vegetale, in particolar modo a quello delle piante grasse. Come mai questa scelta?
“La scelta di dare spazio alle piante grasse è stata dettata dal fatto che sono le uniche a resistere nelle mie mani, diciamo che ho un pollice piuttosto nero! A parte gli scherzi, ovviamente, la scelta non è casuale: è un elemento simbolico che attraversa in profondità il romanzo. Le piante grasse sono resilienti, capaci di sopravvivere in ambienti ostili, di trattenere dentro di sé l’essenziale, anche quando all’esterno tutto sembra arido. In questo senso possono rappresentare una meravigliosa metafora, anche noi, come loro, nonostante le delusioni, un passato, magari, complicato, possiamo andare avanti e fiorire.
La serra in cui Anna coltiva queste piante diventa un luogo segreto di libertà e autenticità, un rifugio in cui può finalmente essere sé stessa, lontana dai ruoli e dalle richieste familiari. È anche un terreno di incontro inaspettato con Teo, il nipote adolescente, con cui riesce a costruire un legame profondo proprio attraverso questa passione condivisa. In un contesto familiare dove i dialoghi sono spesso tesi o mancati, il mondo vegetale offre un linguaggio alternativo, fatto di cura, attesa e silenziosa presenza. Le piante grasse, quindi, sono il cuore pulsante di una simbologia che parla di sopravvivenza emotiva, di bellezza discreta, di forza nascosta.”
Domanda di rito dallo spirito radiofonico: se il tuo libro fosse una canzone, quale sarebbe?
““C’è Tempo” di Ivano Fossati.”
Hai già altre storie pronte a essere impresse su carta? Qualche progetto di cui si può già parlare o qualche idea che ti piacerebbe mettere in cantiere?
“Sì, vorrei raccontare una grande storia d’amore. Perché l’amore, per quanto mi riguarda, quello che parla di uguaglianza e non di sottomissione, è un atto femminista e politico. Non è una faccenda privata ma una questione sociale. L’amore ci può trasformare, ci può dare la forza di opporci a qualsiasi dominazione. E ognuno di noi deve viverlo, non secondo costrutti sociali che servono al sistema economico e sociale del nostro Paese, ma al proprio sentire. E quel sentire deve avere tutta la dignità che merita.”