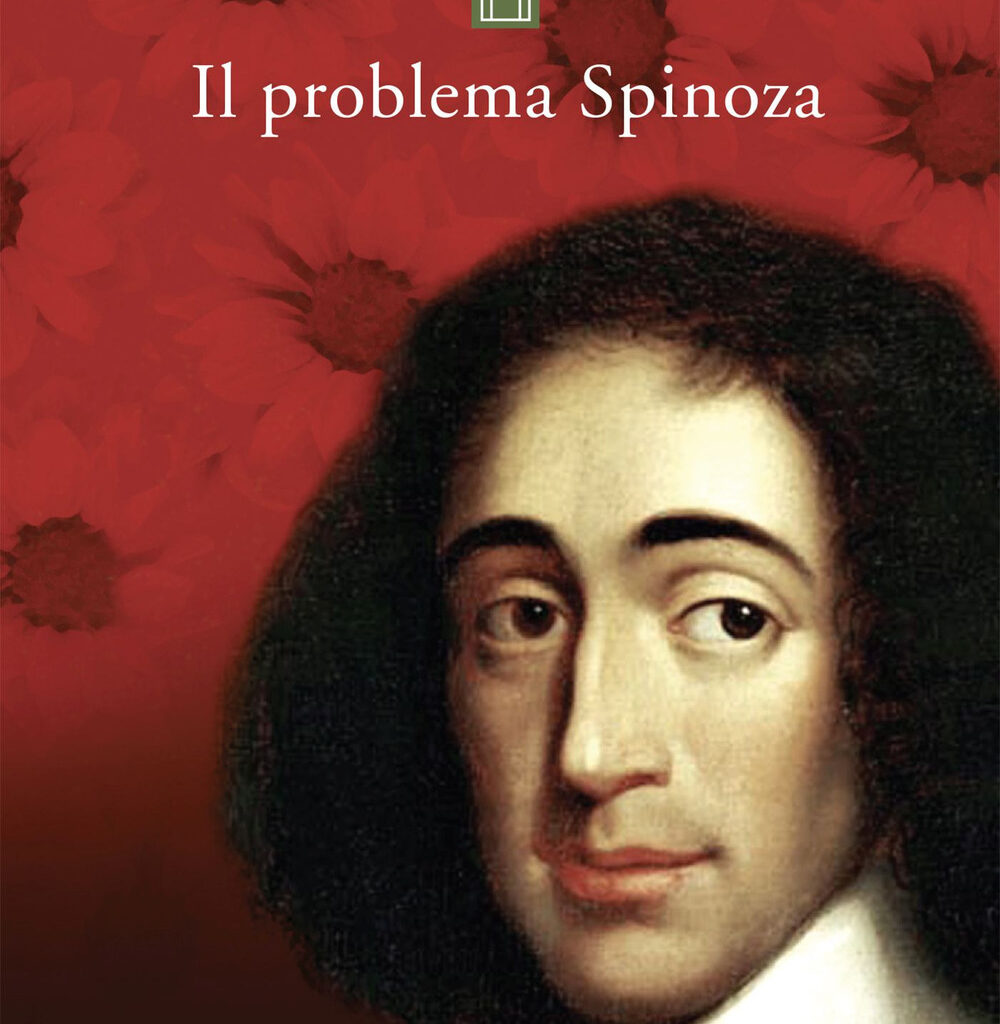Assieme a Le lacrime di Nietzsche e a La cura Schopenhauer, Il problema Spinoza fa parte di una trilogia di romanzi di Irvin D. Yalom edita da Neri Pozza, in cui le trame raccontano di possibili vicende che hanno come protagonisti le tre figure di spicco della filosofia e della cultura mitteleuropea, calate nel contesto del tempo e dei loro riflessi sul Novecento, basandosi su documenti e fatti storici, attraverso lo strumento offerto dalla psicoterapia a cui Yalom ha dedicato la sua lunga vita professionale ed accademica.
In una successione di capitoli alternati per soggetto – ad uno sul grande filosofo Baruch-Bento Spinoza dal 1656 in poi, ne segue uno su Alfred Rosenberg, ideologo e stretto collaboratore di Hitler, a partire dal 1910 – l’autore immagina lo svolgersi fattuale e psicologico della vita dei due personaggi, che potremmo dire imperniata sul dilemma dell’appartenenza e/o dell’esclusione dalla comunità di riferimento. Si tratta di asimmetriche, esistenziali necessità di appartenere alla collettività, per esserne protetti ed amati, in lotta con quelle di distinguersene, diversificarsi, fuggire, come anelito di libertà e supremazia.
«Non sono più un Ebreo» è una frase che Bento Spinoza sente echeggiare con un brivido nella mente, dopo la scomunica dalla vita religiosa e comunitaria. «Una vita fuori a guardare dentro» è il titolo che Rosenberg pone a sigillo della sua vita spesa a cercare di essere parte di qualcosa, nonostante i suoi “grandi” e agghiaccianti successi di carriera nel nazismo. Il legame tra i due, che dà luogo al titolo, è il “problema Spinoza”, che tortura Alfred Rosenberg.
Estone-tedesco, il giovane Alfred, timido, isolato dai compagni di studio, rancoroso, senza amici e maestri riconosciuti, sviluppa nel mito – costruito sull’odio antisemita, per la purezza della razza tedesca – l’ideale della comunità a cui vorrebbe appartenere e in futuro guidare, ma viene colpito dal pensiero complesso di Spinoza, che deve studiare al liceo per punizione nel 1910. Uno dei suoi miti di supremazia della cultura ariana è Goethe, che nei suoi scritti si dichiara fervente ammiratore del pensiero di Spinoza.
Diventa così un tormento: come ha potuto questo «emblema del popolo tedesco» aver tratto ispirazione da un uomo di «razza inferiore»? In cosa risiede la genialità di «questo ebreo»? Nella mente, forse nella sua biblioteca, un feticcio sul quale Rosenberg riuscirà a mettere le mani, in una delle razzie ordinate dai nazisti?
Nel “contempo” del romanzo, nel 1656, il giovane Spinoza – ebreo fuggito con la famiglia dal Portogallo e dall’Inquisizione spagnola per stabilirsi nella tollerante Olanda, ad Amsterdam – vive integrato nella comunità ebraica, per rispetto della sua famiglia e delle sue sorprendenti doti e capacità di studio dei testi sacri e tradizionali della loro cultura, nonché di greco e latino e filosofia. Ma sempre più in disparte. Il suo pensiero lo porta a porre in dubbio la veridicità dei testi sacri, indicando come metafore le verità affermate, sottoponendole alla verifica attraverso l’analisi testuale con l’esercizio della ragione, in quanto tutto è legato in natura dal meccanismo di causa-effetto, che è strumento di verifica della prova di un fatto. E giunge ad identificare Dio con la Natura, ad affermare l’immanenza della vita, a negare la vita dopo la morte.
Questo lo porta alla scomunica, alla cacciata dal quartiere ebreo e dalla famiglia, con un doloroso processo che, mentre lo addolora per non farne più parte, gli dà una sensazione di libertà dalle costrizioni del pensiero e delle convenzioni. Troverà un «luogo sicuro» in un villaggio, dividendosi tra l’attività di intagliatore di lenti, di pensatore e di maestro di un cenacolo di seguaci che si riuniranno attorno alla sua modesta casa, dove prende forma la biblioteca (il cui destino complesso si svelerà) mentre sviluppa e scrive la sua opera filosofica, poi messa all’indice anche dalla Chiesa Cattolica.
Con uno stile di vita volto ad un’atarassia emotiva e pratica, dalle parche consuetudini, gli rimarrà il pensiero e il ricordo della possibile “appartenenza” che gli è stata negata, come conseguenza del suo anelito di libertà intellettuale. L’autore, integrando le vicende storiche con fatti e attendibili personaggi di fantasia, con la sua perseverante attenzione alle vicende culturali europee e al loro nesso con la cultura e la storia ebraica, realizza un romanzo affascinante e coinvolgente che offre numerosissimi spunti di riflessione e approfondimento.