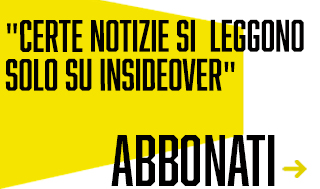Negli Stati Uniti la sanità militare è sempre stata considerata una componente di supporto: salvare i propri soldati, sostenere le missioni in zone di guerra, garantire la prontezza operativa. Ma il mondo post-pandemico ha cambiato radicalmente questa prospettiva. Oggi, gli ospedali da campo, le navi-ospedale e le squadre mediche speciali non sono solo strumenti di soccorso: sono leve di potere e influenza. Nel linguaggio dei think tank americani, si parla di medical soft power, un concetto che unisce la capacità di curare alla possibilità di plasmare relazioni politiche. In contesti di crisi — siano essi un’epidemia in un Paese fragile, un tifone che devasta un’isola strategica o un conflitto che paralizza il sistema sanitario locale — arrivare per primi significa dettare i tempi dell’agenda e guadagnare la fiducia delle popolazioni e dei governi. Questa fiducia, una volta conquistata, può tradursi in accesso privilegiato alle basi, influenza nei negoziati e visibilità positiva in aree dove la competizione con altre potenze, in particolare Cina e Russia, è serrata.
Il toolkit: capacità mobili e proiezione globale
La proiezione sanitaria militare americana si fonda su quattro asset principali. Le navi-ospedale — USNS Comfort e USNS Mercy — sono vere e proprie città galleggianti della salute: ognuna dispone di centinaia di posti letto, sale operatorie, reparti di terapia intensiva, laboratori diagnostici e capacità di telemedicina. La “Comfort”, con la missione Continuing Promise, ha percorso nel 2025 migliaia di miglia nei Caraibi e in America Latina, offrendo cure a migliaia di pazienti e organizzando corsi di formazione con medici locali. La “Mercy”, invece, ha appena concluso la Pacific Partnership, toccando arcipelaghi vulnerabili del Pacifico e fornendo sia assistenza medica diretta sia interventi infrastrutturali come la riparazione di scuole e cliniche.
A terra, le Expeditionary Medical Facilities possono essere schierate in meno di una settimana. Sono modulari, scalabili e progettate per operare in ambienti privi di elettricità stabile, acqua potabile o rete ospedaliera. Nell’Africa occidentale e settentrionale, queste strutture sono state utilizzate nell’ambito di esercitazioni multinazionali come African Lion, dove la componente sanitaria è stata integrata con formazione per il personale medico locale, vaccinazioni e screening.
Il terzo asset è l’aero-evacuazione medica ad alta biosicurezza. Con il Transport Isolation System, sviluppato dopo l’epidemia di Ebola, gli Stati Uniti possono trasferire pazienti altamente infettivi su aerei militari come i C-17, mantenendo l’isolamento e la continuità terapeutica durante il volo. È una capacità unica, che consente non solo di salvare vite ma di intervenire anche in contesti in cui nessun altro Paese potrebbe garantire un trasporto sicuro.
Vuoi ricevere le nostre newsletter?
Infine, il quarto pilastro è la logistica globale. Il Pentagono dispone di catene di fornitura capaci di portare apparecchiature mediche, farmaci e personale in qualunque parte del mondo in tempi rapidissimi. Questa capacità logistica — spesso invisibile agli occhi dell’opinione pubblica — è il vero “moltiplicatore” dell’efficacia sanitaria militare americana.
La catena di comando: USAID e DoD
Sulla carta, le operazioni di assistenza umanitaria all’estero sono guidate da USAID, l’agenzia governativa per lo sviluppo internazionale. È USAID che decide dove e quando inviare i team di risposta rapida (Disaster Assistance Response Teams), coordina con le ONG e gestisce i rapporti con i governi locali. Il Dipartimento della Difesa entra in gioco quando serve il “peso” operativo: capacità logistica, trasporti strategici, sicurezza e — nei casi di disastri sanitari complessi — personale medico militare.
Questa divisione dei ruoli è sostenuta anche da linee di bilancio specifiche, come l’OHDACA (Overseas Humanitarian, Disaster and Civic Aid), che finanzia le missioni militari a carattere umanitario. Ma nella pratica, le emergenze reali spesso ridisegnano la gerarchia: quando il fattore tempo diventa critico e i mezzi civili non bastano, è il Pentagono a prendere il comando operativo di fatto, lasciando a USAID un ruolo di regia strategica.
Il caso dell’epidemia di Ebola in Africa occidentale, tra il 2014 e il 2016, è considerato dagli esperti un punto di svolta. All’epoca, USAID attivò una delle sue più grandi DART, mentre il Pentagono lanciò “Operation United Assistance”, inviando migliaia di militari per costruire centri di trattamento, ospedali da campo e laboratori diagnostici. Oltre 1.500 operatori sanitari locali vennero addestrati in poche settimane, mentre le unità di trasporto ad alta biosicurezza permettevano di evacuare operatori infettati in condizioni di sicurezza.
Quell’operazione dimostrò che la combinazione tra il know-how civile di USAID e la capacità di mobilitazione militare del DoD poteva cambiare il corso di una crisi sanitaria globale. È da lì che nasce l’attuale modello di “diplomazia sanitaria” militare: interventi rapidi, visibili, altamente tecnologici, capaci di stabilizzare aree fragili e di costruire capitale politico.

Nel Pacifico, la Pacific Partnership è molto più di una missione medica: è un’iniziativa di costruzione di alleanze. Ogni tappa è pensata per rafforzare la cooperazione con Paesi strategici, contrastando la crescente influenza cinese nella regione. Le attività non si limitano alle cure: includono la ricostruzione di infrastrutture, esercitazioni di risposta ai disastri e formazione del personale sanitario locale.
Nell’Africa sub-sahariana, programmi come African Lion combinano esercitazioni militari convenzionali con moduli di assistenza medico-civile. L’obiettivo non è solo addestrare i partner africani alla gestione dei traumi da combattimento, ma anche migliorare le loro capacità di risposta sanitaria civile. Questo doppio binario — militare e umanitario — aumenta l’interoperabilità e consolida legami di fiducia. Nell’emisfero occidentale, la Continuing Promise è pensata per rafforzare la presenza americana nei Caraibi e in America Latina, regioni dove la concorrenza geopolitica con attori come la Russia (in Venezuela e Cuba) e la Cina è in crescita. L’assistenza sanitaria diventa così anche uno strumento per contrastare narrative ostili e per rafforzare governi amici.
I rischi della militarizzazione dell’aiuto
L’uso di strumenti militari in contesti umanitari non è privo di rischi. Organizzazioni come la Croce Rossa Internazionale e Medici Senza Frontiere avvertono che la presenza militare può compromettere i principi di neutralità e indipendenza dell’azione umanitaria. In alcuni contesti, la popolazione locale potrebbe percepire l’aiuto sanitario come parte di un’agenda politica o militare, riducendo la fiducia verso operatori civili e ONG.
Inoltre, la crescente dipendenza dalle capacità del Pentagono rischia di soffocare le competenze e le risorse delle agenzie civili, creando un vuoto che solo le forze armate possono colmare. A lungo termine, questo può ridurre la resilienza dei sistemi sanitari locali, trasformando gli interventi di emergenza in una sorta di “badilata geopolitica” che sposta il problema senza risolverlo.

La diplomazia sanitaria militare funziona perché unisce due elementi: la visibilità positiva e la capacità di intervento reale. Le immagini di medici in uniforme che curano bambini o salvano vite durante un tifone hanno un impatto emotivo fortissimo, sia nelle comunità locali sia nell’opinione pubblica internazionale. Allo stesso tempo, la capacità tecnica e logistica degli Stati Uniti in questo settore è tale da garantire un vantaggio competitivo che pochi altri Paesi possono eguagliare.
Il risultato è un soft power “potenziato”, capace di aprire canali diplomatici in Paesi dove altri strumenti — come la cooperazione economica o la diplomazia tradizionale — incontrano resistenze. È una forma di influenza meno appariscente delle basi militari o degli accordi di difesa, ma non meno strategica.
Nei prossimi 12 mesi, tre indicatori diranno molto sulla direzione che prenderà questa forma di potere, anche alla luce delle vicende che hanno coinvolto USAID. Il primo è la frequenza e la portata delle missioni delle navi-ospedale: più scali e più giorni in porto significano un impegno più profondo. Il secondo è il peso della componente sanitaria in esercitazioni come African Lion: se cresce, è un segnale che la diplomazia sanitaria diventa un pilastro e non più un accessorio. Il terzo è proprio lo stato di salute di USAID: eventuali tagli o riorganizzazioni potrebbero spingere ulteriormente la bilancia verso il Pentagono, accelerando la militarizzazione dell’assistenza.