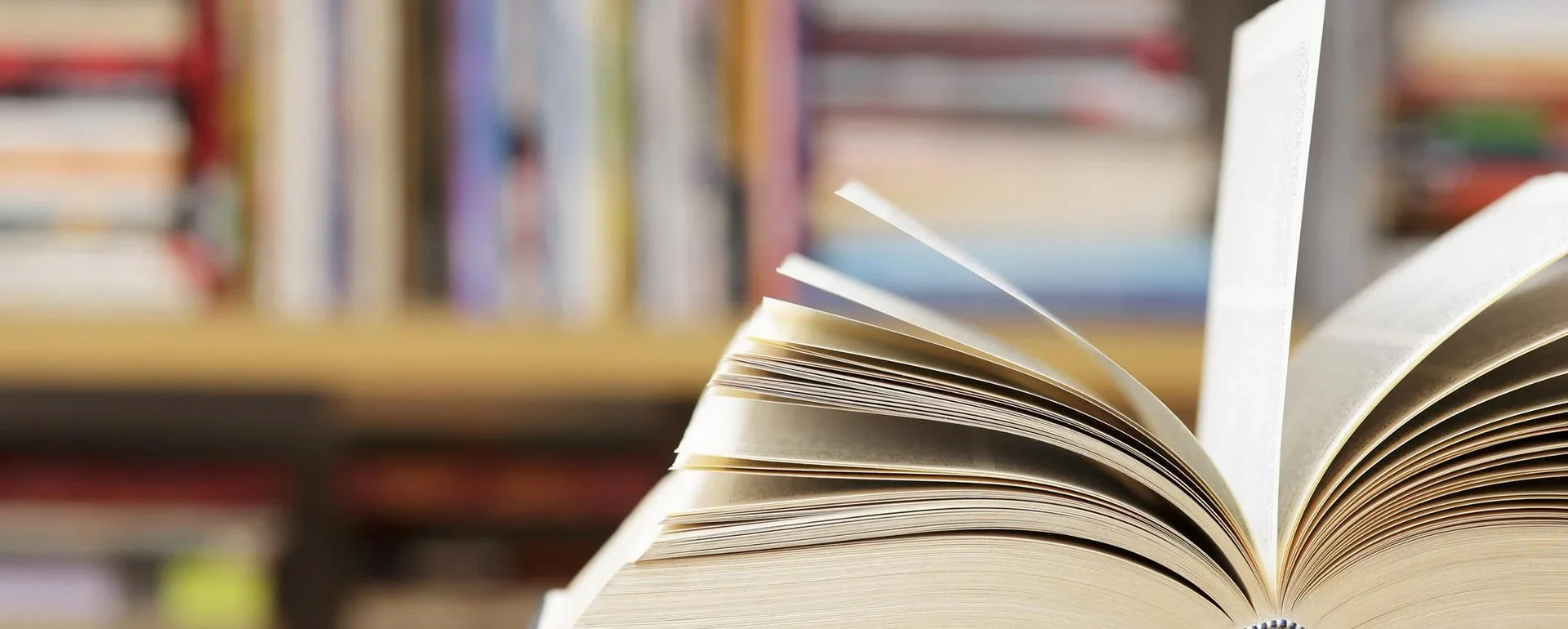Se c’è un libro di poesia che si impone come un discorso argomentativo compatto e degno di nota sul tema della migrazione, è I Corpi Santi di Giuseppe Cavaleri (prefazione di Sonia Gentili, Interno Poesia, pp. 92, euro 13), recentemente vincitore del Premio «Camaiore Proposta – Vittorio Grotti». Il titolo rimanda a un’antica zona di Milano: i Corpi Santi sono un sobborgo periferico di Milano il cui nome deriva da una leggenda secondo la quale le reliquie dei Magi si fermarono nel punto dove sorge ora la basilica di Sant’Eustorgio; da lì il nome del quartiere.
Il libro di Cavaleri si apre con una scena significativa: la linea 93 dell’Atm di Milano, da Corvetto a Lambrate, attraversa ampie zone dei Corpi Santi, tutte sospese tra il degrado sociale e la riqualificazione urbana. Su questo autobus si incrociano vite ai margini (immigrati, sbandati, persone con esistenze fragili). Tuttavia, sono proprio queste storie di persone in movimento, alla ricerca di un’esistenza più dignitosa, a portare con sé, in un mondo iper-tecnologizzato e ultra-individualista, la ventata di uno spirito popolare che resiste.
ECCO CHE ALLORA IL TITOLO, i Corpi Santi, prende tutto un altro significato: quei corpi che si mischiano ai borsoni sono veramente corpi degni di santificazione; incarnano gli storti, gli sperduti, gli spezzati che intonano la loro litania al dio dei dis-integrati, al dio dei non-integrati. Per loro, per questo soffio di forza e verità, vale la pena ripensare la nostra lingua, ma anche i meccanismi anti-democratici delle nostre democrazie. Le altre due sezioni del libro, Mareneve e L3, funzionano come una dimostrazione della tesi: l’io poetante risale a ritroso il proprio cammino da Milano fino alla Sicilia.
Qui, la campagna assolata ai piedi di un Etna costantemente in subbuglio si intreccia ai ricordi d’infanzia, all’istinto verghiano per la roba e a una doppia consapevolezza: da un lato, che il mondo esterno, un tempo visto come «un mistero di misteri smisurato», si rivela essere «un vaso di serpi non scoperchiato»; dall’altro, che è proprio imboccando la Mareneve – la strada che collega il versante nord-orientale dell’Etna ai paesi costieri – nel tentativo di «guardare le cose dall’alto», che ci si rende conto che in Sicilia «crescere non è parola che esiste».
D’ALTRONDE, nella terza e ultima sezione, un fitto tessuto di prose poetiche riavvolge ancora il tempo, spingendosi fino all’alba dell’umanità. Dal paesaggio rupestre di Pantalica l’autore coglie come il lento scorrere dell’acqua sulla roccia plasmi non solo le gole ma le abitudini stesse dell’uomo: dalla vita nelle caverne alla scoperta del fuoco, dai primi graffiti alla svolta genetica dell’aplogruppo L3, radice comune da cui prese avvio la migrazione «Out of Africa». Si vede quindi come il libro riporti il discorso al dato scientifico: nel corpo umano, L3 conserva la memoria biologica di quell’esodo originario. Non è un semplice marcatore: è la prova che muoversi, uscire, viaggiare non è deviazione ma gesto fondativo dell’umano.