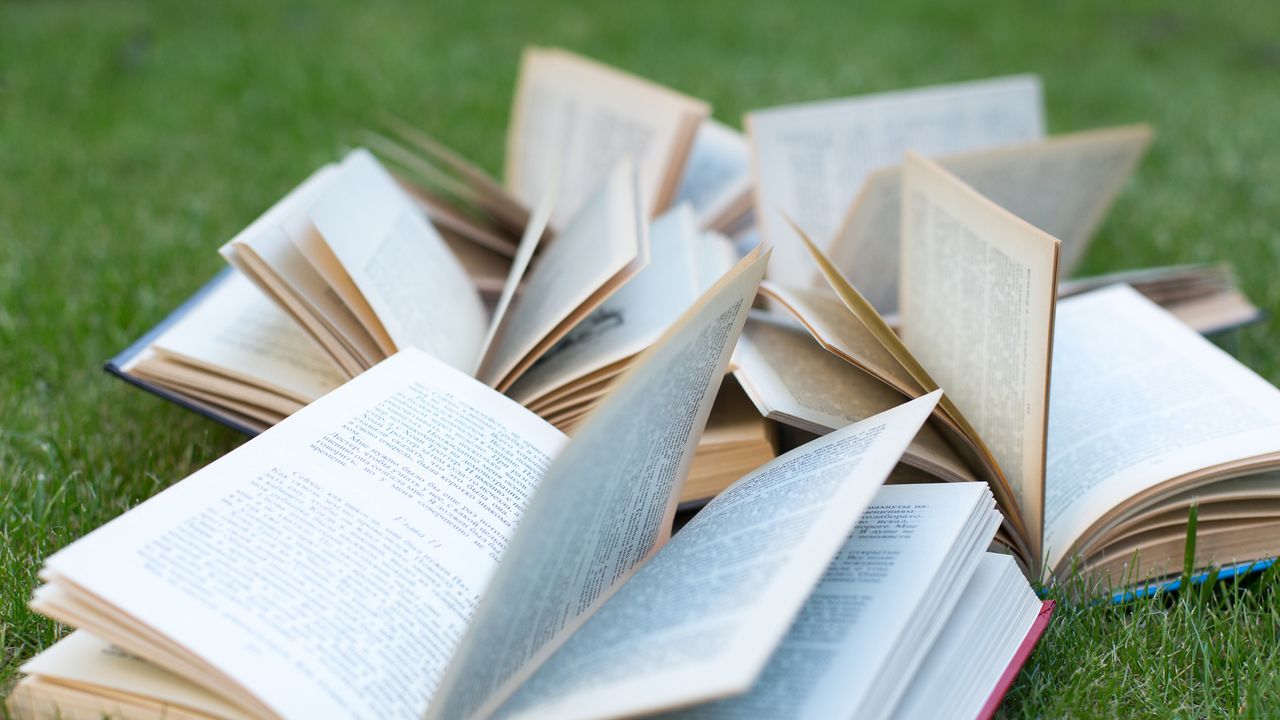È di questi giorni la notizia della Danimarca che vuole azzerare la tassa sui libri che attualmente è al 25%, una delle più alte al mondo. I libri acquistati nel 2023 nel Paese sono stati solo 8,3 milioni su una popolazione di 6. In Italia, nello stesso anno, le copie vendute sono state 115 milioni con una popolazione di quasi 59 milioni di persone secondo i dati dell’Associazione Italiana Editori. Quello danese è un tentativo già attuato in altri paesi che non ha però portato nuovi lettori, ha solo fidelizzato maggiormente quelli già esistenti. Nel nostro Paese il numero dei lettori è mediamente più alto, ma è in calo. Secondo la rilevazione dell’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori (AIE) su dati Pepe Research, il 30% dei lettori legge in maniera frammentaria, dedicandosi a questa attività solo qualche volta al mese se non qualche volta all’anno. Le persone tra i 15 e i 74 anni che dichiarano di aver letto, anche solo in parte, un libro nell’ultimo anno (a stampa, e-book, o ascoltato un audiolibro) sono il 73%, contro il 74% del 2023.
«I dati sulla flessione dei tempi di lettura e del numero di lettori, che vanno di pari passo alla flessione del mercato, confermano la necessità di tornare a sostenere la domanda di libri nel nostro Paese soprattutto tra i più giovani, creando una consuetudine con i libri che prosegua nel corso di tutta la vita», ha spiegato il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta. «Non c’è crescita e sviluppo culturale ed economico per l’Italia se non facciamo crescere i lettori, soprattutto al Sud e nelle aree meno prospere del Paese».
A lavorare per creare questa consuetudine sono, in questi anni, i festival, incontri e appuntamenti, che danno un contatto diretto con il mondo del libro. Hyle Book Festival lo fa rivitalizzando il Parco della Sila con incursioni tra letteratura, arte, natura e sostenibilità. Dopo un anno di sospensione, il festival, nato nel 2020, torna con rinnovata energia, con il titolo Il sogno continua immenso. «C’è bisogno in modo sempre più impellente di bilanciare la frenesia e velocità quotidiana in cui siamo immersi con il momento di ascolto, di rallentamento e di incontro con il silenzio che la lettura richiede. Nei festival forse il tempo si dilata e la lettura diventa partecipazione, incontro, scambio e magari anche proposito e intento» spiega Elena Dardano, ideatrice e curatrice del festival che è in programma dal 22 al 24 agosto. «Più difficile è quando questo tempo dobbiamo ritagliarlo tra i mille impegni quotidiani, tra giornate che sembrano scivolare via e tra cellulari che impazienti e impellenti risuonano di bip. Ecco che la lettura quindi passa quasi in secondo piano e che i lettori diminuiscono. Hyle è un invito a riprendersi questo tempo e a riscoprirlo anche nella placida calma della natura, che esiste e basta, che ci riporta alla capacità dell’essere anche senza il fare. Questo è il proposito che vogliamo lasciare al pubblico, insieme a una divulgazione letteraria che possa avvenire anche nelle aree interne, nelle zone montane e nei paesi».
Cosa può fare un festival che ha un tempo limitato?
«Lasciare una traccia nelle suggestioni di incontri che, attraverso le diverse arti, vogliono ispirare e far percepire quanto la letteratura ci accompagni da vicino, sempre presente nel raccontare ciò che viviamo e nel restituircelo con chiarezza e profondità. Coltivare talenti ed espressività: è questo l’intento della Residenza di scrittura naturalistica che il festival promuove biennalmente, un lavoro che inizia nel festival attraverso tre giorni di workshop, laboratori, scrittura immersiva nel bosco ed editing esperienziale a contatto con la natura e che continua poi per i due anni successivi con il lavoro di editing della pubblicazione dei lavori, andando dunque a lasciare traccia concreta nella formazione di giovani talenti e nel mondo del libro. Veicolare cultura attraverso legami con il sociale: il festival quest’anno aprirà alle donazioni di libri che il pubblico potrà indirizzare a una biblioteca del territorio, a un istituto penitenziario minorile, a un centro naturalistico o a una scuola, così da costruire sempre legami e connessioni. Far confluire e aprirsi oltre: sono due movimenti in cui Hyle crede e che da quest’anno vogliamo rendere ancora più attuale creando una rete di persone che possano essere in contatto per tutto l’anno all’insegna della letteratura e della cultura per poi ritrovarsi al festival. È qualcosa a cui pensiamo spesso e che è diventata una bussola: cosa resta del festival dopo i tre giorni del festival? Hyle procede in questa direzione a passo lento, ma costante».
Negli anni come è cambiato il festival o il suo pubblico?
«La prima edizione del festival si è svolta nel 2020 grazie alla forza di un gruppo di appassionati, di persone e istituzioni che hanno creduto nella possibilità di creare una rassegna di letteratura in un territorio dove l’offerta in questo senso era minore. Nato come appuntamento domenicale nelle giornate di agosto, il festiva ha progressivamente scelto di concentrare gli eventi in giorni consecutivi nel Centro Visita “A. Garcea”, luogo di straordinario valore, crocevia di sensibilità culturale, ricerca e divulgazione scientifica, capace di restituire quel senso di pienezza e consapevolezza che il festival si propone di trasmettere. Il pubblico pian piano è cresciuto e cresce. Quello che non si è mai ricercato è l’affanno e la logica dei numeri. Il festival ha sempre creduto, piuttosto, nella costruzione di una proposta culturale riconoscibile e autentica, capace di generare un pubblico fedele per l’identità stessa della manifestazione. E così è stato, e pian piano il festival è stato seguito per chi è, non per chi tenta di essere o diventare».