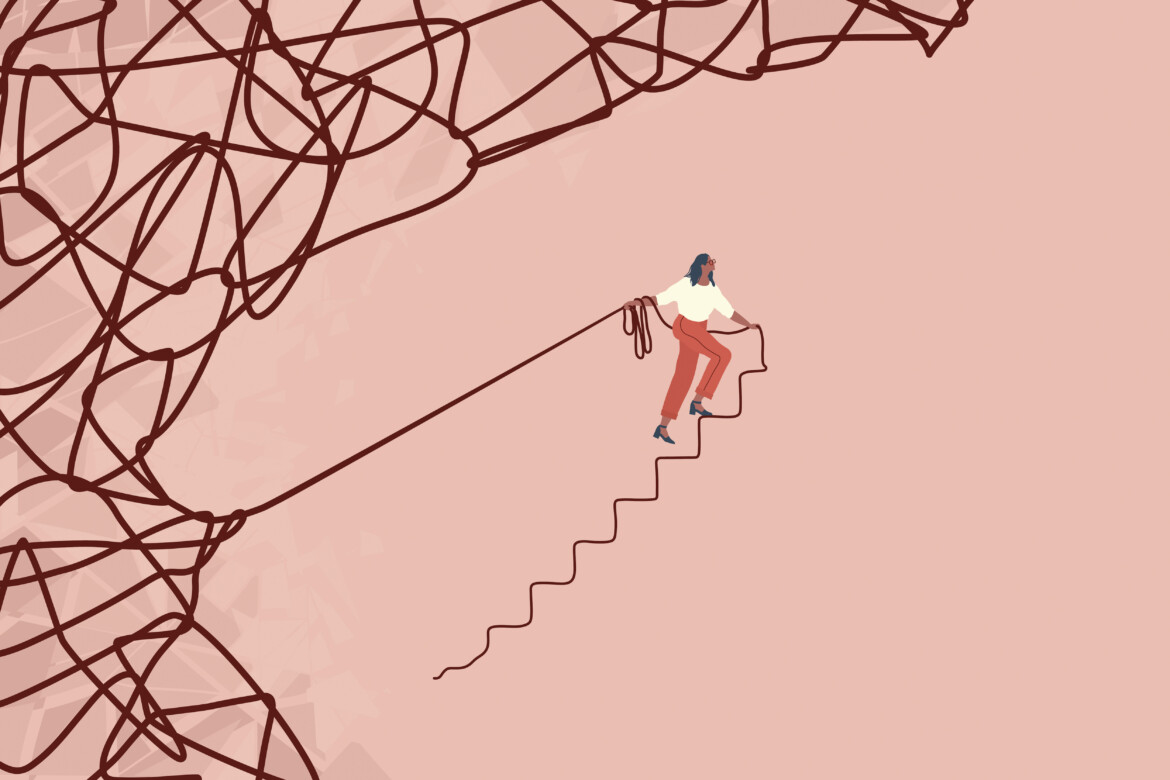Di una furia bianca, segaligna e tranquilla come quella delle montagne che la accompagnano, sono alcune narrazioni recenti che si costruiscono attorno a rilievi dell’arco alpino, che diventano i luoghi in cui prendono forma interrogativi esistenziali e sociali. Essi rivelano le incongruenze (anche generative) delle relazioni tra gli individui nel solco delle storie personali, i lutti, le memorie familiari e della Storia. Si tratta invero di rilievi a cui personagge e personaggi si aggrappano con corde emotivamente rilevanti, che stringono e si stringono nell’impossibilità di sottrarsi a schemi emozionali che possono causare pregiudizio alla loro salute emotiva oppure che li liberano. I rilievi montuosi quindi, smarcandosi dal suolo, diventano simboli di quell’altezza che si staglia nella prominenza altera di un isolamento che però non è solo elevazione ma anche partenza, transito e ritorno.
MAESTRA IN TAL SENSO è la composizione ad anello che la scrittrice svizzera Sarah Jollien-Fardel imbastisce attorno alla vita della protagonista di Longe, romanzo edito quest’anno dalle edizioni Sabine Wespieser (pp. 153, euro 18), non ancora tradotto in italiano.
Insieme a Rose le protagoniste a cui si guarda sono le montagne alte del cantone vallese, le Alpi Pennine, che si dividono tra la Svizzera romanda e la Svizzera tedesca, dove si elevano il Cervino, il Gornergrat e la Punta Dufour del Massiccio del Monte Rosa. È in una di queste vallate che nasce Rose, una donna che scopriamo vivere nel presente del racconto attaccata ad una corda. Anzi, forse si tratta di una cavezza – proprio quella usata per legare gli animali da soma – o forse ancora della corda che serve per addestrare i cavalli grazie al lavoro alla longhina. Rose, legata, è chiusa nella camera di un mayen, una sorta di piccolo chalet alpino utilizzato per il pascolo estivo e la fienagione. Ma perché Rose vive rinchiusa in una valle di montagna? Le usa violenza chi l’ha imprigionata? E se quella clausura fosse un modo per Rose di difendersi? Da chi, e perché?
FIN DALLE PRIME PAGINE la voce narrante, che si esprime in prima persona, ci lascia trovare gli indizi per terra, come Le Petit Pouchet – Pollicino – le briciole di pane nella foresta. Eppure noi lettrici e lettori ci sentiamo come il ribelle in fuga nel Ma Bohème di Rimbaud, e vaghiamo senza direzione. Qualcosa però affiora, come i ricordi, ed è la memoria di un episodio risalente a tre anni prima, quando la gendarmerie aveva annunciato a Rose che la sua unica figlia, Anna, era morta. In circostante apparentemente accidentali. Ne è al corrente anche Camil, l’uomo amato da Rose fin da quando erano entrambi bambini e poi divenuto suo marito. Completamente disorientata Rose sprofonda nella disperazione più totale, che attraversa le pagine di questo romanzo così disturbante e sul filo dei lasciti dello scompenso psichico.
Rose rivela di sentirsi bene in pochi momenti, anzi mai: «Tutte le mattine, durante un quarto di secondo». Nonostante la corda che la lega, e che ripristina il legame di attaccamento intrapsichico, Rose si dice senza collera e assente a tutto, tranne che ai ricordi. Essi sono cicatrici in rilievo, anzi, sono come le creste aspre che hanno circondato le sue giornate fin da piccola.
VIGE LA MINERALITÀ che trasmettono le rocce della valle alta, e poi ci sono i legami corrotti, e la fuga necessaria da quei legami che incavano i corpi come si fa con il legno delle statuine intagliate e poi rotte. La morte della madre, la cognizione acerba del dolore e i giorni trascorsi nel bistrot della nonna, in cui la dipendenza dall’alcol regna sovrana. Losanna è allora la città della fuga dai nodi, che poi si ritorcono attorno al collo di Rose per cristallizzarla in un paesaggio montano che blocca gli orizzonti e ogni possibile fuga dal male del sé ferito.
DI PROCESSO INVERSO, perché nel caso seguente la montagna sa di ritorno salvifico, è la traiettoria che segue la protagonista di Sette volte bosco di Caterina Manfrini recentemente edito da Neri Pozza (pp. 208, euro 18). «Sette volte bosco, sette volte prato e tutto tornerà com’era stato» recita un proverbio cimbro, a sostanziare la ciclicità delle stagioni ma anche il desiderio che le ferite inferte ai corpi e ai luoghi passino per cicli di guarigione e di rinnovamento.
Caterina Manfrini nel suo romanzo ci descrive innanzitutto le trafitture esistenziali della protagonista del suo libro, Adalina, ricostruendo la storia di una giovane ragazza originaria della Valle Terragnolo, nelle Alpi Orientali, deportata nel campo profughi di Mitterndorf vicino a Vienna a causa del confino ad opera dell’Impero austroungarico. Durante la Grande Guerra, per allontanare gli abitanti del Tirolo meridionale dalla zona di frontiera, il governo austro-ungarico istituì infatti campi di internamento siti tra Austria, Boemia, Moravia e Stiria in cui rinchiudere civili politicamente ostili, sospetti irredentisti, e per coloro che vivevano in zone di confine.
Adalina, rimasta orfana di entrambi i genitori, sopravvive al campo e ritorna a casa ritrovando inesorabilmente cambiato tutto ciò che ricordava, anche le montagne. Ripone una parte delle sue speranze in Emiliano – il fratello soldato – e nel maso di famiglia che si trova tra i monti a nord-est di Rovereto, nel Trentino orientale. La giovane prova ad affrontare le mutazioni dei luoghi che conosceva e che insieme a lei hanno subito i danni di una tragedia collettiva, perché anche le montagne sono state toccate dalla guerra insieme ai paesaggi che le circondano, bombardati.
LA VALLE È STATA DEPREDATA, sotto lo sguardo impotente dei monti Finonchio e Maggio e del massiccio del Col Santo-Pasubio, che sovrastano il maso di famiglia. Il maso stesso è stravolto, gli animali non ci sono più ed è parzialmente distrutto. Eppure Adalina non demorde e come il Leno, e la natura che il torrente attraversa, reagisce, ricostruisce, cerca speranza nella cura di ciò che è danneggiato e corrotto.
Affine, almeno nei termini dello sguardo, è la speranza che anima Traverser les montagnes et venir naître ici (pp. 350, euro 21) di Marie Pavlenko, edito in Francia presso Escales a fine 2024. È nelle montagne del Mercantour, il massiccio situato tra le Alpes Maritimes, le Alpes-de-Haute-Provence e il Piemonte, che Astrid cerca una cura e una nuova casa.
Scelta senza nemmeno visitarla questa casa a 1900 metri d’altitudine accoglierà come può la sua fuga da Parigi, e le foreste alpine agiranno lo stesso tipo di accoglienza. Ospitando il suo bisogno di abbandonare il passato, quelle montagne – su cui il marito di Astrid amava tanto arrampicarsi – non restano infatti puro decoro ma caratterizzano questo spazio transfrontaliero tra la Francia e l’Italia, attraverso cui sono arrivati e continuano ad arrivare donne e uomini in fuga. Migranti che fuggono, che attraversano e che passano – la cui sopravvivenza, tra le falle di una politica dell’emergenza, riesce solo talvolta ad essere garantita.
LA NEVE OSTILE di queste montagne incornicia spietata l’incontro fortuito tra Astrid e Soraya, giovanissima siriana fuggita da Aleppo bombardata dalle forze di Bachar al-Assad. Soraya giunge incinta attraverso la Bulgaria, l’Albania e l’Italia con la zia Ibtissan, in quella Francia tanto decantata dal padre. Ma forse quest’ultimo si sbagliava – pensa Soraya – perché sono quelle montagne, e la neve e il freddo che le hanno strappato la zia e che quasi uccidono pure lei, se non fosse per Astrid che la ritrova nel fitto gelato dei costoni. Smagrita ed estenuata Soraya sopravvive.
Se è vero che l’umanitarismo non può sostituire le lotte politiche contro l’oppressione sistemica, è anche vero che Astrid proverà ad ascoltare la storia di Soraya, a capirla e a capirsi. Capire il tormento su cui la penna di Marie Pavlenko si ostina con pudore. Tribolazioni a cui Astrid cercherà di far fronte con le risorse che pensava di aver esaurito e che invece la abitano ancora. Anche con il supporto della sua vicina Ida – creatrice e saggia – e di Max, che facilita la comunicazione linguistica tra le donne, Astrid e Soraya cominciano a vedersi, a riconoscersi e a parlarsi.
Più che la lingua però sono le loro ferite a parlarsi, a ravvisarsi e a comunicare oltre la distanza culturale ma anche quella dei traumi subiti. Le loro voci-corpo risuonano e si fanno eco, perché così come l’eco si riflette solo su superfici ampie, dure e lisce – come le pareti rocciose delle montagne – esse gridano, si ascoltano e attendono un ritorno.