“L’effetto di una legge che apre una breccia è più dirompente dell’effetto di un tribunale che apre la stessa breccia, anche se si tratta della Corte costituzionale“, afferma a In Terris Marina Casini. Giurista e bioeticista, presidente del Movimento per la Vita Italiano e della Federazione europea “One of Us”. Figlia di Carlo Casini, leader storico, guida e animatore del Movimento per la Vita. Laureata in Giurisprudenza, è docente di Bioetica e Biodiritto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. La sua attività accademica è arricchita da numerose pubblicazioni su temi quali i diritti umani, l’obiezione di coscienza, la famiglia e le questioni relative all’inizio e alla fine della vita. Membro del Comitato esecutivo della Federazione “One of Us”, la più grande rete pro-life europea, che riunisce 50 associazioni di 24 Paesi. In questa veste, ha sottolineato l’importanza di costruire ponti per il dialogo e promuovere una cultura della vita inclusiva e rispettosa della dignità umana.
 Marina Casini (@ Carlo Lannutti via Imagoeconomica)
Marina Casini (@ Carlo Lannutti via Imagoeconomica)
Stando alla cronaca, pare proprio che a settembre si apra in Parlamento il dibattito legislativo sul suicidio assistito. Una parte del centrodestra è promotore di un ddl intitolato “Disposizioni esecutive della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242” (Zanettin-Zullo). Si afferma che l’obiettivo è quello di arginare la deriva permissiva avviata dalla sentenza costituzionale del 2019, di evitare che le regioni vadano in ordine sparso, di impedire che venga approvato dal Parlamento il testo Bazoli, molto permissivo. Come si pone il Movimento per la Vita rispetto alla questione di una disciplina legislativa su questa materia e in questi termini?
“La questione è delicata, complessa e complicata, e nel Movimento per la Vita ci sono opinioni diverse. Parlo dunque a titolo personale. Non metto assolutamente in dubbio le ottime intenzioni dei proponenti e dei sostenitori del ddl, molti dei quali conosco e stimo, ma non nascondo che – al di là delle ottime intenzioni – questa mossa mi pare più un cedimento rispetto alle pressioni che spingono verso l’ ‘ufficializzazione e ‘istituzionalizzazione’ della morte volontaria assistita, che una via di reale contenimento del fenomeno. È vero che la legge 219 del 2017 e la sentenza costituzionale 242 del 2019 hanno aperto il varco a logiche di morte su richiesta (anche se non manca una significativa attenzione ai fragili e alle cure palliative); è evidente che episodi allarmanti ci sono stati e ci saranno (purtroppo), che in molte Regioni ci sono agitazioni e che, al seguito della Toscana, alcune di esse manifestano tendenze alla legalizzazione interna. Tutto questo preoccupa moltissimo ed è giusto farvi fronte”.
 Foto di Mufid Majnun su Unsplash
Foto di Mufid Majnun su Unsplash
Qual è la sua impressione?
“Ho l’impressione che a spingere verso la legge siano più il timore della deriva eutanasica, la pressione culturale, la notizia di centinaia di persone che vogliono essere aiutate a morire (vero o fake diffusa propagandisticamente?) piuttosto che una reale situazione di permissività tale da esigere una normativa nazionale limitatrice. Deve far riflettere anche il fatto – ovviamente doloroso perché duole che ci sia la ricerca della morte – che se alcune persone hanno ottenuto l’aiuto in Italia, altre sono andate in Svizzera, perché in Italia non è stato loro permesso il suicidio assistito. Questo per dire che allo stato attuale il suicidio assistito non è parte integrante dell’ordinamento giuridico. Se la valutazione è corretta, ma posso sbagliarmi, ciò che oggi viene presentato come un ‘argine’ da parte della legge rischia di diventare il suo contrario, cioè una legittimazione di ciò che accade”.
Ma la sentenza 242 è già applicata…
“Infatti. Fino ad ora la sentenza 242 è stata direttamente applicata: chi ha aiutato alcune persone ad autosomministrarsi la morte non è incorso in sanzioni penali. I processi penali nei confronti dei ‘soccorritori’ erano dovuti alla mancata presenza dei requisiti richiesti dalla sentenza 242 o al mancato coinvolgimento del comitato etico territoriale. Come dicevo, però, l’introduzione per legge delle disposizioni della sentenza 242 rischia di portare a un consolidamento e a un ampliamento della breccia, proprio per natura della legge che dispone regole per tutto il territorio nazionale”.
 Foto di PublicDomainPictures da Pixabay
Foto di PublicDomainPictures da Pixabay
I punti da affrontare sono tanti… andiamo con ordine. Mi pare rilevante il fatto che nel ddl non si parli affatto di “diritto alla morte” ma si mantenga il reato di cui all’art. 580 del Codice penale salvo le ipotesi di depenalizzazione che si rifanno alla sentenza costituzionale 242 e che per altro sono descritte in modo un po’ più restrittivo.
“Certo che è rilevante. Non c’è dubbio che la differenza tra “diritto” e depenalizzazione circoscritta ad alcune ipotesi è abissale e sostanziale. Non si può però trascurare l’esperienza: spesso la depenalizzazione è interpretata come passaggio al “diritto”; infatti, nei paesi che hanno legalizzato l’eutanasia, a cominciare dall’Olanda, il primo passo è stato proprio la depenalizzazione a partire da casi estremi (i c.d. “casi pietosi”). Certamente il discorso non va irrigidito, perché la sanzione penale è uno strumento di tutela che può essere sostituito con un altro ritenuto più efficace e adeguato a proteggere il bene in questione – la vita umana, nel nostro caso – ma se la pena viene semplicemente eliminata senza che a ciò corrisponda una diversa, non equivoca, e più adeguata protezione, concretamente applicata, è facile poi scivolare nella pretesa del “diritto di morire” da parte di chi interpreta e applica la legge; “diritto” «paradossalmente percepito dal malato – precisa proprio la Corte Costituzionale nella sentenza 66 della scorsa primavera – come un “dovere di morire” per non “essere di peso”, con un grave abbassamento della sensibilità morale collettiva che tutela le persone più fragili, spesso, peraltro, ‘invisibili’”.

I sostenitori del ddl ne sottolineano la positività in quanto il testo afferma l’inviolabilità e l’indisponibilità del diritto alla vita senza alcun tipo di distinzione; sono dichiarati nulli gli atti civili ed amministrativi contrari alla legge; sono potenziate le cure palliative anche dal punto di vista dell’investimento economico; soprattutto si tiene fuori il Servizio Sanitario Nazionale da ogni complicità con l’aiuto al suicidio. Non le sembrano aspetti meritevoli di apprezzamento?
“Ma certo! Lo sono senz’altro e sono d’accordissimo! Resta purtroppo il fatto che il testo ha anche un altro contenuto ed è stato elaborato soprattutto per quest’altro contenuto e cioè – sulla scia di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nel 2019 – per configurare un’area di non punibilità nei confronti di chi agevola l’esecuzione del proposito suicidario, «formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato Nazionale di Valutazione di cui all’articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833». Non per nulla il titolo della legge, se non verrà modificato, è proprio “Disposizioni esecutive della sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242”. Ora, a parte le criticità legate all’istituzione e alla disciplina del Comitato Nazionale di Valutazione, che di fatto configura una sorta di procedura, mi pare che le affermazioni sulla tutela del diritto alla vita e alla cura siano indebolite proprio dalla previsione delle ipotesi di depenalizzazione del suicidio assistito abbinate alla valutazione dell’apposito Comitato Nazionale”.
 Marina Casini, Presidente del Movimento per la Vita Italiano (foto: Francesco Vitale)
Marina Casini, Presidente del Movimento per la Vita Italiano (foto: Francesco Vitale)
Eppure è stata la Corte Costituzionale a chiedere ripetutamente un intervento del legislatore…
“È vero. Ma fino a che punto c’è – se c’è – da parte del Parlamento l’obbligo di stare dietro alla Consulta che – diciamolo – è andata ben oltre i suoi compiti dettando praticamente al legislatore quello che deve fare? Non sono pochi i giuristi costituzionalisti che sottolineano la discrezionalità, il cosiddetto “margine di apprezzamento”, del potere legislativo cioè la sua autonomia in ordine alla decisione di legiferare o meno. In diverse decisioni questa discrezionalità è stata ribadita anche dalla stessa Consulta. Riflettiamo poi sul fatto che l’ultima sentenza, la 132 del 25 luglio scorso, ha addirittura travalicato i limiti che essa stessa aveva indicato relativamente al tipo di coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale, cadendo in contraddizione e dando un palese e pesante rinforzo politico alla proposta più permissiva. Se nelle sentenze 242 del 2019 e 135 del 2024 aveva parlato di un ruolo di verifica delle condizioni legittimanti e delle modalità di esecuzione, nella sentenza 132 del 2025 giunge ad affermare che tra i compiti del Servizio Sanitario Nazionale c’è anche il ‘reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego’. Per la Corte, dunque, il Servizio Sanitario Nazionale deve entrare, quasi da protagonista, nelle procedure per l’aiuto al suicidio”.
 Montecitorio, Sala della Regina – Un momento della tavola rotonda su Carlo casini (foto: Francesco Vitale)
Montecitorio, Sala della Regina – Un momento della tavola rotonda su Carlo casini (foto: Francesco Vitale)
E adesso?
“Ora, il legislatore che intende mettersi al seguito della Corte, sia pure nel tentativo di restringere lo spazio del suicidio assistito, non può ignorare che proprio dalla Corte vengono indicazioni che potrebbero far dichiarare subito incostituzionale la disposizione, proprio sotto il profilo che maggiormente distingue l’attuale ddl dalla proposta più permissiva. Quindi, bene che vada, risulterebbe una legge che ripete i contenuti della sentenza n. 242/2019. Ma, come detto all’inizio, la forza di una legge nazionale è superiore rispetto a quella di un atto giurisdizionale anche se di rango costituzionale: per la mentalità comune, ciò che è permesso dalla legge non è solo una cosa che si può fare, ma è una cosa socialmente “rispettabile”, “buona”, se non addirittura “doverosa”. Il passaggio dall’eccezione alla normalità fa presto ad arrivare”.
 Foto di Dominik Lange su Unsplash
Foto di Dominik Lange su Unsplash
Ma le Regioni si stanno muovendo, ciascuna per proprio conto, per inserire al loro interno normative a favore del suicidio assistito. Si parla di “regionalismo differenziato”. La Toscana ha già provveduto. Lasciamo fare? Non è meglio, in una materia tanto delicata, giungere a una normativa nazionale che metta ordine e omogeneità?
“Certamente le cose non vanno lasciate andare, tanto è vero che sulla legge della Toscana pende un giudizio di costituzionalità, sollevato dal Governo, stante la violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, non sussistendo sul tema alcuna competenza legislativa regionale né concorrente, né residuale. La sentenza è attesa per novembre e sarà interessante vedere come si comporterà la Corte. È chiaro che se la Corte dichiara illegittima la legge toscana, anche le altre Regioni dovranno prenderne atto. Quanto all’ordine e alla omogeneità, ciò che rileva non è tanto l’uniformità della disciplina legislativa estesa a tutto il territorio nazionale, quanto il suo contenuto. E se il contenuto della legge nazionale – che è il livello più alto della società organizzata – è quello di aprire al suicidio assistito, seppure solo depenalizzato in un ambito circoscritto, l’effetto pratico andrà oltre le intenzioni e la lettera della legge, finendo per debilitare tutto ciò che riguarda il diritto alla vita e il diritto alle cure.
 Foto di Sabine van Erp da Pixabay
Foto di Sabine van Erp da Pixabay
Qualcuno sostiene che l’attuale ddl è un “buon punto di equilibrio” tra la posizione di chi è contrario a qualsiasi legge e chi ne vorrebbe una apertamente permissiva. Cosa ne pensa?
“Mi è venuto in mente che la stessa cosa veniva detta ai tempi della campagna referendaria sull’aborto: la legge 194 si trovò avvantaggiata proprio perché presentata come “giusto equilibrio tra due opposti estremismi” che allora erano individuati nel Movimento per la Vita da un lato e nel partito radicale dall’altro. In realtà si trattava di una narrazione sbagliata perché le ambiguità e le equivocità della 194 la ponevano – e la pongono – nella sostanza in posizione prossima alle istanze radicali, tanto che l’interpretazione e l’applicazione della legge sono andate e vanno in quella direzione. Detto ciò, allo stato attuale il ddl di cui stiamo parlando non è accostabile alla legge 194 quanto meno per l’esclusione del Servizio Sanitario Nazionale, anche se temo che questo aspetto reggerà poco. Vedremo poi cosa accadrà in Parlamento”.

Per giustificare una legge sul suicidio assistito da parte dei cattolici è stato più volte invocato il principio della riduzione del danno di cui parla il paragrafo 73 dell’enciclica Evangelium Vitae. Questo principio viene invocato sia nei confronti del “caos” dovuto al “regionalismo differenziato”, sia nei confronti della proposta Bazoli. Questo principio non potrebbe rendere doverosa la proposta restrittiva?
Il paragrafo 73 dell’Evangelium Vitae è molto importante, ma anche molto esigente e rigoroso. Bisogna comprendere in profondità la situazione nelle circostanze concrete, tenendo conto di tutti i fattori in gioco, del metodo e delle strategie, avendo grande rettitudine, capacità di discernimento, acuto e intelligente senso politico. Se, infatti, in teoria il principio della doverosa riduzione del danno va tenuto presente senza irrigidimenti moralistici, in pratica bisogna capire a fondo la situazione complessiva perché il “rimedio” potrebbe essere peggiore del danno che si vuole ridurre. La parte che riguarda il «particolare problema di coscienza [che] potrebbe porsi in quei casi in cui un voto parlamentare risultasse determinante per favorire una legge più restrittiva […] in alternativa ad una legge più permissiva già in vigore o messa al voto», è preceduta da un monito di chiarezza adamantina: «Nel caso […] di una legge intrinsecamente ingiusta, come è quella che ammette l’aborto o l’eutanasia, non è mai lecito conformarsi ad essa, né partecipare ad una campagna di opinione in favore di una legge siffatta, né dare ad essa il suffragio del proprio voto». Questo per dire che il legittimo e doveroso tentativo di limitare gli aspetti iniqui di una legge in vigore o messa al voto, che non è possibile abrogare o scongiurare, non va banalizzato come se giustificasse il “compromesso” o il “male minore” a basso costo. Non dimentichiamo che molti, e alcuni anche nel mondo cattolico, ritenevano necessaria una legge sull’aborto per ridurre il danno dell’abortività clandestina e per evitare la totale liberalizzazione voluta dai radicali. E così adesso siamo all’assuefazione, tanto che l’aborto è diventato un fatto socialmente accettato, considerato comunque “diritto”, realizzato anche con le pillole per renderlo – almeno apparentemente – facile come bere un bicchier d’acqua. Approfitto per dire una cosa”.
 Montecitorio, Sala della Regina (foto: Francesco Vitale)
Montecitorio, Sala della Regina (foto: Francesco Vitale)
Quale?
“A proposito di leggi, che sarebbe urgente togliere dal recinto del tabù la legge sull’aborto e pensare a ipotesi di revisione, quanto meno per eliminarne le ambiguità, a favore del diritto a nascere e a favore di un’autentica tutela sociale della maternità. Perché non aggiungere, per esempio, “nel concepimento” quando all’art. 1 si dice che «Lo Stato […] tutela la vita umana sin dal suo inizio»? Importante sarebbero anche una riforma dei consultori familiari per renderli limpidamente a servizio della vita nascente e della donna-madre durante la gravidanza e la modifica dell’articolo 1 del codice civile per riconoscere l’inizio della capacità giuridica di ogni essere umano dal concepimento. È in gioco il volto davvero umano della società e dunque di una politica che voglia essere davvero centrata sull’ “umano tutto intero”, come da tempo giustamente si chiede.
 Marina Casini (foto: Francesco Vitale)
Marina Casini (foto: Francesco Vitale)
A sostegno del ddl viene ricordato l’appoggio dato dai cattolici alla Legge 40 sulla “procreazione medicalmente assistita”. Come vede questo collegamento?
“Sinceramente non vedo un collegamento, salvo il richiamo da parte di chi sostiene il ddl sul suicidio assistito alla “riduzione del danno” o al “massimo bene possibile”. Ma il contesto, la prassi e il tessuto normativo, in cui è intervenuta la legge 40, nonché il metodo di lavoro seguito sono molto diversi. Basti ricordare che prima della legge 40, in base al principio di completezza dell’ordinamento giuridico, secondo cui tutto ciò che non è vietato è permesso, il permissivismo era totale (tutto era possibile, salvo ipotesi periferiche come formazione di ibridi, chimere, clonazione) e che la legge 40 è stata raggiunta dopo aver fatto una intensa battaglia parlamentare per abbattere il progetto di legge permissivo in discussione che legittimava consolidandolo quanto già accadeva. La battaglia fu tale che la relatrice dei Ds, Marida Bolognesi, il 1° febbraio 1999, diede le dimissioni. Per ricostruire quel pezzo di storia c’è materiale in abbondanza. Per quanto “imperfetto”, il testo originario della legge 40 è stato un successo ottenuto in mezzo a mille difficoltà, con l’approvazione di una maggioranza trasversale del Parlamento”.
Cosa accadde poi?
“I colpi purtroppo successivamente inferti dalla Corte Costituzionale, dal 2009 in poi, dimostrano quanto sia aggressiva l’ideologia individualista e intollerante e quindi quanto grande sia stato il risultato raggiunto con la legge 40 nel 2004 e confermato nel 2005 con il referendum. È assolutamente importante ricordare che l’angolo di visuale della legge originaria era il figlio generato in provetta, riconosciuto dal concepimento soggetto titolare di diritti, e che perciò era esclusa l’uccisione di ogni essere umano allo stadio embrionale (principio di destinazione alla nascita). La disciplina legislativa era coerente. Preciso che i cattolici difesero quella legge non perché “cattolica”, ma perché difendeva e promuoveva laicamente il valore della vita e della famiglia e i conseguenti diritti fondamentali nei confronti dei figli generati con le tecniche procreative: il diritto a nascere e il diritto ad avere un padre e una madre certi e ‘totali”.
 Foto di Gerd Altmann da Pixabay
Foto di Gerd Altmann da Pixabay
Di cosa ci sarebbe bisogno veramente a livello legislativo?
“La tutela dei fragili è una cosa molto seria e non la vedo compatibile con istanze di morte volutamente cagionata. Sarebbe molto significativa una proposta di legge, anche di iniziativa popolare, sulla tutela concreta, efficace ed effettiva, delle persone fragili. Una tutela a 360 gradi, che preveda corsie preferenziali per la cura e l’assistenza da parte di tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Le cure palliative – per le quali bisogna fare ancora molto – sono un aspetto fondamentalissimo, ma vanno circondate da tutta una serie di attenzioni e agevolazioni che vanno da un qualificato potenziamento dell’assistenza sanitaria sia domiciliare che ospedaliera, a un facile e immediato accesso alle cure necessarie; da un sostegno ai caregivers, all’abbattimento delle barriere della burocrazia sanitaria e delle attese per visite e controlli medici; da una più qualificata formazione umana e professionale degli operatori sanitari, a un investimento economico per il miglioramento in termini di servizi e ambiente delle strutture sanitarie, da un migliore funzionamento e da una riqualificazione dei pronto soccorso, a un aumento degli hospice e dei posti letto negli ospedali. Questo per dire solo alcuni aspetti. Senza aiuti per vivere e per curarsi; senza aiuti alle famiglie al cui interno ci sono malati, disabili, anziani; senza ambienti accoglienti, senza relazioni di cura che illuminano di senso l’esistenza di chi è colpito dalla malattia e dalla non autosufficienza, la morte appare come una via liberante. La Corte costituzionale nella sentenza 66 del 2025 afferma che è «dovere della Repubblica di rispondere all’ appello che sgorga dalla fragilità, in modo che una persona malata possa avvertire la solidarietà attorno a sé non a tratti, non a prolungate intermittenze, ma in via continuativa, attraverso un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale. Diventa quindi cruciale garantire adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare”.
 Foto di Caroline Hernandez su Unsplash
Foto di Caroline Hernandez su Unsplash
Ma sicuramente sarà in aula il disegno Bazoli…
“Sì, lo so. È chiaro che la battaglia va fatta per impedire che venga approvato o quantomeno per cercare di eliminarne gli aspetti più iniqui. Nella scorsa legislatura una simile strategia ha funzionato per la proposta Zan e sempre per la proposta Bazoli. Se – per riprendere il famoso paragrafo 73 dell’Evangelium Vitae – non fosse possibile scongiurare del tutto la proposta messa ai voti, gli aspetti di ingiustizia che eventualmente restassero sarebbero minori e l’azione volta ad ottenere quel risultato, seppure non soddisfacente, sarebbe accettabile”.
 Foto di beauty_of_nature da Pixabay
Foto di beauty_of_nature da Pixabay
Una parola conclusiva
“Tre cose. La prima: la mia è una riflessione che può essere sbagliata, non sono una che ritiene di avere la verità in tasca, anzi, spesso sono assalita dai dubbi sulle “strategie” operative e i percorsi da intraprendere per raggiungere un risultato. Però sono certa che nella vita reale, quella quotidiana, di fronte alla malattia, alla disabilità, alla vecchiaia, con le paure (di essere un peso, della solitudine, di quello che potrebbe succedere, di affrontare il cambiamento…), la sofferenza, lo sconforto, la fatica, i limiti, la stanchezza, il subbuglio esistenziale, la difficoltà di accettare il declino e la privazione dell’autonomia, che esse molto spesso comportano, c’è bisogno di una grande prossimità. Il buon samaritano insegna. Insomma, di tutto c’è bisogno tranne che di una “spinta” verso il “fine vita volontario” (che poi che sia davvero “volontario” è tutto da dimostrare se siamo in presenza di un “invito” sociale ad andarsene). La seconda: mi ha colpito quanto papa Leone ha detto il 28 agosto scorso: «Non c’è separazione nella personalità di un personaggio pubblico: non c’è da una parte l’uomo politico e dall’altra il cristiano. Ma c’è l’uomo politico che, sotto lo sguardo di Dio e della sua coscienza, vive cristianamente i propri impegni e le proprie responsabilità! […] l’impegno apertamente cristiano di un responsabile pubblico non è facile, in particolare in certe società occidentali in cui Cristo e la sua Chiesa sono emarginati, spesso ignorati, a volte ridicolizzati. Non ignoro neppure le pressioni, le direttive di partito, le «colonizzazioni ideologiche» — per riprendere una felice espressione di Papa Francesco —, a cui gli uomini politici sono sottoposti. Devono avere coraggio: il coraggio di dire a volte «no, non posso!», quando è in gioco la verità. Anche qui, solo l’unione con Gesù — Gesù crocifisso! — vi darà questo coraggio di soffrire in suo nome. Lo ha detto ai suoi discepoli: «Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!». La terza: il pensiero che ho espresso, e che probabilmente dispiacerà a qualcuno, non vuole assolutamente creare un clima di rottura: non è il mio stile e non è mai stato neanche quello del Movimento per la Vita. Seguiremo perciò il dibattito parlamentare nel confronto e nel dialogo. Continueremo con ancora maggiore perseveranza e speranza a lavorare cercando la collaborazione di tutti per promuovere una sempre più piena cultura della vita”.
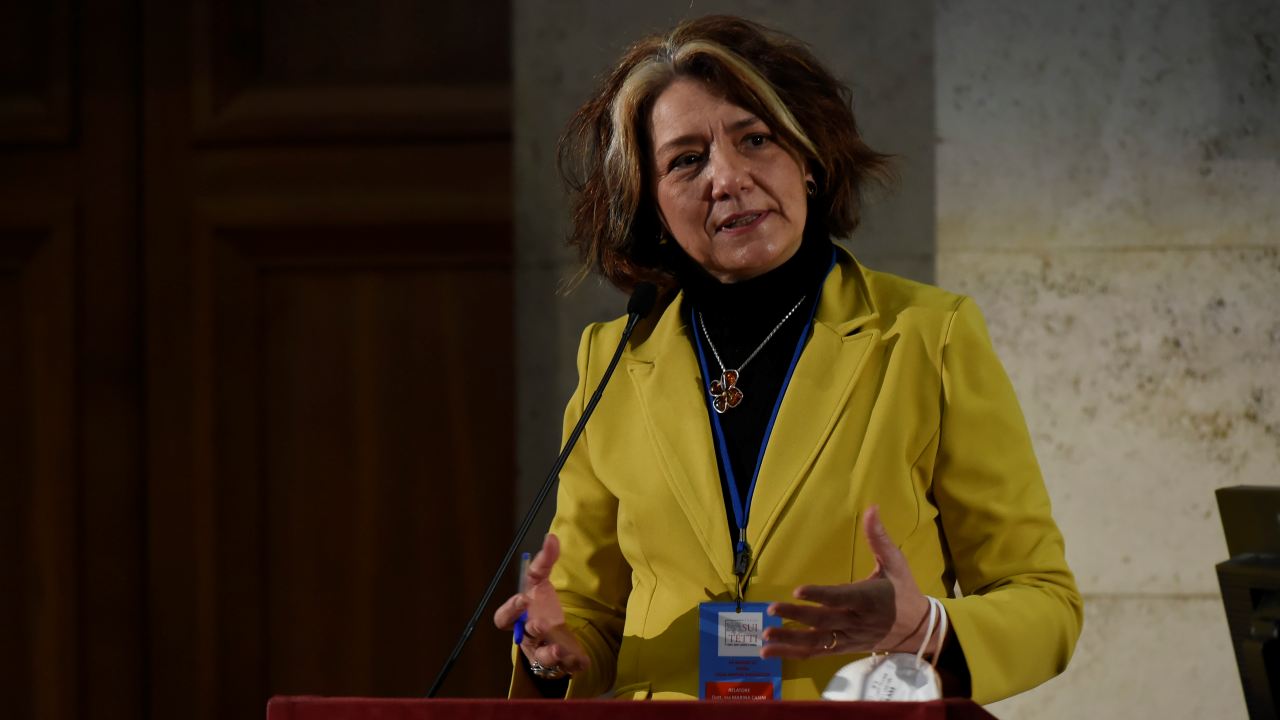
 Foto di
Foto di