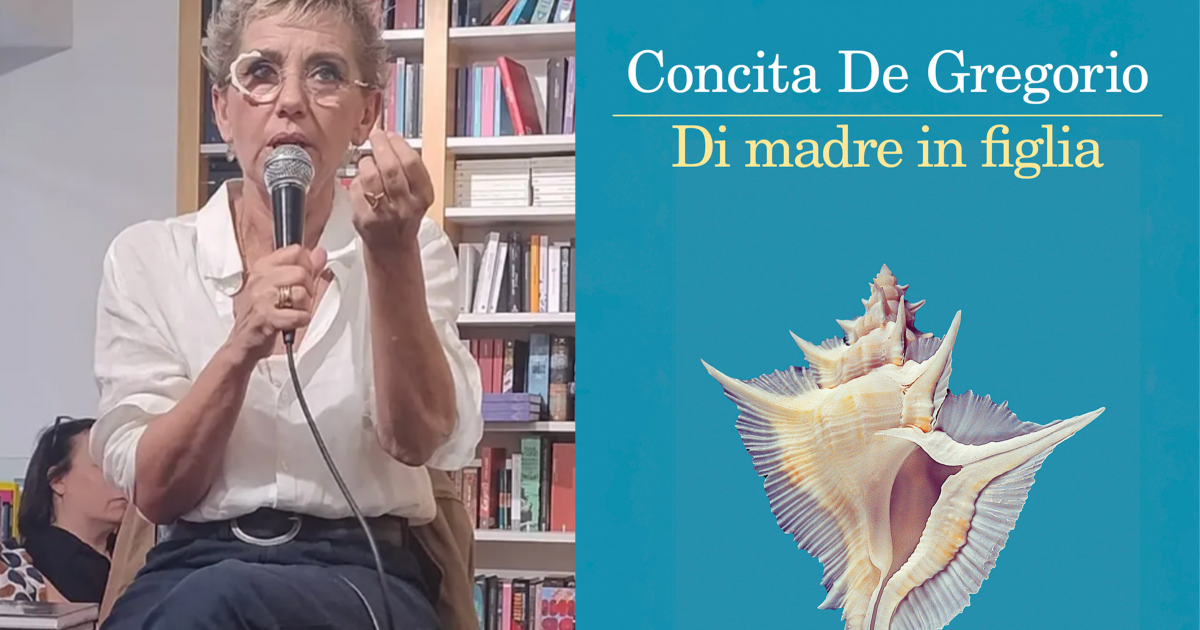È una domanda interessante quella che ci aiuta a porci Di madre in figlia. Come misuriamo l’amore? Uno dei punti centrali del libro, come De Gregorio sottolinea anche durante la presentazione, è proprio la natura dell’amore materno:
L’amore, come una medicina, dipende dalla dose.
Se è troppo, soffoca. Se è troppo poco, lascia ferite profonde e ci condanna ad un’esistenza di ricerca. Ma ciò che emerge è che ognuno ama come può, con gli strumenti che ha, secondo la propria esperienza e secondo il proprio tempo. Non esiste una madre perfetta, così come non esistono figli cresciuti senza ferite. Esistono solo tentativi di trasmettere affetto e protezione e questi cambiano nel tempo. De Gregorio ricorda che l’ossessione dei nonni di una volta era la mera sopravvivenza dei figli. “Hai mangiato abbastanza, hai freddo, hai caldo, stai bene?”. Andando avanti la generazione successiva ha puntato tutto sull’emancipazione attraverso lo studio.
Mi raccomando, non vi fidanzate. Se vi fidanzate non vi laureate più, non andrete a studiare fuori, resterete a casa. L’idea era: prima studiate, poi vi fidanzate. Perché sapere è potere, e l’unico strumento di libertà è la conoscenza. Solo la conoscenza poteva emanciparci anche socialmente dalle condizioni delle generazioni precedenti.
Scherzando poi si parla dei vari tipi di mamme, come quella Elicottero che segue i figli dall’alto, o quella Spazzaneve che spiana la strada ai figli in modo che non trovino ostacoli. Tutti questi modelli hanno un tratto comune, cioè il desiderio di preservare i figli dai pericoli del mondo. Ma questo non è possibile. Quello che invece è possibile è riconoscere che l’amore, nelle sue forme e con le sue imperfezioni, è la vera eredità che resta dei nostri genitori e delle generazioni prima delle loro. E che va letto anche in relazione alla storia e ai tempi che continuano a cambiare.
È in questa prospettiva che si capisce meglio il filo che lega le tre protagoniste.
Marilù, la nonna, cresce Angela, sua figlia, negli anni Settanta e nel desiderio di donarle la libertà tanto agognata dalla sua generazione. Così Angela racconta attraverso i ricordi di come spesso si sia sentita abbandonata a sé stessa; del fatto che avrebbe voluto un padre ma non l’ha avuto, di come Marilù fosse una madre egoista, spregiudicata, indifferente e di come la perdesse in continuazione. Marilù ribatte che non l’ha mai persa, visto che è ancora qui, e che ha sempre e solo voluto insegnarle ad essere libera perché per la libertà era la cosa più importante.
Devastata dalla sua esperienza come figlia “abbandonata”, Angela cresce e diventa una donna intelligente ma ansiosa, iperprotettiva e dipendente dalle medicine, convinta che controllare e prevenire sia la forma giusta d’amore. Così sua figlia Adè cresce protetta da tutto e da tutti, soffocata dall’ansia e dall’insonnia, succube di una madre spesso controllante che però sta facendo del suo meglio, probabilmente come Marilù a sua volta ha fatto. Solo staccandosi dal telefono e costretta a entrare nel mondo della nonna, Adè riesce a vedere i limiti e le verità di entrambe, a scoprire che l’amore è sempre imperfetto e sempre diverso, ma non per questo meno reale.
La storia, dunque, non parla solo di rapporti familiari, ma della difficoltà di entrare in contatto con l’altro, di accettare un amore che non è come lo vorremmo, di riconoscere che ognuno ama a modo suo e che imparare a ricevere quell’amore è forse la sfida più grande.