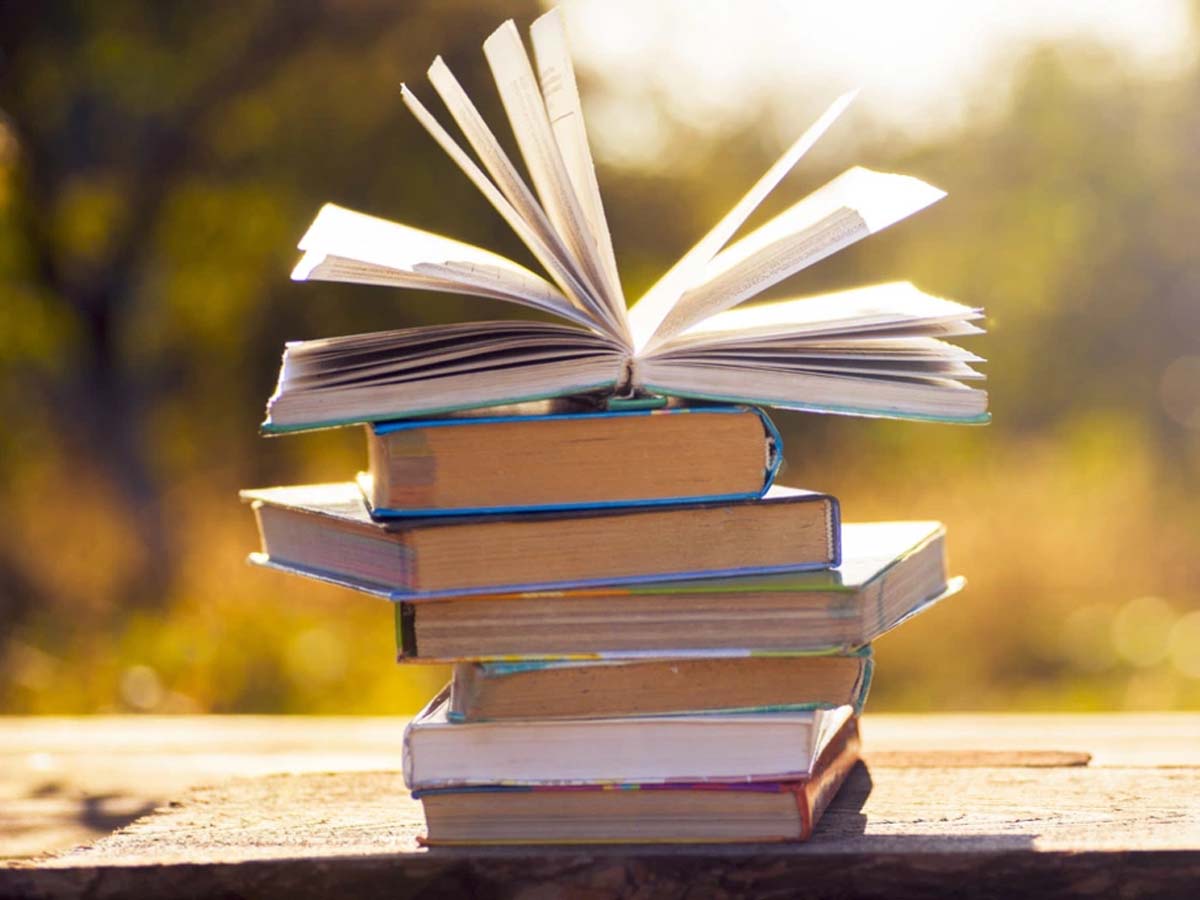Si può rinascere dopo incidenti sul lavoro che ti impediscono di camminare come prima, e che ti mettono un cartello di inabile, iellato, e tutto il repertorio non ufficiale, ma assai operativo, del genere? E se sì, si può raccontare questa rinascita senza ricorrere al repertorio canonico del “e vinse quasi sempre tutto, conquistò la ricchezza, e l’amore, e una bellissima casa, e mangiò solo piatti prelibati e di gran lusso”?
“Di nome faceva Arturo” di Remo Rapino (Città Nuova, 178 pagine, 16,90 euro) dice di sì. È uno dei pochi racconti in cui l’umile emarginato non solo incontra un amore non technicolor ma reale e fecondo, oltre che inaspettato, ma compie un cammino di crescita molto poco scenografico, in apparenza: perché incontra non solo la bibliotecaria che sarà la donna del suo cuore, anche se le cose non andranno esattamente secondo le umane, terrene speranze, ma anche un libro perduto, e poi un altro, e lentamente tanti altri, oltre che un filosofo di strada, che per certi versi potrebbe richiamare il Socrate dell’Agorà ateniese, un cane vagabondo, un architetto che litiga con il mondo intero, perché non si piega agli interessi politici.
Sarà con loro che inizierà un cammino nuovo, apparentemente senza senso apparente, fatto di libri. I libri? E a che servono più ormai, quando posso dare un’occhiata distratta, un minutino, non di più, a qualche pagina riportata sui social, sul mio smart?
Eppure la rinascita degli emarginati è proprio questa, dare nuova vita ai libri. Ed è così che Arturo e gli altri li raccolgono, li curano, rilegano, abbelliscono e li mostrano impilati nel cortile del protagonista, una volta tanto non il bello e fatale o il commissario di turno, ma il menomato, sfortunato, avanzo sociale.
Eppure questo avanzo ha successo, perché la gente va alle surreali presentazioni di libri e argomenti nel cortile ormai di carta, e porta altri libri, giornali, ma pure da mangiare e da bere, ed è coinvolta da questo semplice modo di tornare alla piazza, alle radici, anche quelle libresche e librarie.
Non una storia ammiccante e per forza a lietissimo fine, perché come nella storia umana, quella vera, ci sono i tempi degli addii, del dolore, delle domande sul perché.
Ed è questo che rende “Di nome faceva Arturo” una storia vera, credibile, che rifugge dai luoghi comuni di oggi, e semmai ritorna all’essenza: il rapporto con la natura, ad esempio, quella non esotica da vedere con viaggi da raccontare a vita, ma quella di tutti i giorni, la riva del nostro mare, gli uccelli, i fiori dei campi, e “un libro sotto il braccio”: quel libro che ci offre nuove possibilità, l’incontro con il bene, il ricordo personale, o la lettura, che non sono così lontani, “la gentilezza di un gesto, una carezza, il fiato di una parola buona”. E la natura sembra interagire, in questo libro, con il protagonista, che non passa per i giardini perché avverte dentro di sé che gli alberi, le piante, il creato partecipano al dolore dentro di lui, e ne soffrono come lui.
Dove il miracolo esiste, a saperlo guardare, è l’insegnamento anche di Pascoli, nel dono divino di un incontro con l’altro, o in quello che ci permette di contemplare la bellezza del creato, di trovare finalmente il Senso perduto dal nostro allontanarci dall’essere creature.