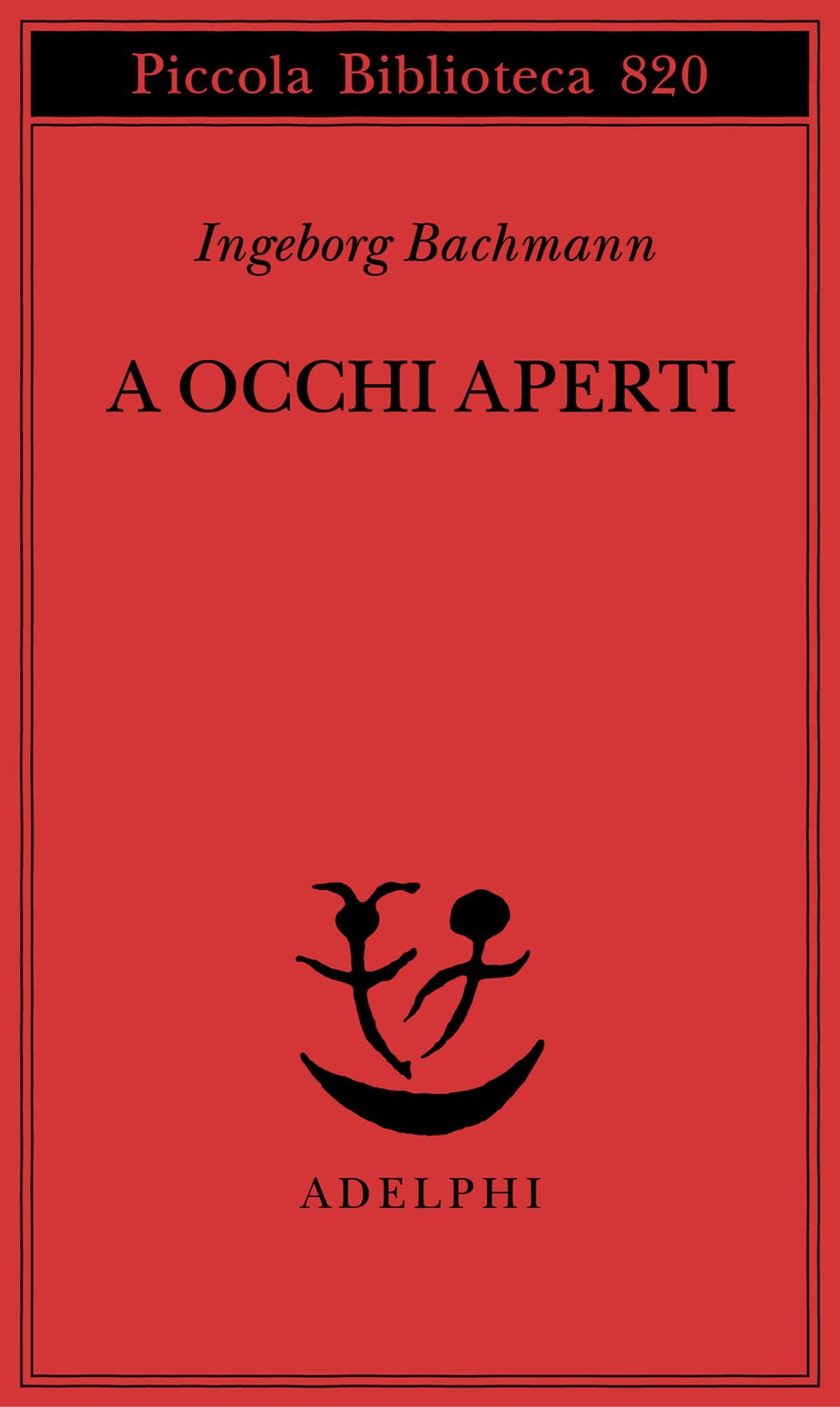Ne I passeggeri clandestini, Bachmann annota con stupore di bimba i tanti, troppi minuscoli particolari che con gli occhi di adulti e di tristi contemporanei quali siano ci sfuggono quando prendiamo un aereo. Talmente assuefatti dal già visto, dal già vissuto che non ci soffermiamo più su piccole meraviglie come l’amoreggiare delle nuvole, le melodie dei carillon venduti nei negozi di souvenir degli aeroporti, il sorriso di una hostess o anche solo le vite di chi – inconsapevole del nostro passaggio sopra la sua testa – continua a suonare la propria chitarra nella tranquillità del suo patio in una delle minuscole casette che ci sfilano sotto.
Ingeborg Bachmann
Chi abbia letto anche solo una pagina, o una poesia, di Ingeborg Bachmann non può che essere rimasto colpito dalla sua audacia nell’affrontare la violenza e il dolore, e nell’assecondare con tenacia la tensione che ci spinge «verso l’assoluto, l’impossibile, l’irraggiungibile».
Il libro è un piccolo gioiello; che si tratti di descrivere le gesta di Maria Callas “non si è certo trattato soltanto di una voce” o di raccontare dell’incontro surreale con Ungaretti, un pomeriggio passato a Fiumicino in cui il mostro sacro della poesia italiana è descritto in maniera originalissima e personalissima come una delle persone più generose mai viste, che si prende cura di lei regalandole amuleti portafortuna quando si accorge che lei sta poco bene; dice Bachmann: “io esisto soltanto quando scrivo, quando non scrivo non sono niente”, un leitmotiv che emerge con forza nella raccolta, e che descrive il suo modo di intessere scrittura, esistenza, performance in un groviglio indissolubile.
Nata nel 1926 a Klagenfurt, e morta in circostanze assurde in Via Giulia a Roma – quando la sua vestaglia andò a fuoco per colpa di una maledetta sigaretta – Bachmann seppe produrre poesia, radio, critica, recitazione. Già nel 1952 si occupava di qualcosa di particolarissimo, ovvero i radiodrammi, tanto da essere premiata per questo anche dall’Associazione ciechi di guerra.
Un’intera sezione è dedicata a Wittgenstein – filosofo suo connazionale a lei particolarmente caro – con cui stabilisce un patto di chiarezza. Bachmann riassume il suo pensiero con concisa lucidità: come quando afferma che per dire tutto ciò che si sa “tre parole bastano”, e in poche pagine riesce a trasformare la filosofia in prosa memorabile. Allo stesso modo autori come Kafka, Musil, Plath o Bernhard diventano occasioni di riflessione sul linguaggio come limite e apertura del pensiero, per identificare e disegnare ove possibile i bordi del mondo.
Il passaggio sul titolo ritorna potente: “quello stato lucido e straziante in cui il dolore diventa fecondo” senza però retorica o lirismo: è un invito a fare qualcosa della sofferenza, a convogliarla come sorgente di conoscenza, e non come chiusura. Il dolore, per Bachmann, è materia viva, e non pietra tombale. Una materia prima di cui fare qualcosa, magari proprio della poesia, descritta come qualcosa però di solitario, che non interessa a nessuno, eppure luogo fondamentale per quel qualcuno che a un certo punto, come in un bosco, vi capiti errando.
Ecco il suo manifesto: difendere una verità individuale, sempre distante dal quieto buonismo dell’ipocrisia e del “sentire generale” della propria e di altre epoche. D’altronde siamo anche negli anni Cinquanta–Sessanta, ci siamo lasciati alle spalle le macerie del secondo conflitto mondiale, in un’Europa che ancora frana nei non detti. Bachmann – come molti della generazione del Gruppo 47 – lavora per una letteratura capace di guardare dritto dentro la Storia. Come in Quel che ho visto e sentito a Roma, in cui anche la nostra capitale diventa strumento d’indagine e di visione, non solo teatro, ma metafora: luogo per imparare a “guardare” o per recuperare nomi, scovare dettagli da leggere in modo nuovo e memorie sepolte da far risorgere, per capire cose come il fatto che “il Tevere non è bello, ma è bella la sua acqua, verde melma oppure bionda, secondo i riflessi del fiume”, che San Pietro è più piccola di quello che si immagina, che l’Isola Tiberina “è una nave”, e che a Campo de’ Fiori “Giordano Bruno continua a essere bruciato ogni sabato” quando appena smantellato il mercato e “mentre si smorza il puzzo di pesce, cloro e frutta marcita” i netturbini danno fuoco alle immondizie sotto ai suoi piedi.
Ai lettori d’oggi, questo piccolo volumetto rosso offre una lezione vitale: la scrittura – quando attraversata da una sottile ma non cinica malinconia consapevole – diventa intuizione netta, tensione prolifica verso il (comunque sempre inafferrabile) segreto d’esistere. A occhi aperti non è quindi solo un’antologia, ma un laboratorio di critica-lirica: vi si ritrova la voce di un’autrice che si emoziona, gioisce, insiste, soffre, risuona, reagisce. Per chi voglia attraversare quel confine tra parola e silenzio, tra pensiero e vita, un libro da leggere davvero, a occhi ben aperti.
Harper’s Bazaar Shopping List McQueen Occhiali da sole con fibbia
McQueen Occhiali da sole con fibbia JW Anderson Top con scollo all’americana
JW Anderson Top con scollo all’americana  Ferragamo Infradito con dettaglio grafico
Ferragamo Infradito con dettaglio grafico  Gucci Costume da bagno in jersey
Gucci Costume da bagno in jersey