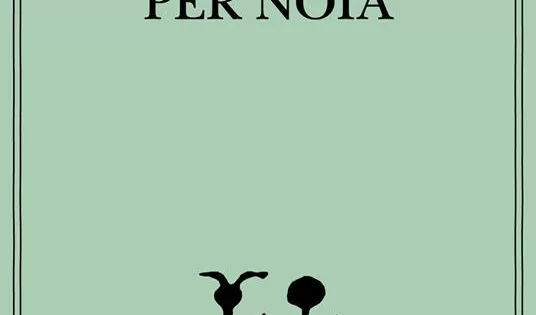Gli articoli di Ennio Flaiano raccolti in questo volume Adelphi (“Chiuso per noia”, a cura di Anna Longoni) sono per davvero una delizia per chi ama Flaiano e per chi ama il cinema: due piccioni con una fava. Si tratta di recensioni scritte dal grande scrittore, sceneggiatore, commediografo tra il 1938 e il 1970. È critica cinematografica pura, specie quella scritta per i pezzi che apparvero sul “Mondo” di Mario Pannunzio; articoli che oggi, in epoca di trafiletti, non si leggono più, e bisognerebbe che qualcuno ponesse il problema di una critica cinematografica (non parliamo più di quella teatrale) che ormai esiste davvero poco e non certo per colpa dei critici, razza in via di estinzione.
Ma innanzitutto, quale operazione deve compiere il lettore davanti a questo libro? Deve cercare di tenere distinti l’autore dall’oggetto dei suoi scritti, un po’ come consigliava Proust contro Saint-Beuve, sforzarsi cioè di separare Flaiano dall’oggetto della sua opera dimodoché possa risaltare pienamente la sua personalità: coltissima, ironica, “pirroniana”. Perché di recensioni di film è pieno il mondo, mentre gli scritti di Flaiano sono limitati, e perciò vanno gustati come bocconi squisiti e irripetibili di arguzia, saggezza e cultura. Insomma, va benissimo leggere di “Viale del tramonto” o “Miracolo a Milano”, o penetrare nella recondita filosofia di Rossellini (qui si parla di “Stromboli” e “Francesco giullare di Dio”): eppure la forza di questo volume sta in lui, Flaiano, tra i più inarrivabili intellettuali del Novecento italiano, nei suoi dubbi, nella sua ironia, nelle sue visionarie descrizioni dell’animo umano. Si ha l’impressione che Flaiano, scrivendo dell’ultimo film visto, avesse in testa tutta la storia del cinema, sorella minore, per uno come lui, della letteratura.
Da queste pagine emerge un intellettuale molto più avanti del suo tempo, e certi giudizi reggono ancora a decenni e decenni di distanza. Non manca qualche stranezza, come su Totò: mal giudicato nel 1939, ma stra-rivalutato tanti anni dopo. «Il genere di comicità del nobile Antonio de Cupis (così, se non erriamo, si chiama il nostro eroe) si basava, e si basa tuttora, su una mimica quasi acrobatica, su battute sciocche e più ancora sulla facilità di intendersi col pubblico ai danni di ogni cosa». Storpiò persino il nome, da De Curtis in De Cupis! Poi, molto dopo, lo elogiò giudicandolo «unico» nel suo genere. Cose che capitano anche ai grandi.
Restano magnifici certi suoi giudizi che vogliamo qui riportare. Sul capolavoro di John Ford: «Non ci stancheremo di parlar bene di queste “Ombre rosse”, anche perché arrivano dopo tante ombre pallide ed evanescenti, ombre di filmetti, di commediole, di rifriggiture. È un film di quelli che si rivedono». Sul film di Frank Capra: «Finisce per il meglio ne “L’eterna illusione”; poveri e ricchi, onesti e disonesti concludono inneggiando alla Vita e stringendosi la mano sopra l’Opera Omnia di Ralph Waldo Emerson. Il film è di propaganda contro la Ricchezza, che è la malattia americana, e mostra che si può guarirne in quindici giorni col metodo più semplice, cioè lasciandola». Su “Ossessione”: «Il film di Visconti è stato tratto, com’è noto, da un romanzo di James Cain che ha per titolo “Il postino suona sempre due volte”. Attratto dalla fatalità da proverbio che pesa sui protagonisti, Visconti ha saputo condividere la “loro” realtà, considerarla con estrema sollecitudine, senza cadere nell’approssimativo e senza dare giudizi. La macchina è mossa con una sapienza rara e indiscreta, il quadro è sempre denso, vive di vita propria. Quanto all’adattamento italiano di quei personaggi americani, una critica veristica ha rimproverato a questo film verista l’inverosimiglianza dei caratteri, il girovaghismo del protagonista, impossibile a sfogarsi in un paese come il nostro. Ma evidentemente quei critici non hanno mai letto l’elenco delle fiere paesane sul Barbanera e non hanno meditato l’infinita varietà di girovaghi che contempla e offre alla nostra fantasia».
E Rossellini, poi: «”Stromboli” è uno di quei pochi film che ci fanno capire, per contrasto (e la stessa impressione ce la dette “Monsieur Verdoux”), come la menzogna sia l’ispiratrice abituale del cinema; di quel cinema che ha creato un suo linguaggio morale e presenta la vita, le persone, le cose (che pure ci circondano e ben conosciamo) in una luce senza speranza, perché falsa. La nostra immaginazione è deviata, oppressa e forse un giorno ci accorgeremo che questo bel risultato lo dobbiamo proprio a ciò che abbiamo creduto fosse uno svago mentale. “Stromboli” è dunque un antiromanzo che riconduce la realtà alle sue proporzioni». Rossellini dunque è riuscito a far parlare il cinema da sé, ma andando ben oltre il semplice verismo, che è sempre “morale”, cioè giudicante: Rossellini invece non ha bisogno di giudicare, ed è questo il cinema puro – il paragone con l’amatissimo Chaplin non è casuale.
Eccolo dunque Charlot, «la sola invenzione letteraria valevole del cinema nei suoi primi cinquant’anni di vita (…) Ogni giorno è buono per lui per cominciare. E perché dovrebbe sentirsi infelice se nel “Circo” si ricorda che nei taschini del gilet ha un cucchiaio e una provvista di sale? L’anarchia di Charlot è tutta sentimentale. È un dinamitardo che si addormenta proprio mentre dovrebbe tirare la bomba nella carrozza dello zar. E il suo ottimismo è un prodotto del cuore, non del cervello».
Non c’è dubbio, e forse non poteva essere altrimenti, che Flaiano sia sempre rimasto fedele al cinema classico e ai suoi grandi maestri. La recensione di “2001, Odissea nello Spazio”, pur non priva di una certa arguzia, dimostra che il nuovo cinema gli restava estraneo. Non ci trovava il “cuore” di Chaplin. E nemmeno più la fantasmagorica tristezza del suo amico Fellini cui, com’è noto, diede un contributo enorme. Persino il luogo fisico dove andare a vedere i film non gli piaceva come prima. Il tempo era passato, e anche quel cinema là.
© Riproduzione riservata
Mario Lavia