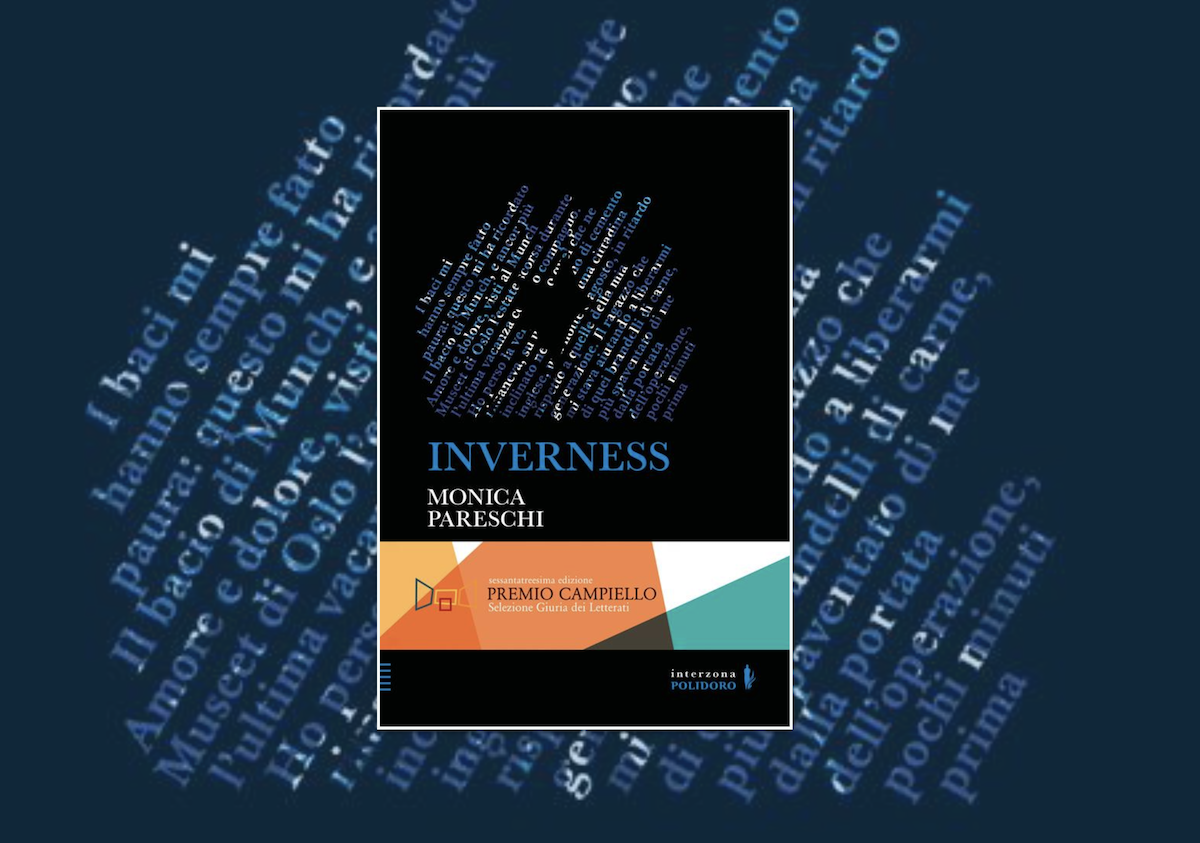
Voglio parlare di un libro molto bello che mi ha tenuto compagnia durante l’estate: Inverness, di Monica Pareschi, uscito nella collana Interzona diretta da Orazio Labbate (Polidoro Editore, Napoli 2025), raccolta di racconti a sorpresa inserita nella cinquina finalista del sessantatreesimo Premio Campiello.
I racconti, si sa, non hanno in genere molta fortuna in Italia, ma io sono contenta che questa volta non sia così: non solo la forma breve mi pare molto adatta a una comunità di lettori e lettrici che assegna alla lettura tradizionale di libri un tempo più corto di un tempo, ma la narrazione breve, quando è riuscita come in questo caso, ha una precisione e una poeticità che nei romanzi è distratta dalla trama.
La cerimonia di premiazione del Campiello avrà luogo sabato 13 settembre, a due giorni da questa mia nota. Se ho tardato, nel mio consiglio di lettura, è perché questo calligrafico ed emozionante mosaico di storie mi ha tenuto compagnia per ben due volte e, ora che ne scrivo, voglio trovare un modo per muovere la curiosità senza guastare la sorpresa, che non manca mai a conclusione di ciascuno degli 8 racconti.
Titolo e trama, per cominciare
Inverness è una città dell’estremo nord della Scozia e anche il titolo dell’ultimo racconto. «Andremo fino a Inverness», dice la protagonista e io narrante all’amica con cui sta pianificando un viaggio tra Interrail e autostop. «P. mi guarda con aria interrogativa. E perché? Mi piace il nome, rispondo. Quello che non dico è che è un nome pieno di sole e di luce ghiacciata, azzurra. Un nome che contiene l’Inverno». Una città e un’idea di inverno gelido e luminoso in piena estate, che però sono una specie di chimera, Eden astratto, ideale, illusorio.
In genere i racconti non si leggono come un romanzo, ma in questo caso l’unità è data dalla multiforme e polifonica riflessione sulle relazioni, dove il termine “riflessione” deve intendersi non tanto come articolazione del pensiero, o giudizio, quanto come atto di rispecchiamento della realtà umana.
Le protagoniste, mute o parlanti, a seconda della scelta narratologica e dell’angolo di visuale, sono identità che misurano l’attrito dell’esistenza (e in effetti dei loro corpi, infantili, adolescenti o maturi) nell’incontro con l’altro, sia esso l’amante, l’amica, o, archetipicamente, il genitore. Non occorre definire la tipologia della relazione per riconoscere che in ogni storia si delinea un microcosmo nel quale si muovono principalmente due caratteri tra cui nasce o si esaurisce una tensione che però non trova soluzione nell’incontro concreto, reale: non c’è coppia possibile (sentimentale o amicale), e neppure comunicazione; nella matematica delle relazioni secondo Monica Pareschi, 1 + 1 non dà luogo a un 2.
Il rischio dell’amore
Il primo racconto, I “Baci” di Munch, o la perfezione dell’amore, offre sin dall’incipit una chiave interpretativa, l’allusione all’incontro con l’altro come minaccia d’esistenza o pericolo mortale: «La nostalgia di sé, la perdita dell’uno, l’angoscia che attende la fusione indifferenziata è tutta nell’orecchio abbozzato, nella resa cruda della gola: nel baciare serriamo gli occhi, ottusi, sigillati, ciechi e sordi, badiamo a suggere, e a distruggere, la creatura nata morta» (pp. 10-11).
La fuga che caratterizza la prima protagonista di questo libro si riverbera con modalità differenti un po’ in tutta la raccolta, creando l’illusione che al centro del discorso stia sempre la stessa persona, inseguita e ritratta in momenti diversi della vita. La troviamo infatti bambina smaniosa, istintiva e selvatica, davanti a una grassa coniglia separata dalla prole per l’istinto (innaturale o naturale nonostante tutto?) di divorare i suoi piccoli. Alla scena fa eco il ricordo della madre umana, assediata dal pianto della bambina, ininterrotto fino ai tre anni: «Volevo uccidermi. O forse: volevo ucciderti» (p. 18).
Siamo nell’estate in cui per la bambina tutto cambia, in un paesaggio agreste e silenzioso, con poche presenze umane, ripugnanti per età e voracità. Il perturbante del racconto si fa largo tra piccoli segni, inquietanti o grotteschi, fino alla sorpresa finale che non disvelo e che ha i tratti di un sogno. Il titolo dice che questo è il suo Primo amore, sconvolgente, crudele, con l’aggiunta di un non detto che lascia incerti sulla direzione della crudeltà.
In un altro racconto, Fiori, troviamo la fuga della protagonista davanti a quello che potrebbe essere il più classico e pacifico dei corteggiamenti: una passeggiata, la bancarella dei fiori, un aperitivo da condividere su un tavolino forse troppo stretto, ma poi ecco i fiori in grembo, come una barriera, una difesa o una specie di alternativa. «Sembra che tutta la tua attenzione sia per questi fiori […]. C’è che questi fiori non chiedono niente. C’è che il loro amore è muto, puro e perfetto, e il mio per loro lo stesso. Non ci scambiamo nulla, se non un po’ d’acqua, e piacere per giorni. Per questo il mio desiderio è eterno. Loro non mi chiedono di essere vivi, mentre stanno morendo, non succhiano linfa da me per rimanere in vita perché sono già morti» (p. 41).
La voracità dell’amore
Ho fortunatamente letto e anzi consumato i racconti di Monica Pareschi nel formato cartaceo dell’opera. Se avessi scelto la lettura digitale, forse avrei ceduto alla curiosità di rintracciare con più precisione nel testo i riferimenti al cibo e all’atto del mangiare, succhiare, ma anche espellere, rigurgitare. La scrittura di Pareschi è intimamente corporea e mi pare che il cibo sia concreta metafora dell’amore irrisolto, che dell’impossibilità dell’amore (o di quella che per la scrittrice è proprio la sua perfezione) il cibo rappresenti un correlativo oggettivo. Troppo amore uccide – di qui la fuga, il ritrarsi, da quello come da ogni nutrimento.
Tra baci rubati, incontri dolorosi, umiliazioni e rifiuti, si palesa una forma ricorrente nelle protagoniste: congelate o rallentate da una solitudine, che chi legge immagina necessaria a sopravvivere a un primo dolorosissimo rifiuto: «Papà, penso. Poi lo ripeto forte, papà. Le volte che non mi hai amata, le volte che non sono riuscita a farmi amare da te: Il respiro mozzato sempre, le pastiglie per respirare, le pastiglie per dormire: Sono stata brava, papà. Un piede avanti all’altro, ogni giorno, senza desideri, l’ordine delle cose. Ho studiato, mi sono laureata, sono andata a insegnare in montagna. Sono tornata, ho lavorato, sono rimasta a casa. Non ho sbagliato mai, non mi hai visto mai sbagliare». Per queste donne e bambine la diffidenza nei riguardi del cibo, talvolta il disgusto e poi il rifiuto, suggeriscono una risposta adattativa che interessa anche la sfera dei sentimenti.
La lingua dell’amore
Secondo una leggenda molto nota di cui non saprei ora ricostruire l’origine, l’imperatore Federico II, più assetato di conoscenza che pietoso, ordinò un terribile esperimento: per conoscere la nascita del linguaggio naturale, furono selezionati alcuni neonati e si diede ordine alle madri e alle nutrici di non rivolgere ai bambini alcuna parola. I bambini, come è noto, morirono tutti. Forse, oltre alle parole, si vietarono ai neonati anche altri contatti non strettamente essenziali alla sopravvivenza, in ogni caso l’esperimento confermò l’idea che le parole siano una forma essenziale di cura.
Dell’esperimento federiciano è lecito dubitare, ma sappiamo con certezza che i neonati al cui pianto non sia data risposta, smettono di piangere. È esperienza esistenziale dei troppi bambini che sperimentano precocemente l’abbandono, ma anche di altri che, pur amati, sono stati privati di qualche abbraccio per un pregiudizio fin troppo diffuso nella storia della pedagogia occidentale: il pianto sarebbe fin dal principio un capriccio, e la tenerezza, lungi dal temprare il carattere, renderebbe deboli e viziate le piccole creature. Non mi dilungo, sono espressioni così diffuse nelle generazioni che ci hanno preceduto che possiamo considerarle patrimonio comune, senza stupirci che di tanto in tanto tornino in auge.
Il punto però è un altro: il bambino che non piange non è un bambino ben educato, ma un cucciolo che rinuncia al suo richiamo perché ha perso fiducia nella risposta e perciò si adatta a costruirsi e a sostenere da solo un esoscheletro che lo tenga in piedi e lo guarisca dal bisogno degli altri. La sua quiete è una fuga che precorre l’ipotesi di un secondo rifiuto, insostenibile.
Mi scuserete se sono uscita dai sentieri collaudati e mi muovo su quelli pedagogici, infinitamente meno solidi per me, ma la storia dell’umanità, delle arti e della letteratura, mi sembra indicare che anche la risposta adattativa, l’esoscheletro, contempla (spesso se non sempre) un enorme potenziale di bellezza. Tu, sanguinosa infanzia, è il titolo di una raccolta di racconti di Michele Mari (Einaudi, Torino 1997). La associo a quella di Monica Pareschi (oltre che per la circostanza di aver conosciuto personalmente entrambi gli autori, una decina d’anni fa, in una trasferta marchigiana, in occasione del Premio Letterario Fano) perché mi pare che ci sia in entrambi i libri l’idea la prima stagione dell’esistenza definisca un nucleo emotivo archetipico di altre successive esperienze, ma offra anche ad alcuni la cura della scrittura.
Il linguaggio dei bambini, e anche quello degli adulti, è l’originalissima soluzione che distingue il genere umano da ogni altra specie vivente. La narrazione è un modo per tenere insieme persone che altrimenti sarebbero estranee e c’è la possibilità che incontrarsi nella scrittura/lettura di un racconto permetta di riconoscere una prossimità superiore a quella che condividiamo con chi ci fa compagnia nella vita reale. Le storie raccontate uniscono chi scrive a chi legge ma anche i lettori fra loro, generando comunità del libro oggi sempre più rare.
Avete presente quando in un paese straniero sentite una parola italiana, o riconoscete una posa familiare, l’abito o la scarpa che hanno tutti nella vostra città d’origine? Fuori dall’Italia ci chiama al sorriso anche il concittadino a cui, a casa, non presteremmo attenzione. Quest’esperienza di familiarità è mille volte più intensa quando ci si trova co-lettori di un autore o di un’opera che ci ha profondamente toccato, come sono i classici che Pareschi ha tradotto, o come mi auguro sarà questo suo libro. Sono certamente due esperienze differenti, ma entrambe riguardano identità e riconoscimento.
Insomma quella relazione che, secondo le narrazioni di Pareschi, si incaglia nel mondo reale, in quello delle parole genera invece un’eccezionale chance di prossimità. C’entra sempre la compassione. Ho già scritto in altri articoli che questa è per me la virtù sovrana? Temo di averlo fatto anche troppo.
Monica Pareschi è una straordinaria traduttrice letteraria: sua è la voce italiana di (tra gli altri) Doris Lessing, Willa Cather, James Ballard, Bernard Malamud, Alice McDermott, Shirley Jackson, Hisham Matar, Charlotte e Emily Brontë. Dall’aver a lungo dialogato con la scrittura altrui l’autrice ricava una prosa precisissima, dura (graffiante) quanto basta, ma poi a tratti lirica e leggera, tanto che il sorriso non manca. Io mi sono commossa leggendo e vorrei proprio testimoniare con queste poche righe che la letteratura è ancora capace di questo.
Non serve aver avuto esperienze identiche o simili a quelle dei personaggi per sentire che abitano la nostra coscienza. Leggere Inverness fa bene a quelle piccole ferite nascoste che, specie i più giovani, possono sentire come una dotazione esclusiva, mentre, a ben guardare, sono il patrimonio, crudele ma anche generoso, dell’umanità tutta.