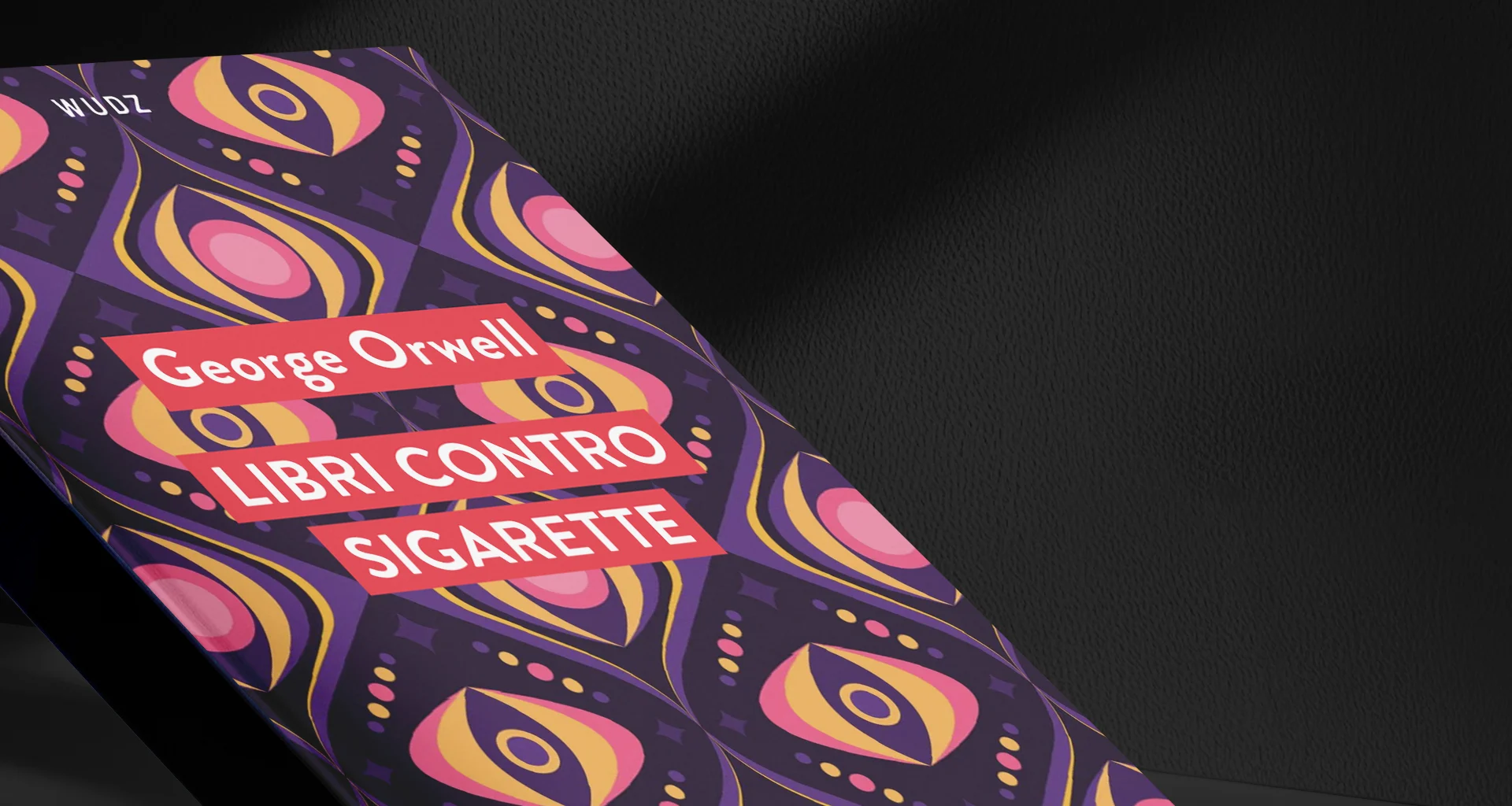La libertà comincia da una pagina scritta. Eric Arthur Blair (Motihari, India, 1903 – Londra, Regno Unito, 1950), «in arte e nella vita» conosciuto con lo pseudonimo di George Orwell, ha percorso il suo quasi mezzo secolo d’esistenza (morirà a soli 46 anni di tubercolosi), tracciando affermativamente mirabili orizzonti scontornati, degni della «direzione ostinata e contraria» intonata dal grande Fabrizio De André.
Il Novecento di Orwell – considerando opere memorabili come Omaggio alla Catalogna (1938) e La strada di Wigan Pier (1937) -, è già il tempo temibile e terribile che si prepara «all’ancor peggio».
Tra le macerie di guerra, la devastazione della menzogna e il volto sporco della propaganda, Orwell abbracciò l’impegno di Spagna, ritrovando nell’umana cooperazione tra pari la bellezza di un mondo, che non voleva arrendersi al tristemente concesso.
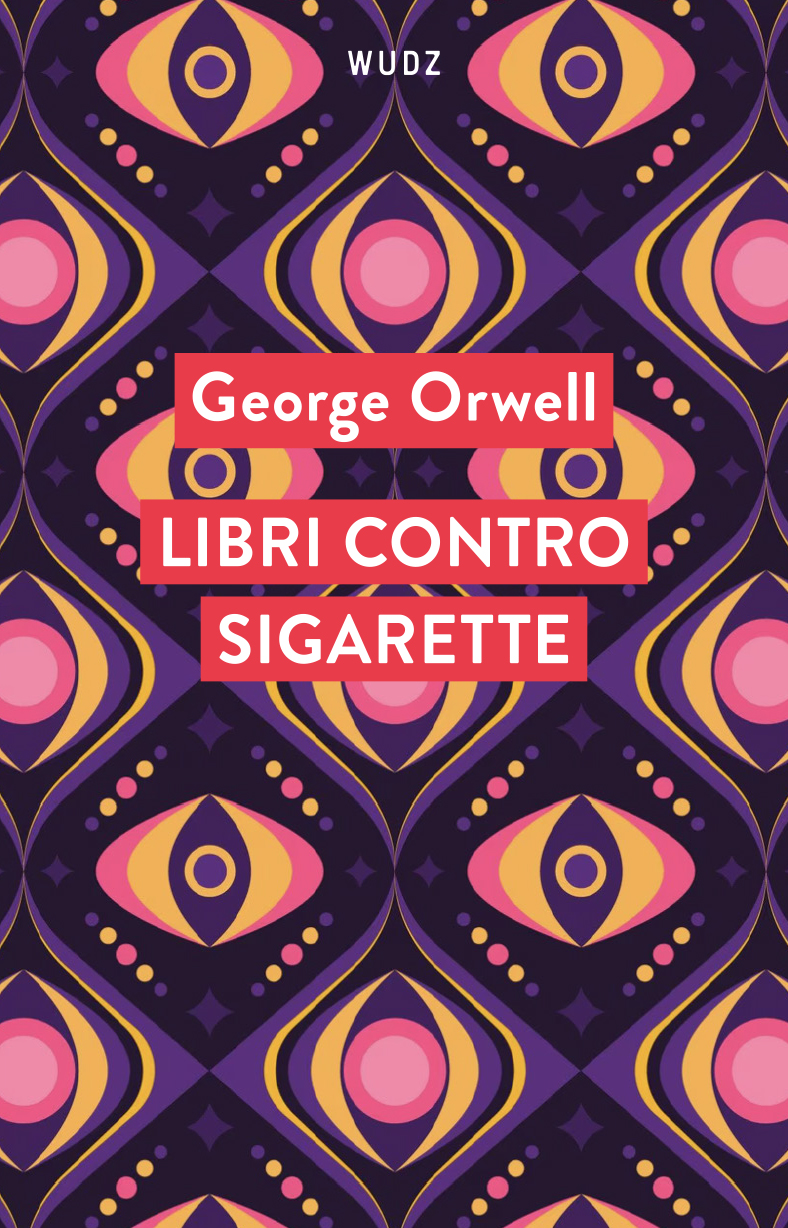 George Orwell, Libri contro sigarette (2025), Wudz edizioni.
George Orwell, Libri contro sigarette (2025), Wudz edizioni.
Come ebbe modo di annotare nei suoi diari, divenuti libro e reportage:
«[…] a chi arrivava fresco dall’Inghilterra, Barcellona appariva straordinaria, travolgente. Per la prima volta mi trovavo in una città dove la classe operaia aveva preso le redini. […]
Nella Caserma Lenin di Barcellona, il giorno prima di arruolarmi […] vidi un volontario italiano in piedi davanti al tavolo degli ufficiali. […] C’era qualcosa in quel volto che mi toccò nel profondo: era la faccia di chi avrebbe ucciso e sacrificato la propria vita per un amico […] Esprimeva candore e, al contempo, ferocia […]
Quando fummo per uscire, attraversò la stanza e venne a stringermi la mano con forza. Strano l’effetto che si può provare per uno sconosciuto. Fu come se per un attimo le nostre anime avessero colmato ogni distanza fra le lingue e le tradizioni per incontrarsi nell’intimità più autentica.
Sperai di piacergli quanto lui piaceva a me, ma ero anche consapevole del fatto che per mantenere quella prima impressione non avrei dovuto rivederlo. E neanche a dirlo, non lo vidi mai più. Incontri di quel tipo accadevano continuamente in Spagna». (Orwell; 1938)
In una vita a margine tra scrittura e impegno nella lotta attiva, George Orwell ha celebrato e messo sotto processo qualsivoglia visione data e autoreferenziale della realtà: contravvenendo ai sogni di un progresso fagocitante, il non signor Blair ha per tempo rincorso e dato voce ai bambini incatenati e sfruttati nelle miniere di carbone in suolo britannico.
Distaccandosi dalle brutture e violenze incontrate sul campo di un’indagine trentennale, larga parte della sua esistenza ha avuto luogo nel profumo di un giardino, coltivato con dedizione e amore, nelle campagne inglesi.
Come ha illuminato Rebecca Solnit nell’assai profondo saggio (dedicato a) Le Rose di Orwell (2021):
«In un’epoca di menzogne e di illusioni, il giardino è un modo per radicarsi nel regno della crescita e del passare del tempo […] Gli alberi sono un invito a pensare al tempo e a viaggiarci attraverso nel modo in cui lo fanno loro: in piedi, in silenzio, protendendosi verso l’esterno e verso il basso».
Una bella e recentissima edizione di Libri contro sigarette (2025) della casa editrice aretina Wudz, riprende la raccolta di alcuni fondamentali scritti di George Orwell per illuminarne la contemporaneità, in rapporto a temi quali la libertà di espressione, nonché le insidie verso cui viaggia da tempo l’universo della carta stampata.
Soffermandosi su un contributo di stringente attualità come La prevenzione della letteratura, ospitato nel gennaio 1946 dalla rivista inglese Opinion, è possibile rintracciare una serie di riflessioni puntuali e, ancora una volta, preveggenti sullo stato di salute della libertà di stampa.
Ne riferisce, in proposito, Orwell:
«Tutto, attualmente, cospira per fare dello scrittore, e anche di qualsiasi altro tipo di artista, un piccolo funzionario all’opera su argomenti imposti dall’alto, senza che mai egli possa proferire una parola su quella che gli sembra essere la verità».
Partendo da considerazioni attorno all’organizzazione di un evento-principe, un seminario, che avrebbe potuto e dovuto naturalmente ragionare l’importanza e la salvaguardia della libertà di espressione, lo scrittore rammenta:
«La libertà morale – la libertà di discutere di questioni sessuali in modo esplicito sulla carta stampata – sembrava in generale riscuotere il consenso generale, ma non si accennò minimamente alla libertà politica.
In quell’assemblea di diverse centinaia di persone, di cui forse la metà direttamente legata al mondo della stampa, nessuno seppe evidenziare che la libertà di stampa, se ha un qualche significato, vuol dire libertà di critica e di opposizione. […] In realtà, l’incontro si dimostrò una manifestazione a favore della censura».
Non risparmiando invettive contro qualsivoglia congrega intellettuale e pseudo progressista – aperta al dialogo nella sola forma in cui ad esser mantenuto è il solo e ristretto privilegio -, George Orwell ragiona la portata di quel che potrà essere un universo futuro, dinanzi allo schiudersi di nuovi mezzi e strategie della comunicazione:
«Con ogni probabilità romanzi e storie verranno […] soppiantati da film e programmi radio. O qualche tipo di narrativa sensazionalistica di basso livello sopravvivrà, prodotta da un procedimento industriale su nastro trasportatore che riduce al minimo l’iniziativa umana.
Scrivere libri con un macchinario non sarebbe probabilmente al di sopra delle possibilità dell’umano ingegno. Ma già si può vedere all’opera una specie di processo meccanizzato in film e radio, pubblicità e propaganda, e ai livelli più bassi del giornalismo. […]
L’immaginazione – perfino la coscienza […] – sarebbe eliminata dal processo di scrittura. I libri verrebbero progettati a grandi linee dai burocrati, passando per così tante mani che, una volta completati, non sarebbero il prodotto di un individuo più di quanto lo è un’automobile della Ford alla fine della catena di montaggio.
Va da sé che qualsiasi oggetto prodotto in questo modo sarebbe una schifezza: ma qualsiasi oggetto che non fosse una schifezza metterebbe a rischio la struttura dello Stato».
In rapporto alla figura somma di Orwell non si dovrebbe mai trascurare l’influenza e l’amorevole, quanto ribelle, appoggio ricevuto negli anni della formazione da parte di una donna estremamente passionale e controcorrente.
Hélène Limouzin, detta Nellie – zia dello scrittore per parte di madre e suffragetta in lode della causa femminista -, fu la portentosa forza centrifuga da cui mossero e presero avvio le aspirazioni condivise e i sogni di riscatto di un giovane uomo.
Nellie, che, come Orwell, aveva scelto di abbracciare l’aspirazione al cambiamento in devozione di un mondo più giusto, fu a sua volta la redattrice di articoli impegnati nelle lotte sociali.
Nell’umile e vivace spazio domestico parigino, entro cui Nellie offrì accoglienza al giovane nipote sulla via della scrittura, pare allora di udire i racconti del più anziano compagno della donna, un anarchico francese di nome Eugène Adam, che visse ardentemente la Russia al tempo della sua Rivoluzione di ottobre (1917).
Sembra ancora possibile carpire l’enfasi, e quel credo passionale, che rivive anche in Mario Tronti quando, in uno scritto pubblicato postumo, confida:
«io voglio salvare la Rivoluzione d’Ottobre dalle sorti del socialismo realizzato. Ne ho bisogno, non solo per continuare a pensare, ma per continuare ad agire, pensare e agire contro il presente stato delle cose, per rovesciarlo “superandolo” […]». (Tronti; 2024)
Libri contro sigarette, assieme alla curiosità passionale di un uomo che non ha mai smesso di interrogare la vita come la sua stessa coscienza, costituisce una delle chiavi essenziali per entrare in contatto con il credo autentico di uno scrittore divenuto insostituibile, proprio perché negligente in quella arrogante, o tristemente consueta, pretesa di esserlo.
Floriana Savino terminati gli studi classici, si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bari, con indirizzo Decorazione, conseguendo la Laurea magistrale in Arti Visive con il massimo dei voti, nel febbraio 2020. L’interesse per l’espressione artistica nasce dalla possibilità evocativa dei simboli archetipici e dal processo metodologico alla base di ogni creazione. Tra le sue partecipazioni vi sono mostre ed esposizioni a carattere nazionale e internazionale. Attualmente collabora con riviste accademiche e testate indipendenti che indagano le forme dell’abitare, in stretto sodalizio con arte, architettura e nuova urbanistica. È docente di Storia dell’Arte Moderna e Storia della Stampa e dell’Editoria presso la LABA di Rimini, di Linguaggi dell’Arte Contemporanea e Storia dell’Arte Moderna per l’Accademia di Belle Arti di Sanremo.