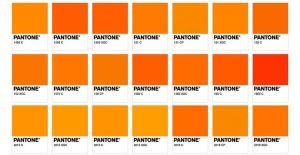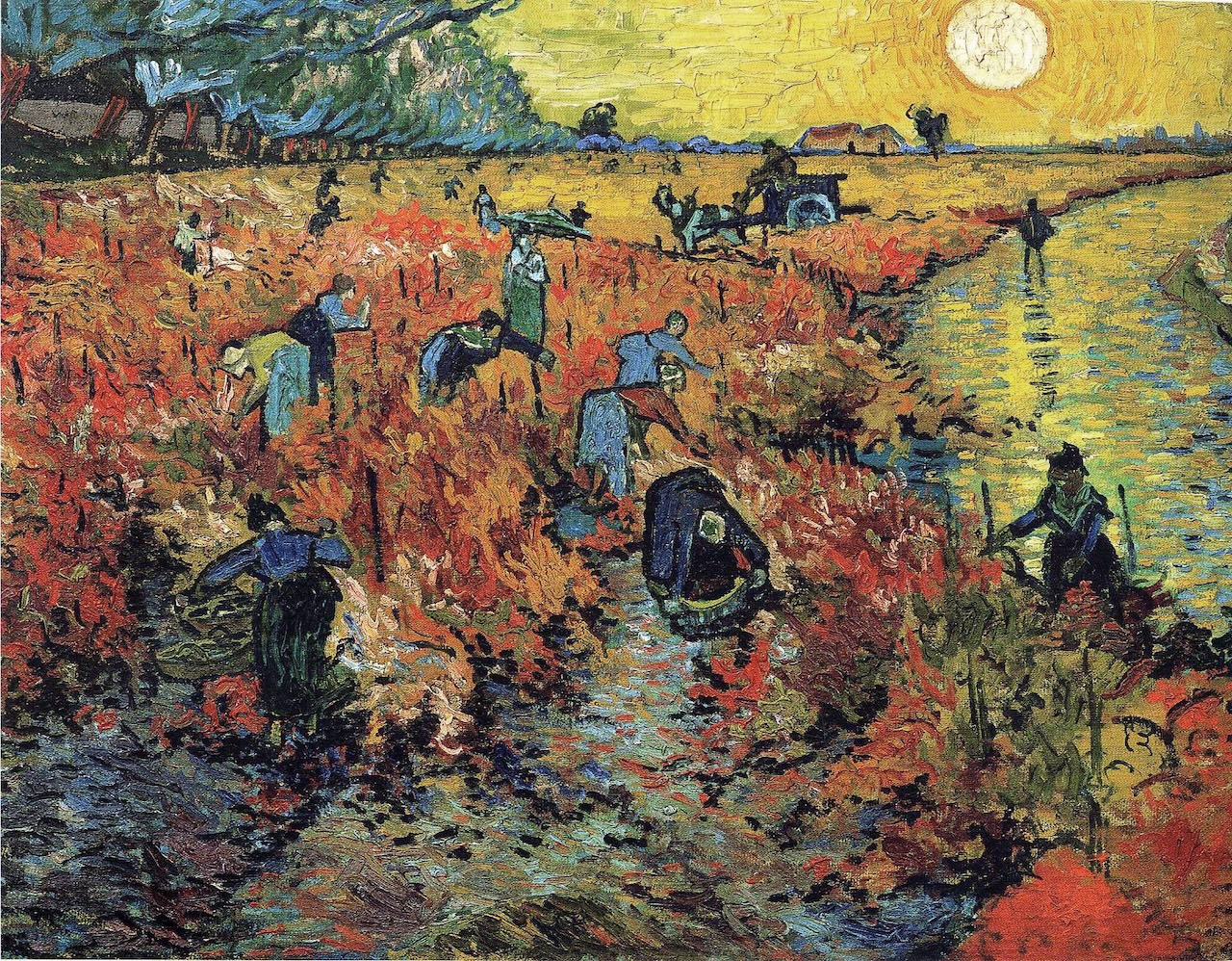C’è stato un momento, non più di pochissimi anni fa, in cui bere un bicchiere di orange wine — quei bianchi trattati come rossi, macerati a lungo sulle bucce, con profumi ossidativi e cromie che oscillano tra il tramonto e la ruggine — era come fumare una Gauloises in un bar di provincia popolato da Marlboro: un segno di appartenenza a un’élite culturale, un atto di resistenza contro la banalità seriale dei Sauvignon e dei Pinot Grigio da scaffale del supermercato.
Poi, come spesso accade alle avanguardie che funzionano troppo bene, la nicchia si è fatta moda, la moda è diventata mercato, e il mercato caricatura. Alla fine, quell’arancio è sbiadito: ciò che prometteva di essere una rivoluzione enologica — la Amber Revolution, come l’ha battezzata Simon J. Woolf — ha lasciato soprattutto un retrogusto ironico e amaro, più vicino al disincanto che alla palingenesi.
Com’è stato possibile? E soprattutto, come mai in così poco tempo?
Gli orange wine sono stati raccontati come il ritorno a una tecnica ancestrale: le anfore georgiane, le bucce immerse nel mosto per settimane, la sapienza dei vignaioli caucasici che “sapevano già tutto”. Più che una semplice ripresa filologica, è riuscito però soprattutto un racconto: una narrazione capace di trasformare un gesto antico in segno contemporaneo, capace di intercettare un bisogno diffuso di autenticità e di diversità. In breve, l’“archeologia liquida” è stata anche un dispositivo di comunicazione potente, che ha permesso a questi vini di emergere come alternativa all’omologazione globale.
Un vino con note ossidative, tannini insoliti (per un bianco), e aromi di erbe e infusi non era soltanto un’esperienza sensoriale diversa, ma anche un simbolo culturale: il gusto del “naturale” in opposizione al convenzionale, del piccolo in contrapposizione al grande, del non filtrato contro lo standardizzato. Gli orange wine sono così nati quasi come “vini contro”: contro la limpidezza impeccabile, contro la riproducibilità infinita, contro la parkerizzazione degli anni Duemila. In altre parole, erano anche un invito a ripensare il vino proprio là dove sembrava aver smesso di sorprendere.
Come tutte le mode, la traiettoria è stata quasi da manuale. In un primo momento, gli orange wine hanno abitato i margini: enoteche radical-chic di Brooklyn, bar indipendenti a Berlino, ristoranti sperimentali a Copenaghen. Luoghi dove bere un calice ambrato non era tanto un’esperienza gustativa, quanto un atto performativo: un modo di dichiarare appartenenza a un microcosmo intellettuale, un gesto capace di funzionare come password simbolica. In quegli ambienti, bere orange era come citare Derrida a un tavolo di bistrot: non importava solo il contenuto, ma la dimostrazione di padroneggiare un linguaggio.
Poi però è arrivata la fase dell’istituzionalizzazione: i ristoranti stellati hanno preso in carico il fenomeno, abbinando questi vini a piatti concettuali magari di cavolo fermentato o caviale di quinoa, collocandoli all’interno di un’estetica gastronomica che ha fatto dell’alterità un elemento di lusso. Da opposizione a sistema, insomma.
Infine è giunta la fase della diffusione di massa, quando la bottiglia arancio è finita negli scaffali della grande distribuzione “green”, accanto all’acqua di cocco e alle chips di cavolo nero. È in questo passaggio che la controcultura si è trasformata in prodotto di largo consumo.
E come accade spesso in questi cicli — dalle sottoculture giovanili alla moda dei superfood — il momento della massificazione coincide con quello della crisi (che attenzione non significa declino). Ciò che era stato simbolo di differenza diventa allora qualcosa più declinato verso il conformismo.
Un momento chiave della parabola degli orange wine è stato colto con lucidità, (e prima di tutti) da Wine Enthusiast in un articolo del 10 settembre 2024 – “Orange Wine Can’t Be ‘Cool’ Forever. That’s a Good Thing” di Hannah Walhout – dove si osserva come il fenomeno sia passato dal clamore entusiastico a una sorta di stanchezza collettiva.
E qui entra in gioco la questione centrale: la macerazione. Per anni è stata celebrata come un gesto quasi eroico, una sospensione del tempo enologico, un ritorno a un’idea di autenticità. Ma, come spesso accade quando un processo tecnico diventa bandiera culturale, la medaglia ha anche un rovescio.
La macerazione però – a mio sindacabilissimo giudizio – rischia di trasformarsi in una sorta di scorciatoia stilistica, capace di uniformare più che distinguere. Se tutti i produttori adottano lunghe macerazioni, ossidazioni controllate e tannini volutamente “rustici”, allora la firma dominante diventa il metodo, non più la geografia, e quindi il territorio, il vitigno o il microclima. Ne risulta un linguaggio gustativo forse prevedibile, dove i vini finiscono per assomigliarsi troppo, e dove l’etichetta “con buccia” rischia di valere più della voce del territorio che li ha generati.
C’è poi anche un rischio di appiattimento emotivo: tannini asciutti e note ossidative marcate, se ripetuti all’infinito, smettono di sorprendere. Quello che all’inizio sembrava un orizzonte nuovo diventa un gioco prevedibile, più vicino a un esercizio di stile che a un piacere da condividere a tavola. Il vino, insomma, rischia di trasformarsi in performance sensoriale, gesto da interpretare più che da bere.
A complicare le cose interviene il linguaggio del marketing, che ha trasformato “orange wine” in una buzzword: un’etichetta facile da applicare, un filtro estetico buono per ogni occasione, col pericolo di banalizzare una categoria in realtà complessa e sfaccettata. È proprio qui che, come ha colto con finezza Wine Enthusiast, nasce il backlash, prosaicamente traducibile come il rinculo: quando il bello diventa uniforme, quando il complesso si riduce a cliché, quando ciò che era segno di identità rischia di scivolare nella caricatura di sé stesso.
Dal vino al feticcio, dal feticcio al reietto? Le cose non stanno esattamente così.
Oggi, infatti, parlare di “tramonto” degli orange wine rischia di essere fuorviante. Non sono affatto scomparsi, né confinati in una nicchia marginale: al contrario, forse non se ne è mai prodotti e bevuti così tanti. A cambiare non è stata la quantità, che anzi è esponenzialmente aumentata, ma lo status simbolico. Dieci anni fa, una bottiglia di orange era un talismano di distinzione, il segno di un’appartenenza culturale rara e un po’ esoterica. Oggi è diventata una tipologia codificata, replicata in cantine che non avevano alcuna tradizione di macerazione e che l’hanno adottata come opzione di catalogo, una linea in più accanto al bianco e al rosso e alla “fottuta” bollicina.
In questo senso, l’orange wine ha seguito lo stesso destino di fenomeni come il biologico: da pionieristico e rivoluzionario a pratica diffusa, standardizzata e, proprio per questo, meno narrata e meno sorprendente. Se ne parla meno perché non stupisce più, ma intanto le bottiglie si sono moltiplicate: la forza propulsiva simbolica si è esaurita, mentre quella numerica si è consolidata.
[Vincent van Gogh – The Red Vineyard. unico dipinto che Van Gogh riuscì certamente a vendere durante la sua vita]
Perché allora il disincanto? Oltre alle ragioni già evidenziate, potremmo dire in parte per ragioni economiche: i prezzi dei benchmark sono lievitati, e molti altri hanno seguito a ruota anche se non sempre giustificati dalla qualità. In parte per ragioni sensoriali: non tutti amano bere un bicchiere che sa di buccia di mela ossidata e tannini asciutti come la sabbia del deserto. In parte per ragioni sociali: l’orange è diventato un “vanto da Instagram”, e come ogni foto filtrata con troppi colori, ha perso in fretta il suo fascino.
Cosa ci dice questo del mercato del vino? Che il vino, prima ancora che un prodotto agricolo, è un simbolo: lo scegliamo e lo beviamo non solo per il suo sapore, ma per ciò che rappresenta. Le storie che lo accompagnano non sono un contorno: sono parte del prezzo, e spesso la parte più decisiva. Che il vino è anche identità liquida. Il bicchiere in mano diventa un modo per dire chi siamo, con chi vogliamo stare, a quale tribù apparteniamo. Soprattutto in contesti urbani e digitali, bere non è mai solo bere: è comunicazione sociale. E infine, che il mercato del vino segue la stessa legge di ogni moda: assorbire, metabolizzare, amplificare e banalizzare.
Cosa ci dice di noi appassionati? Che siamo animali simbolici, più che sensoriali. Non ci basta il sorso, vogliamo la storia che lo accompagna: l’etichetta come romanzo breve, il bicchiere come specchio dell’anima. Nell’anfora georgiana non cerchiamo il tannino, ma una promessa: che da qualche parte, nel passato spesso, esista ancora un’autenticità da ritrovare.
E come nota Wine Enthusiast, non è l’ignoranza a portarci al backlash, ma il troppo pieno: saturazione, noia, desiderio di novità.
Siamo creature instancabili di nostalgia e di futuro, sempre alla ricerca del prossimo mito da bere.