Dal 16 al 18 settembre 2025, il Politecnico di Torino ha ospitato la XVIII Conferenza ESPAnet Italia, tradizionale appuntamento del network nazionale che riunisce studiosi e studiose delle politiche sociali. L’edizione di quest’anno, intitolata “Tecnologia, clima, cambiamento demografico: sfide e risposte di politica sociale in un mondo in transizione”, ha stimolato una riflessione ampia e multidisciplinare sulle trasformazioni che stanno ridisegnando i sistemi sociali, economici e di welfare.
La Conferenza ha posto l’accento sulla cosiddetta tripla transizione – ecologica, tecnologica e sociodemografica – e sui profondi cambiamenti che essa implica: dalla ridefinizione dei rapporti tra esseri umani e ambiente alle nuove modalità di produzione e redistribuzione delle risorse, fino alla necessità di ripensare i sistemi di welfare in un’ottica di maggiore inclusività, sostenibilità e resilienza.
Welfare, statualità e capacità istituzionali in Italia. Bilancio di un lungo percorso
Maurizio Ferrera, nostro Supervisore Scientifico, ha tenuto un keynote speech su welfare, statualità e capacità istituzionali in Italia. Oltre a questo intervento, il gruppo di Percorsi di secondo welfare ha dato il proprio contributo a questo ricco dibattito con una serie di interventi che hanno riguardato temi cruciali per il futuro del welfare: l’invecchiamento attivo, il ruolo delle istituzioni culturali nei processi di inclusione sociale, e le sfide strutturali e organizzative del Servizio Sanitario Nazionale.

Cultura e partecipazione: leve di inclusione del secondo welfare
La Sessione 19, coordinata da Chiara Agostini e Anastasia Rita Guarna, è stata dedicata interamente al ruolo del secondo welfare nelle nuove dinamiche sociali, affrontando temi quali il Terzo Settore nei contesti metropolitani, la conciliazione tra vita e lavoro, il welfare fiscale e la governance multilivello.

Qui, Alice Sofia Fanelli, Alessia Borromeo e Franca Maino hanno presentato il paper “Quando la cultura incontra le comunità: agenzie culturali locali, musei e biblioteche come leve di partecipazione inclusiva e capacitante”.
Il lavoro parte da una constatazione: le istituzioni culturali – musei, biblioteche, agenzie culturali – stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante non solo come luoghi di fruizione culturale, ma anche come spazi di partecipazione, co-progettazione e inclusione sociale. In particolare, il paper mette in luce come queste realtà, soprattutto nel Sud Italia, possano diventare infrastrutture sociali capaci di stimolare fiducia, senso di appartenenza e coesione comunitaria.
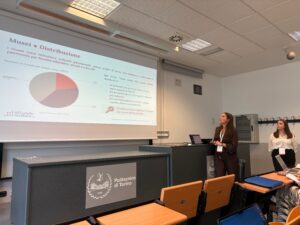
Attraverso l’analisi di dati quantitativi e qualitativi – numeri, accessi, introiti e visitatori di musei, siti archeologici e biblioteche – e l’esame di esperienze concrete, il contributo mette in luce il potenziale trasformativo della cultura. In particolare, mostra come iniziative culturali di prossimità possano avere un impatto significativo nel rafforzare il tessuto sociale locale. In questa prospettiva, la cultura non è più solo un diritto da tutelare, ma diventa una leva strategica per l’innovazione sociale e lo sviluppo territoriale.
Invecchiamento attivo e nuovi modelli abitativi
Un secondo ambito di approfondimento che ha visto coinvolto il nostro gruppo di ricerca è stato quello dell’invecchiamento, trattato nella Sessione 8, coordinata da Franca Maino, Valeria Celestina De Tommaso e Cristiano Gori (Università degli Studi di Trento), in cui sono stati discussi sette paper mettendo a confronto approcci disciplinari diversi sui temi dell’ageing in place, PNRR e domiciliarità, longevità attiva, politiche per i caregiver e bridge employment, ovvero le forme di impiego ponte tra il lavoro di carriera e il ritiro definitivo dal mercato del lavoro
In un contesto in cui l’aumento della popolazione anziana rappresenta una delle principali sfide sociali, il contributo di Franca Maino, William Revello, Antonio Talarico e Manuela Cristaldi ha posto l’attenzione su il progetto Abitare Villa Mater, un innovativo community hub per la longevità attiva avviato a Rivoli (TO).

Si tratta di un modello abitativo collaborativo per persone over 65 autosufficienti, che combina spazi privati con aree comuni progettate per stimolare socialità, attività fisica e cognitiva, e sostegno reciproco. Ciò che rende il progetto particolarmente interessante è la sua impostazione partecipativa e multidisciplinare, che integra saperi diversi – dalle scienze sociali all’architettura – e coinvolge attivamente cittadini, professionisti e stakeholder locali. Nonostante le dimensioni ancora ridotte, Abitare Villa Mater rappresenta un laboratorio di innovazione sociale, in grado di ridefinire l’invecchiamento non come fase di declino e marginalità, ma come momento di partecipazione attiva e contributo alla comunità. Questo approccio anticipa un possibile cambio di paradigma nel welfare, da un sistema prevalentemente reattivo a uno più generativo e preventivo.
Il Servizio Sanitario Nazionale di fronte alla transizione post-pandemica
Infine, le ricercatrici di Percorsi di Secondo Welfare hanno partecipato alla Sessione 21, dedicata al Sistema Sanitario Nazionale (SSN), con due interventi che hanno affrontato da prospettive diverse le sfide del settore sanitario in Italia.
Franca Maino e Marco Betti hanno presentato il paper “Modelli regionali ed esiti sanitari: caratteristiche e performance del SSN nel post-pandemia”, che analizza l’evoluzione dei Servizi Sanitari Regionali (SSR) italiani alla luce del processo di regionalizzazione. Attraverso una cluster analisi, sono stati individuati quattro modelli di SSR che evidenziano performance molto differenziate, confermando la persistenza di divari territoriali ma superando la tradizionale divisione Nord-Sud. Dallo studio emerge anche come configurazioni differenti possano generare esiti simili, purché siano garantite adeguate capacità istituzionali e di governance. Lo studio offre spunti rilevanti per il dibattito sull’autonomia differenziata e per la ricerca di nuovi equilibri tra decentramento e coerenza del Sistema sanitario italiano.
Chiara Lodi Rizzini e Ilaria Caracozza hanno invece presentato il paper “Accesso alle cure odontoiatriche: la leva del welfare bilaterale”, che si concentra su un tema ancora poco esplorato ma cruciale: l’accesso alle cure odontoiatriche. La ricerca mostra come questo settore sia caratterizzato da scarsa copertura pubblica e alta spesa privata diretta, con conseguente rischio di rinuncia alle cure per le fasce più vulnerabili. In questo scenario, i fondi sanitari integrativi possono svolgere un ruolo importante, contribuendo a ridurre i costi a carico delle famiglie e migliorando l’equità di accesso alle prestazioni.

Per un welfare innovativo e inclusivo
La partecipazione di Percorsi di Secondo Welfare alla XVIII Conferenza ESPAnet Italia ha dunque rappresentato un’occasione preziosa per condividere ricerche, esperienze e riflessioni su temi di grande rilevanza sociale.
Franca Maino a margine della Conferenza ha sottolineato come “i diversi interventi del gruppo di ricerca di Percorsi di Secondo Welfare offrono evidenze analitiche ed empiriche a un dibattito che, riprendendo il tema del doppio deficit di statualità richiamato da Maurizio Ferrera nel suo keynote speech, individua come leve di rilancio delle politiche sociali da un lato la razionalizzazione e professionalizzazione della Pubblica Amministrazione, dall’altro la capacità dello Stato di ridefinire ruolo e ambiti di intervento”.
“In questa prospettiva” ha continuato la professoressa “il rafforzamento della state-ness si configura come dimensione autonoma e imprescindibile, da affiancare alla trasformazione della welfare-ness”. In questo quadro, in futuro “saranno determinanti in futuro le pressioni della società, la diffusione di pratiche di co-progettazione e di modelli di governance collaborativa, nonché la capacità del decisore pubblico di agire da facilitatore e innovatore. Bisogna inoltre considerare come sfide persistenti la frammentazione territoriale e l’asimmetria tra Pubblico e privato, che richiedono soluzioni inclusive e sostenibili per affrontare le transizioni in corso e rafforzare il welfare in una prospettiva di coesione e secondo welfare” ha concluso la direttrice scientifica di Percorsi di Secondo Welfare.
