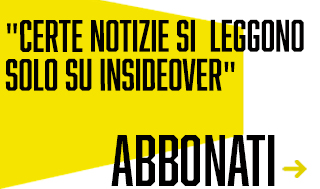L’ultima grande emergenza sanitaria avrebbe potuto rappresentare l’occasione per l’Europa di dimostrare al mondo la solidità del suo progetto politico e sociale. Si è rivelata, invece, la conferma di quanto il continente resti fragile e diviso quando si tratta di salute pubblica.
La corsa ai vaccini lo ha mostrato chiaramente: decisioni prese a Bruxelles, pensate per garantire equità e coesione, si sono spesso tradotte in ritardi burocratici, diffidenze reciproche e marcate disuguaglianze tra i Paesi membri.
La centralizzazione degli acquisti, scelta necessaria per evitare un “tutti contro tutti” tra gli Stati, si è rivelata un’arma a doppio taglio. Ha evitato la guerra dei prezzi, ma lo ha fatto al costo della trasparenza.
I contratti con le aziende farmaceutiche sono rimasti a lungo avvolti nel riserbo, con documenti resi pubblici solo in forma parziale e interi passaggi oscurati. Un modo di procedere che ha fatto crescere il sospetto dei cittadini e indebolito la fiducia nella stessa Unione europea.
Vuoi ricevere le nostre newsletter?
 I problemi burocratici dell’Europa
I problemi burocratici dell’Europa
I vaccini poi, una volta arrivati, non hanno trovato ovunque la stessa capacità di distribuzione. La Germania e la Danimarca hanno costruito campagne rapide ed efficienti, mentre la Bulgaria ha arrancato, incapace di garantire copertura e protezione. Stessa Europa, stesse dosi, risultati opposti: segno che la fragilità non è solo istituzionale, ma affonda le radici nelle disparità interne dei diversi sistemi sanitari.
Sul fronte regolatorio, l’Agenzia Europea del Farmaco ha fatto il possibile per accelerare i processi, ma la macchina è rimasta più lenta rispetto a quella americana.
A rallentare la risposta c’è stata anche la fragilità industriale: a differenza di Stati Uniti e Cina, l’Europa non dispone di agenzie dedicate e di finanziamenti capaci di orientare la ricerca come le americane “BARDA – Biomedical Advanced Research and Development Authority” e “DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency”. Quando le catene globali si sono inceppate, l’Europa ha scoperto di dipendere da impianti e materie prime che non controllava.
A peggiorare ulterioremente la situazione c’è stata la comunicazione, o meglio, la sua assenza. Alcuni esempi concreti? Le sospensioni improvvise del vaccino AstraZeneca, i messaggi contraddittori dei governi, le esitazioni mal spiegate hanno alimentato paure che già covavano sotto la superficie. Una parte consistente degli europei ha iniziato a dubitare della sicurezza e dell’utilità dei vaccini, e la disinformazione ha trovato terreno fertile.
 Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione EuropeaL’autogol di Bruxelles
Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione EuropeaL’autogol di Bruxelles
Anche sul piano internazionale l’Europa non ha saputo giocare la partita che contava. Se da un lato Bruxelles ha sostenuto il meccanismo COVAX, impegnandosi a distribuire gratuitamente miliardi di dosi, dall’altro ha scelto di non appoggiare la proposta di India e Sudafrica all’Organizzazione Mondiale del Commercio per sospendere temporaneamente i brevetti sui vaccini.
Una scelta, questa, che ha finito per rafforzare l’immagine di un’Unione allineata agli interessi delle grandi aziende farmaceutiche e poco disposta a usare gli strumenti di flessibilità previsti dall’accordo TRIPS, come la cosiddetta “licenza obbligatoria”.
È stata un’occasione mancata per esercitare il soft power europeo: rinunciare a quella sospensione ha significato presentarsi ai Paesi emergenti più come custode di un sistema monopolistico che come promotore di una vera solidarietà globale.
Era davvero l’unica strada possibile? Proteggere vite umane dovrebbe venire prima della difesa di un brevetto. Un mondo che sceglie la via della condivisione aperta delle conoscenze scientifiche — con reti di esperti in grado di monitorare le varianti emergenti e aggiornare periodicamente le formule dei vaccini rendendole accessibili a tutti — non è necessariamente un mondo meno innovativo. È, piuttosto, un mondo più preparato.
 Alla ricerca di una svolta
Alla ricerca di una svolta
Il risultato di questo insieme di fragilità è stato pesante: ritardi nelle vaccinazioni, vite perse, fiducia incrinata. La pandemia ha lasciato in eredità una lezione chiara: senza più trasparenza, senza investimenti industriali veri, senza una comunicazione coerente e senza una politica estera della salute, l’Europa rischia di trovarsi impreparata di fronte alla prossima emergenza.
Eppure, non tutto è perduto. Queste debolezze, se affrontate con coraggio, possono trasformarsi in punti di forza. Serve una svolta: un’Europa che sappia proteggere i propri cittadini con efficienza, parlare loro con chiarezza e, allo stesso tempo, presentarsi al mondo come attore credibile per la salute globale.
La vera domanda è se ci sarà la volontà politica di farlo. Perché la prossima crisi non ci concederà lo stesso margine d’errore.