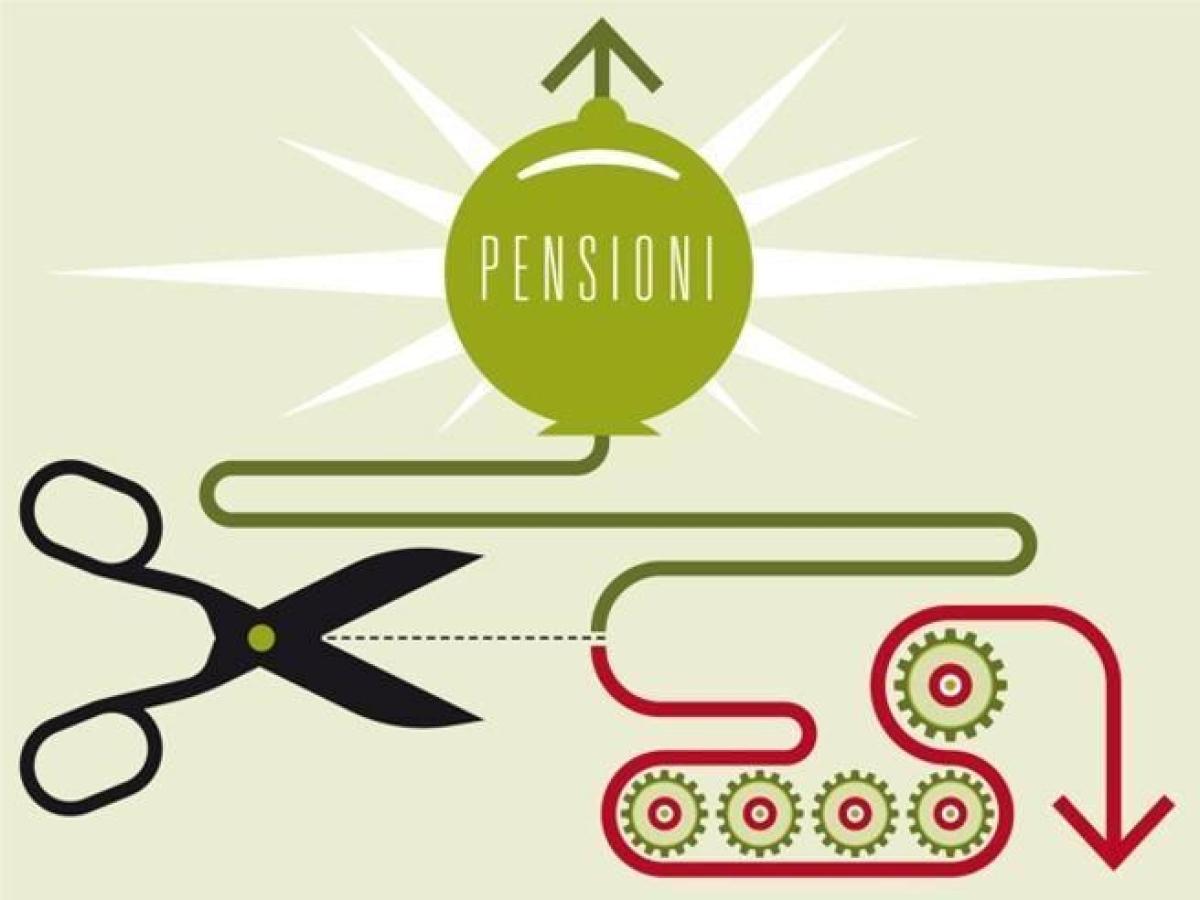di
Massimiliano Jattoni Dall’Asén
Dal 2027 l’età pensionabile verrà aumentata automaticamente come previsto dalla legge Fornero. Il governo valuta deroghe per lavori usuranti e un aumento graduale. Ma resta il nodo delle risorse
Dal 2027 l’età per andare in pensione salirà, come previsto dalla legge Fornero, a 67 anni e 3 mesi, in linea con l’aumento della speranza di vita certificato dall’Istat. Un adeguamento automatico di tre mesi che, secondo i calcoli della Ragioneria generale dello Stato, vale circa 3 miliardi di euro l’anno a regime e che il governo sta valutando di modulare, per non gravare su alcune categorie di lavoratori. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha parlato di una «sterilizzazione selettiva» dello scatto: insomma, l’aumento non sarà bloccato per tutti, ma attenuato per i lavori usuranti e i lavoratori precoci, ritenuti «più meritevoli di un trattamento diverso».
L’obiettivo dichiarato è evitare un rinvio generalizzato che metterebbe sotto pressione la sostenibilità del sistema, ma anche riconoscere «una differenza di merito» tra carriere più leggere e mestieri logoranti.
La misura sarà inserita nella prossima Legge di Bilancio, che dovrà chiarire tempi, costi e platee coinvolte. Il tema resta uno dei più delicati della manovra. Nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri la parola «pensioni» non compare nemmeno una volta. Eppure l’adeguamento dell’età pensionabile resta un passaggio obbligato: la legge Fornero, infatti, lega il requisito anagrafico alla speranza di vita, che nel 2024 ha toccato 21,6 anni per un sessantacinquenne, il valore più alto dal 2019. Per mantenere l’equilibrio, l’età della pensione dovrebbe così salire di tre mesi.
Le ipotesi sul tavolo
Le ipotesi allo studio del ministero dell’Economia e del Lavoro, secondo fonti di maggioranza, sono almeno tre.
* La prima prevede una deroga per chi ha già compiuto 64 anni al momento dell’entrata in vigore della norma: questa fascia sarebbe dunque esclusa dallo scatto dei tre mesi.
* La seconda ipotesi, più graduale, immagina un aumento distribuito nel tempo — un mese nel 2026, due nel 2027, tre nel 2028 — per ridurre l’impatto immediato sui conti pubblici e sui lavoratori.
* La terza strada, la più prudente dal punto di vista finanziario, è quella di limitare la sterilizzazione solo ad alcune categorie, mantenendo per la generalità dei lavoratori il meccanismo automatico.
I conti e il nodo della sostenibilità
Bloccare del tutto l’adeguamento costerebbe, secondo le stime del Tesoro, fino a tre miliardi di euro all’anno, una cifra difficilmente compatibile con i vincoli di finanza pubblica fissati da Bruxelles e con la necessità di mantenere il deficit sotto controllo.
La presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, ha ricordato che il meccanismo di adeguamento non serve solo a riequilibrare la spesa pensionistica, ma anche a garantire assegni più alti nel lungo periodo: «In un sistema contributivo», ha chiarito, «il trattamento dipende dai contributi versati. L’allungamento della vita lavorativa aiuta a migliorare i trattamenti e a rendere più solido il sistema». Rinunciare all’adeguamento significherebbe, al contrario, allungare il periodo medio di erogazione senza aumentare i versamenti, con il rischio di assegni più bassi e di squilibri futuri. Un tema che divide da anni la politica e che, a ogni scadenza, torna a pesare sulle manovre.
Le reazioni
Le opposizioni e i sindacati accusano il governo di ambiguità. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha parlato di un «paradosso»: «Sono andati al governo dicendo che avrebbero cancellato la Fornero, e invece stanno peggiorando le pensioni. Viene da dire: ridatecela». Dall’altra parte, la Lega insiste sulla necessità di «proteggere» i lavoratori più anziani: il vicepremier Matteo Salvini ha definito «inaccettabile» qualsiasi aumento dell’età pensionabile che non tenga conto della vita reale di chi lavora nei cantieri o nei turni notturni. La premier Giorgia Meloni, pur evitando di esporsi pubblicamente, ha chiesto ai ministri competenti di «valutare ogni possibile soluzione» che non comprometta i conti ma eviti un aumento lineare.
Il precedente e lo scenario futuro
L’ultimo adeguamento automatico risale al 1° gennaio 2019, quando era scattato l’incremento legato all’aspettativa di vita (+5 mesi). Il successivo adeguamento, previsto per il 2021, era stato sospeso a causa dell’impennata dei morti causati dal Covid e il conseguente stop della speranza di vita registrato in quel biennio. Ora che l’Istat ha registrato un nuovo aumento della longevità, il meccanismo previsto dalla legge 214 del 2011 si riattiva automaticamente. Bloccarlo, segnalano gli esperti, porta il rischio del cosiddetto «scalone»: rinviare oggi potrebbe portare a un incremento cumulato più consistente nel 2029, quando scatterà la revisione successiva legata alle aspettative di vita aggiornate. Per questo, al ministero dell’Economia si guarda anche a soluzioni intermedie, come un tetto massimo all’aumento per singolo biennio o un adeguamento flessibile legato ad altri indicatori macroeconomici, come crescita del Pil o tasso di occupazione.
Previdenza complementare e generazioni future
Come sappiamo, in parallelo, Giorgetti ha rilanciato l’idea di rafforzare la previdenza complementare per ridurre il «pension gap» e garantire un reddito più equilibrato a chi avrà carriere discontinue. «Un maggiore sviluppo dei fondi integrativi», ha detto il ministro, «risponde all’interesse dei singoli e aiuta a colmare le disuguaglianze tra le generazioni».
Secondo i dati più recenti della Covip, solo un terzo dei lavoratori italiani aderisce a forme di previdenza integrativa, una quota molto più bassa rispetto ad altri Paesi europei.
10 ottobre 2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA