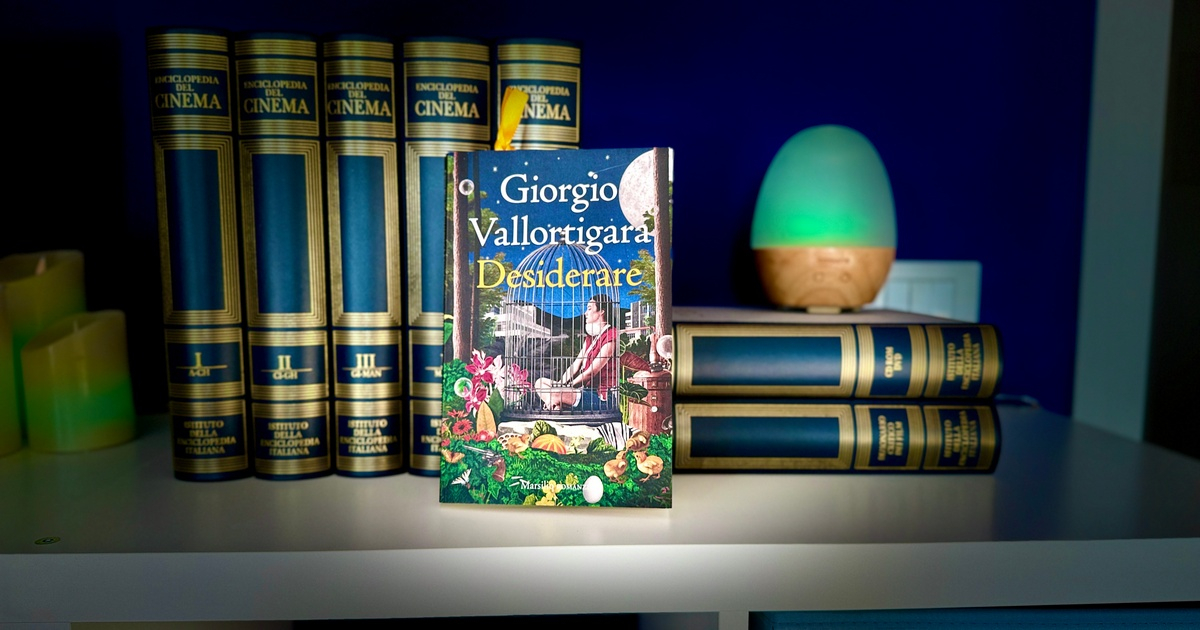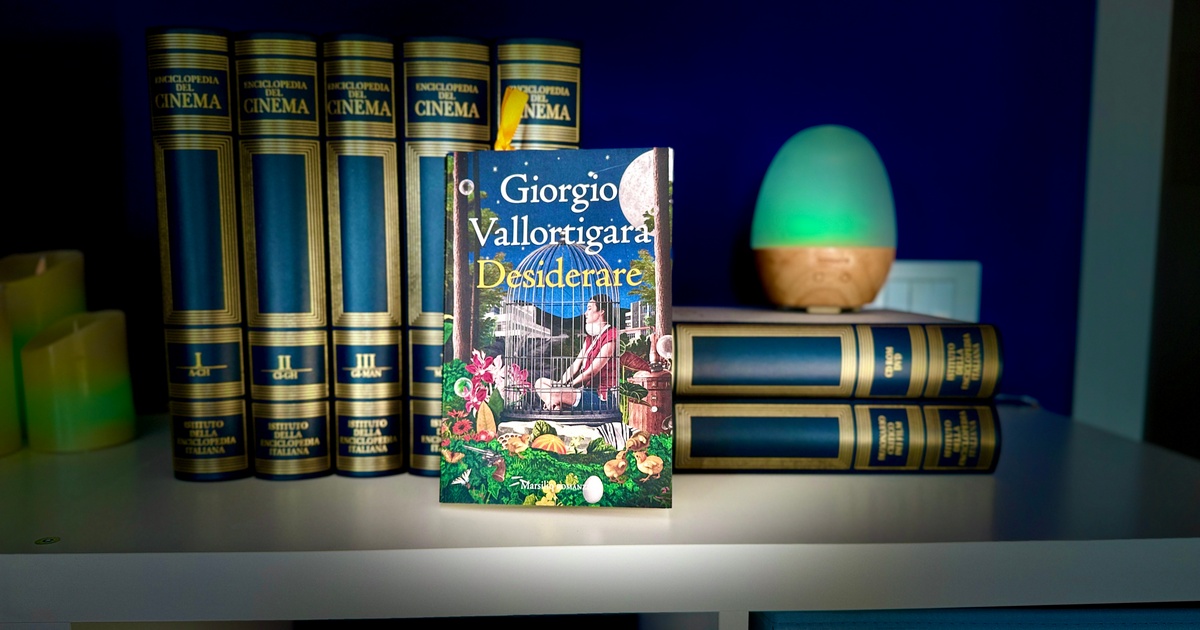
Ci sono momenti, leggendo Desiderare, il primo romanzo di Giorgio Vallortigara edito da Marsilio, in cui ci si sorprende a trattenere il respiro. Non succede nei classici colpi di scena da thriller, quando il cattivo ti sorprende alle spalle o parte la sparatoria, anche perché qui si smentisce Anton Čechov e il fucile (o meglio, la pistola) fa solo una timida apparizione per dare la scusa per illustrare il principio di permanenza dell’oggetto.
A tenere con il fiato sospeso è l’atmosfera generale, perché piano piano emerge che ogni personaggio, a modo suo, vive sull’orlo di un precipizio, e solo microscopiche contingenze fanno la differenza tra rimanere in equilibrio ed essere risucchiati dal buio.
È un romanzo “tutto nervi”, che vive di immagini e di momenti che possono cambiare tutto: una mano poggiata sulla spalla al momento giusto, un patio in ombra con una brocca di limonata, la funivia sospesa su Erice, il selciato del Liston padovano percorso solo sulle fasce chiare.
Chiariamolo subito: Vallortigara sa scrivere, lo si capisce dalla prima pagina: lo stile è accurato senza mai essere ridondante, il lessico è ricercato ma non pomposo, le descrizioni hanno una precisione quasi sensoriale, gli ambienti, che si tratti di un hotel sul mare, di un’aula universitaria o di un corridoio tra uffici, sono descritti con una tale attenzione che il lettore ha l’impressione di esserci davvero, fisicamente, mentalmente e persino olfattivamente. La scrittura, insomma, non si limita a “dire” le cose, ma le fa accadere davanti agli occhi.
Due binari principali e tante digressioni
Il libro procede seguendo due filoni: il primo è quello che potremmo chiamare “thriller cognitivo”: due morti, forse suicidi, forse no, conferenze scientifiche, spostamenti per l’Europa, una Contessa con il cranio trapanato, rivelazioni a strappi e la sensazione di non riuscire ad afferrare qualcosa, che sia una verità, un ricordo, un sentimento.
Il secondo filone è quello del metaromanzo: Itzhak, il protagonista, sta scrivendo la storia di Douglas Spalding, precettore del fratello di Bertrand Russel, scienziato ottocentesco alle prese con imprinting, pulcini e moralismi vittoriani.
I due binari non procedono in parallelo: ogni tanto si incrociano, altre volte sembrano divergere per chilometri, e al lettore tocca colmare lo scarto.
Ne vale la pena, proprio per le virtù letterarie che avevamo già intuito leggendo i saggi di Vallortigara, per lo stile terso senza essere sciatto, ricco senza compiacimento e capace di inanellare riferimenti senza perdere la tenuta della frase.
Entrambi i filoni, ma soprattutto il primo, sono intervallati da digressioni storico-scientifiche, a volte anche artistiche. Alcune sono funzionali alla trama, altre rimandano più al romanzo filosofico, un’opera narrativa che usa la storia, i personaggi e le situazioni come strumenti per esplorare idee.
Ambientazione e personaggi
In questo romanzo le descrizioni sono di una grandissima precisione visiva: la Cappella degli Scrovegni, ad esempio, diventa un prisma per guardare dentro il cervello, il teatro anatomico del Bo non è un feticcio universitario, ma il palcoscenico perfetto per una scena d’azione; la funivia di Erice è l’istante in cui la sospensione nello spazio racconta la sospensione della coscienza. Non ci sono paesaggi “di contorno”: tutto entra nell’anatomia della storia, e anzi le descrizioni si integrano molto meglio di alcune digressioni.
Anche i personaggi sono ben studiati, a loro modo tutti dotati di una certa ambiguità: Itzhak è l’osservatore che tiene insieme la scienza e l’emozione; Sylvia, una misteriosa laureata in matematica, è la figura catalizzatrice: intelligente, spiazzante, a tratti spietata; Patrick de Gray, profondamente carismatico nella sua freddezza, ha un talento luminoso che lo fa brillare ma, nel contempo, non aderire a nulla. Personaggi che restano nella memoria e che vorremmo conoscere di più, dietro a tutti i loro non detti che si rivelano, in parte, soltanto alla fine.
Memoria e desiderio: cosa ci rende ciò che siamo?
Il cuore teorico (ed emotivo) del libro riguarda l’essenza degli esseri umani e una delle domande più antiche del mondo: che cosa ci rende noi stessi? Vallortigara la affronta da scienziato, ma Itzhak la restituisce da narratore, attraverso le vite dei personaggi, ciascuno dei quali sembra costruito per mettere alla prova un’ipotesi diversa. Se pensiamo di essere il nostro corpo, come reagiremmo sapendo che le nostre cellule si rinnovano periodicamente? E se fossimo le nostre idee, cosa succederebbe se disgraziatamente dovessimo cambiarle? Forse siamo la somma dei nostri ricordi, ma allora cosa resta quando la memoria si sfilaccia? E se invece la nostra essenza fosse legata alla possibilità di desiderare, che cosa accadrebbe se il desiderio si spegnesse, o se venisse manipolato?
“
Abitare il presente, senza mai convocare al tribunale della coscienza neanche una singola reminiscenza, con le sue marcature di cosa, dove e quando, pena la cancellazione definitiva, è un supplizio impossibile da infliggersi
Giorgio Vallortigara
Il romanzo non dà risposte definitive, ma mette in crisi il confine tra identità e continuità, tra ciò che proviamo e ciò che ricordiamo di aver provato. I personaggi oscillano tra la nostalgia di un io perduto e la tentazione di diventare altro o forse niente. Patrick, in particolare, sembra disposto a tutto per poter riaprire la finestra di plasticità del cervello adulto, cioè quella fase, tipica degli infanti, in cui le connessioni neurali sono estremamente flessibili e l’apprendimento è quasi illimitato, ma a che prezzo? Non facciamo spoiler.
E se non può esserci identità senza memoria, manca ancora qualcosa: un vettore che la orienti, un movimento, una spinta, il desiderare, per l’appunto. La memoria ci tiene insieme, il desiderio ci muove in avanti e poi sarà la memoria a cucire i minuti in biografie, a dare peso a un odore, a un gesto, a una frase ascoltata dieci anni prima e rimasta lì, come un seme. Il rapporto è bidirezionale: senza memoria il desiderio si schiaccia sull’istante e si spegne; senza desiderio la memoria diventa vuoto inventario. È un equilibrio delicatissimo, e il romanzo mostra cosa accade quando qualcuno decide di spostare l’ago.
Perché non un semplice romanzo?
Capita spesso che validissimi scienziati decidano di cimentarsi nella scrittura di romanzi senza averne i mezzi stilistici. Sotto sotto lo sanno benissimo, e per distrarre il lettore infarciscono il testo di excursus che potrebbero vivere agevolmente in saggi autonomi, anche due o tre, che sono quelli che hanno imparato a scrivere bene. Come si diceva, questo non è il caso di Vallortigara, il cui stile suggerisce una solida frequentazione di letteratura di livello, e una rielaborazione che rende il tutto anche originale.
Nel romanzo viene menzionata una scrittrice che si lamenta dell’invasione di campo di chi scrittore non è, e invece forse, dovendo fare una critica a questo libro, c’è da chiedersi perché quest’invasione di campo non sia stata più netta, perché l’autore non abbia per una volta abbandonato, almeno parzialmente, i panni dello scienziato per indossare quelli del romanziere, visto che ha ampiamente dimostrato di averne le capacità.
A volte le digressioni di cui abbiamo parlato sovrastano la scena: capita più di una volta che la linea del thriller cognitivo venga sospesa a favore di parentesi che inserite in un saggio sarebbero stimolanti, ma che qui invece vanno a interrompere il flusso di un romanzo che, già così, richiederebbe tutta l’attenzione dei lettori. Proprio quando la tensione cresce, quando ci si avvicina a capire chi sia davvero Patrick, o cosa Sylvia stia cercando di ottenere, o che cosa è successo a Vittorio, ecco che il testo devia, e non per andare da un’altra parte del romanzo, ma per alzarsi in volo verso un altro piano: quello delle considerazioni filosofiche, degli excursus sulla storia delle neuroscienze, dei riferimenti colti. Il che non è di per sé un male, ma qui il problema non è la profondità del pensiero, è l’effetto che produce sul lettore immerso nella narrazione: è come essere trasportati via da una stanza in cui stava succedendo qualcosa di cruciale, per essere portati in un’aula a seguire una lezione.
Le lezioni di Vallortigara sono illuminanti, chi ha letto i suoi saggi lo sa bene. Eppure alcuni lettori di romanzi potrebbero sentirsi sovraccaricati da queste digressioni sovrapposte alla trama principale e potrebbero chiedersi perché far perdere il filo quando quel filo terrebbe perfettamente già da solo? È probabile che Vallortigara non lo faccia né per modestia né per inciampo tecnico, ma per un progetto che prevede che la scienza pesi sul corpo della trama, lasciando ai lettori il compito di riannodare i fili.
Desiderare su un’isola deserta
Questo è un compito che chiede molto al lettore in termini di attenzione, ma offre anche qualcosa in cambio. Prima di leggere questo libro, insomma, dobbiamo valutare onestamente quante energie mentali siamo disposti a dedicargli per cogliere i riferimenti nelle digressioni solo apparentemente fuori tema, per scovare il gioco matematico dietro alla progressione dei capitoli, per fare un’esegesi degli intenti dei personaggi per capirli fino in fondo.
Desiderare è un libro che va letto attentamente per poterlo apprezzare come merita, un romanzo forse non troppo adatto ai ritmi frenetici di oggi. Però ci dà l’occasione per trovare finalmente una risposta all’insidiosa domanda che capita di sentirsi rivolgere durante un aperitivo: quale libro porteresti su un’isola deserta?
Questo è il candidato perfetto: a differenza dei classici pageturner questo libro rende meglio sul lungo termine e probabilmente ogni volta che lo si rilegge lo si comprende un po’ di più, trovandoci sempre qualcosa di nuovo.