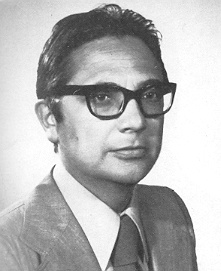«Peccato è mancanza di compimento, secondo la definizione di un grande teologo, Karl Barth. C’è una linea invalicabile (chiamiamola pure peccato originale) che separa ogni esistenza umana dalla pienezza, cui pure noi umani non cessiamo di tendere mossi dal desiderio». Così Salvatore Mannuzzu in un’intervista del 2004 subito dopo la pubblicazione di uno dei suoi libri più intensi, Le fate dell’inverno. Per Mannuzzu la vita è irredimibile, sempre impari rispetto all’altezza irraggiungibile del desiderio. In ciò stanno, insieme, la tragedia e la grazia; perciò il sentimento più consono, quando alla vita si presta cura, è la pietà.
MANNUZZU sta tutto dentro questi confini anche in Apnea, il libro curato da Alessandro Cadoni con una prefazione di Sante Maurizi che raccoglie alcuni scritti sul cinema dello scrittore sassarese (Angelica Editore, pp. 113, euro 12,00).
Per Mannuzzu, nato nel 1930, il cinema è stato l’epopea degli anni d’oro di Hollywood e la grande stagione delle prove d’autore soprattutto europee. Una stagione perduta. «Il cinema – scrive – era quello schermo grande e sporco sotto il quale io sedevo sulla scomoda poltroncina di legno», immerso in apnea «in un buio unico al mondo» ad assumere una «giusta porzione di solitudine dal sapore amaro e insieme non solo amaro (a suo modo, forse, dolce)». L’amore di Mannuzzu per quell’apnea dolce-amara comincia negli anni Cinquanta, nella stagione del cinema come strumento di lettura della realtà italiana dopo la guerra; nel tempo della settima arte come impegno politico.
DI QUEGLI ANNI Apnea raccoglie due testi di Mannuzzu, pubblicati rispettivamente nel 1961 e nel 1962 su «Cinema nuovo» di Guido Aristarco. Siamo nei territori del neorealismo e dell’ortodossia togliattiana. Nel primo testo Mannuzzu recensisce Banditi ad Orgosolo di Vittorio De Seta. E ne mette in evidenza l’analisi puntuale della realtà socio-economica e antropologica della Barbagia, che sola può spiegare compiutamente il banditismo sardo; nel secondo stronca Divorzio all’italiana di Pietro Germi, sostenendo la tesi secondo cui dietro la parodia della realtà sessista e maschilista della Sicilia, che fa da sfondo al film, c’è in realtà, furbescamente sottesa, una piena giustificazione di quel mondo. «Un pezzo questo – scrive Mannuzzu – di cui Goffredo Fofi mi disse che mi sarei dovuto vergognare». Forte, in entrambi i testi, il segno di un’epoca.
BEN ALTRO LO SGUARDO sul cinema dell’autore di Procedura negli altri scritti raccolti in Apnea. In due in particolare. Il primo è quello su Monsieur Verdoux di Charlie Chaplin, pubblicato nel 2009 in Cenere e giaccio per le Edizioni dell’asino, la casa editrice collegata alla rivista «Gli Asini» diretta proprio da Fofi.
Qui emerge lo scrittore degli anni della maturità. «Al termine del film – scrive Mannuzzu – Chaplin ci lascia con un dubbio: se l’orrore del mondo dipenda da una fase della Storia o se ci sia un grano di veleno che sta più dentro, più in fondo, una irredimibilità cui pure spetta la sua grazia, al di là della storia degli uomini». Il secondo è quello, sempre del 2009, su Les enfants du paradis di Marcel Carné. «Film con il quale – scrive Mannuzzu – faccio i conti da sempre».
Per aggiungere, subito dopo, che nella pellicola del regista francese il labirinto senza uscita che è l’esistenza di ogni essere umano (Les enfants du paradis è una storia di amori impossibili) viene percorso a tentoni in un gioco di specchi, che trova il suo fondamento più vero nella passione che Carné mostra come sua guida essenziale: quella per la rappresentazione.
Solo attraverso i modi inevitabilmente reticenti della rappresentazione, della scena, finta come ogni scena, l’irredimibilità della vita risulta in qualche modo, sempre a fatica, attingibile. Succede nel cinema; succede nella scrittura.
CON LA CHIOSA FINALE tutta mannuzziana: «Credo che rimanere al desiderio, pur essendogli sempre impari, rimanere all’altezza irraggiungibile del desiderio – del desiderio inappagato, mai pacificato – sia la vocazione più vera della vita e insieme della letteratura: la vocazione che forse le rende uguali; facendoci sperare che qualcosa si salvi dalla distruzione».