“Se non li leggete, anzi se non leggete proprio nessun libro (specialmente quelli pubblicati negli ultimi cento anni) la vostra mente vi sarà grata”. Giordano Tedoldi, autore di “Phallus Dei” (ne abbiamo scritto qui), introduce così sette suoi suggerimenti di lettura. Una selezione, fra serio e faceto, che si aggiunge a una ormai lunga lista di consigli di scrittori, traduttori e altri protagonisti dell’editoria (qui la lista completa)
La passione si è molto raffreddata, così quando gli amici di LuciaLibri mi hanno chiesto di partecipare alla loro serie dei “sette libri” ho pensato prima di declinare con una scusa, poi ho accettato ma sapendo che avrei dovuto attendere un bel po’ prima che mi venisse la voglia. In effetti sono passate settimane, forse mesi (o anni, è tutto molto vago) e sono in quel momento beato in cui “il committente” se Dio vuole neanche si ricorda più la commissione e la voglia non mi è tornata e come sempre detesto consigliare libri (o qualunque cosa, a meno che non sia a un nemico) ma che posso farci? Bisogna pure ogni tanto mandare segni di vita. Così ecco sette libri che, perlomeno, ho letto. Potrei avere letto anche solo questi e credo che sarei stato benissimo. Il nichilismo letterario (biblionichilismo? Questo è un club a cui apparterrei senza temere gli effetti della battuta attribuita a Groucho Marx) è un po’ una posa, ma qualcosa di autentico ce l’avrà, e comunque, c’è qualcosa di più sgradevole che quando ti scrivono: “e per favore, mandaci una bio e una tua foto”. Perché non: “e per favore, mandaci il tuo necrologio”. Basta così, il malumore ha avuto il suo sfogo, ora ci sono i magnifici sette. Con l’avvertenza che se non li leggete, anzi se non leggete proprio nessun libro (specialmente quelli pubblicati negli ultimi cento anni) la vostra mente vi sarà grata.
“La piccola Dorrit” di Charles Dickens (Einaudi), traduzione di Vittoria Rossi Ancona
Uno. Charles Dickens, La piccola Dorrit. Fa molto ridere. È scritto con uno stile pretestuoso e infinito che ricorda certe pagine wagneriane quando si ha completamente persa la voglia di seguire la storia, ma si resta incantati dai viluppi musicali e dall’amplificatore che va in saturazione. Londra delle truffe, degli arresti per debiti, delle macilente figliole dal cuore d’oro mette nostalgia, nonostante tutta la fuliggine. Per non parlare delle pagine veneziane, pura cartapesta. La Terra desolata di T.S. Eliot se fosse espansa fino a diventare un romanzo dalla mole formidabile sarebbe un po’ La piccola Dorrit. Questi sono gli accostamenti demenziali che solo la letteratura concede, e che nonostante la loro evidente smentibilità, mi sento di infliggere al lettore di queste righe. Nota pettegola: era il romanzo preferito di August Strindberg, che poi alla stessa domanda in altri questionari avrebbe risposto con titoli differenti. Anche lui grande amante di queste indagini, e degli altri in generale.
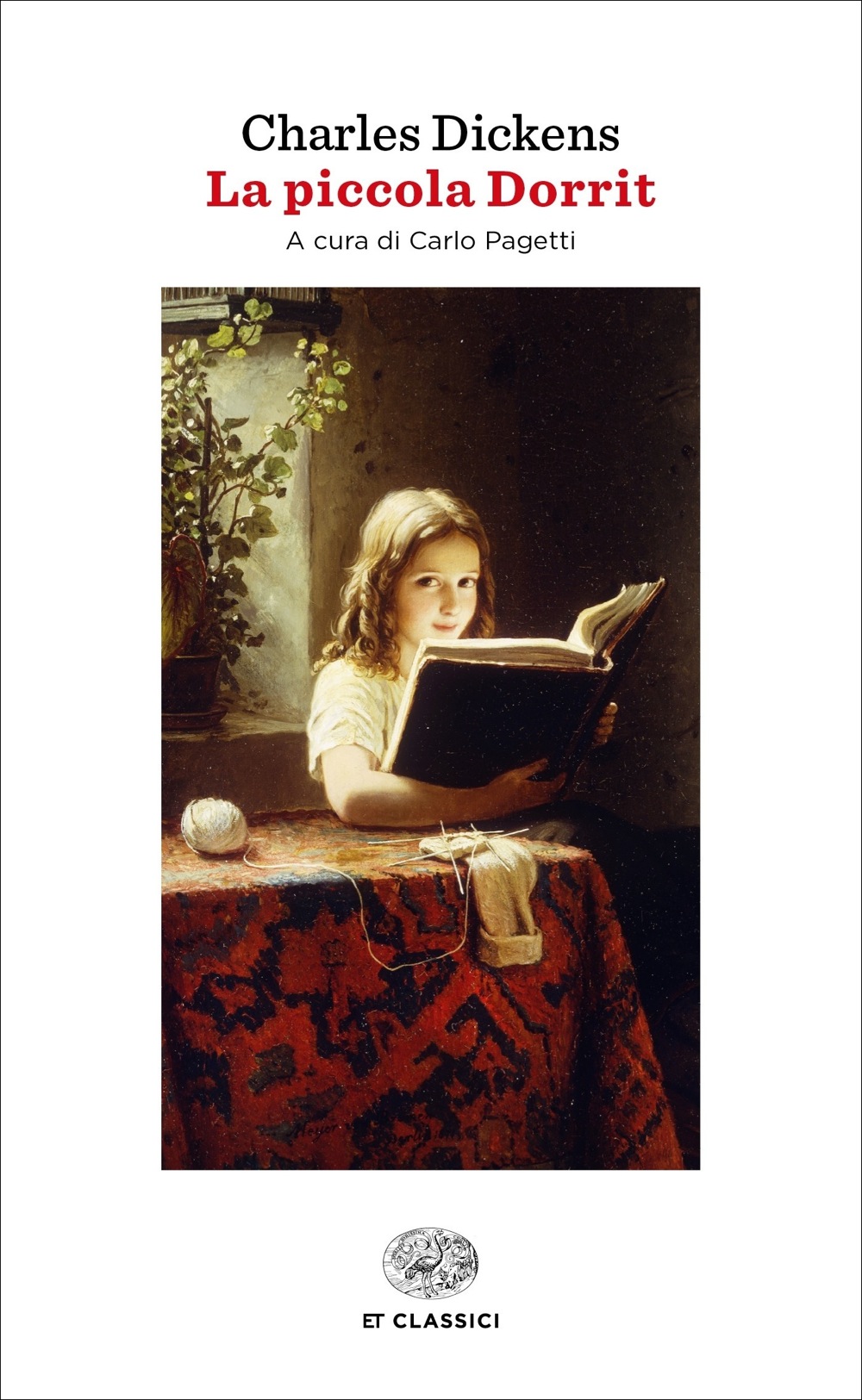
“Il castello” di Franz Kafka (Garzanti), traduzione di Clara Morena
Due. Oddio deve proprio esserci un due? D’accordo. Il castello di Franz Kafka, ammesso che quello sia il titolo. Non ci si capisce niente. Anni fa un amico mi disse: “Si fa una fatica a leggerlo, ma stranamente è quello il bello”. Questo per dire a che punto siamo arrivati. Però anche solo l’idea di scrivere un romanzo, insomma, qualcosa che finga di essere un romanzo con protagonista un “agrimensore”, un certo valore deve avercelo. Il simbolismo del castello è stato talmente sviscerato che non è nemmeno più un castello. Quindi si fa fatica, mentre si legge, a visualizzare il castello. Ma questo non è che uno dei tanti giochi di prestigio di Kafka. Leggetelo e poi sfinite i vostri cari con la vostra interpretazione.

“La Repubblica” di Platone (Bur), traduzione di Mario Vegetti
Tre. Ci siamo quasi. L’ecclesiaste. No scherzavo, ci siete cascati. Guido Ceronetti un’altra volta. La Repubblica di Platone. Seriamente. Vabbè un libro di filosofia ce lo devo mettere, perché è stato un discreto passatempo (e anche un tormento) che ha dissipato irragionevoli risorse della mia esistenza. Se volete, potete leggere anche solo il primo libro, con la magnifica digressione introduttiva sulla vecchiaia, è già interessante, poi tutto il resto ad libitum. Nota ego trip: qualche passaggio del mio primo romanzo deve qualcosa (o molto) alle descrizioni di sogni o miti o visioni che si trovano, nonostante la risaputa condanna platonica del mito, nella Repubblica.
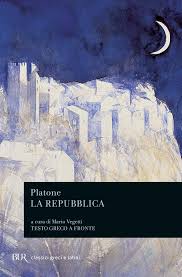
“Estensione del dominio della lotta” di Michel Houellebecq (La Nave di Teseo), traduzione di Sergio Claudio Perroni
Quattro. Oltre la metà, forza. Moby Dick. No, non l’ho letto. Un attimo. Joyce no. Musil? Amato moltissimo, ma ora un po’ distante. Non mi viene niente. Walser anche lui amato moltissimo ma troppo “piccola biblioteca Adelphi” (benemerita, ma come detto, la passione si è raffreddata). Andiamo sulla genia dei bipedi letterati viventi. Ce ne sarà uno da salvare? Mi gioco la carta Le benevole? Basta, ne ho parlato fin troppo nella mia vita, e i libri successivi sono imbarazzanti, forse deliberatamente. Ah be’ l’area francofona mi offre uno spiraglio con un personaggio un po’ stazzonato ma ancora efficace. Michel Houellebecq, Estensione del dominio della lotta. La definizione viene facile: capolavoro della letteratura contemporanea. Sì, il quattro è lui. Quando ti accorgi che quel coglione di Tisserand non è il deuteragonista ma in realtà sei tu è troppo tardi.
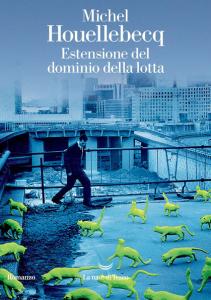
“Liriche e frammenti” di Saffo (Feltrinelli), traduzione di Salvatore Quasimodo
Cinque. Una donna, ci vuole una donna. Ci sarebbero volute duecento scrittrici, e io sono qui che mi copro di vergogna non avendone nominata nemmeno una. Alice Munro, non ci sono mai cascato. Jeanette Winterson, sono i fotoromanzi, ma peggio. I saggi di Zadie Smith vanno benissimo dal dentista, dico sul serio, non sono poi così male. La truppa delle nuove finto pensose tipo Sally Rooney ecc non la avvicino neanche con un lungo bastone. Il cardellino non l’ho letto. Siamo nei guai. Le poetesse della bianca Einaudi, lasciamo proprio perdere. Ragazzi, ho un problema, e non sembra che si risolverà tanto presto. Va bene mi piace Saffo. Le liriche di Saffo. Preferibilmente non tradotta da Quasimodo, ma magari una versione più letterale… Ci si dovrebbe mettere la mia amica Susanna Mati. Siccome in questa rubrica ho visto menzionare libri assurdi, il mio quinto libro sono “Le liriche” (boh) di Saffo. Un attimo, perché questo sarebbe un libro assurdo? Non lo so, l’idea che ho di Saffo nonostante tutte le modernizzazioni, le attualizzazioni e le incarnazioni è che “un libro” a lei attribuito sia una piccola scorrettezza così come l’ondata di pessime traduzioni di Emily Dickinson, tutte di un grigiore burocratico, di una serietà da convegno sulla poesia che il canto originale non aveva minimamente.
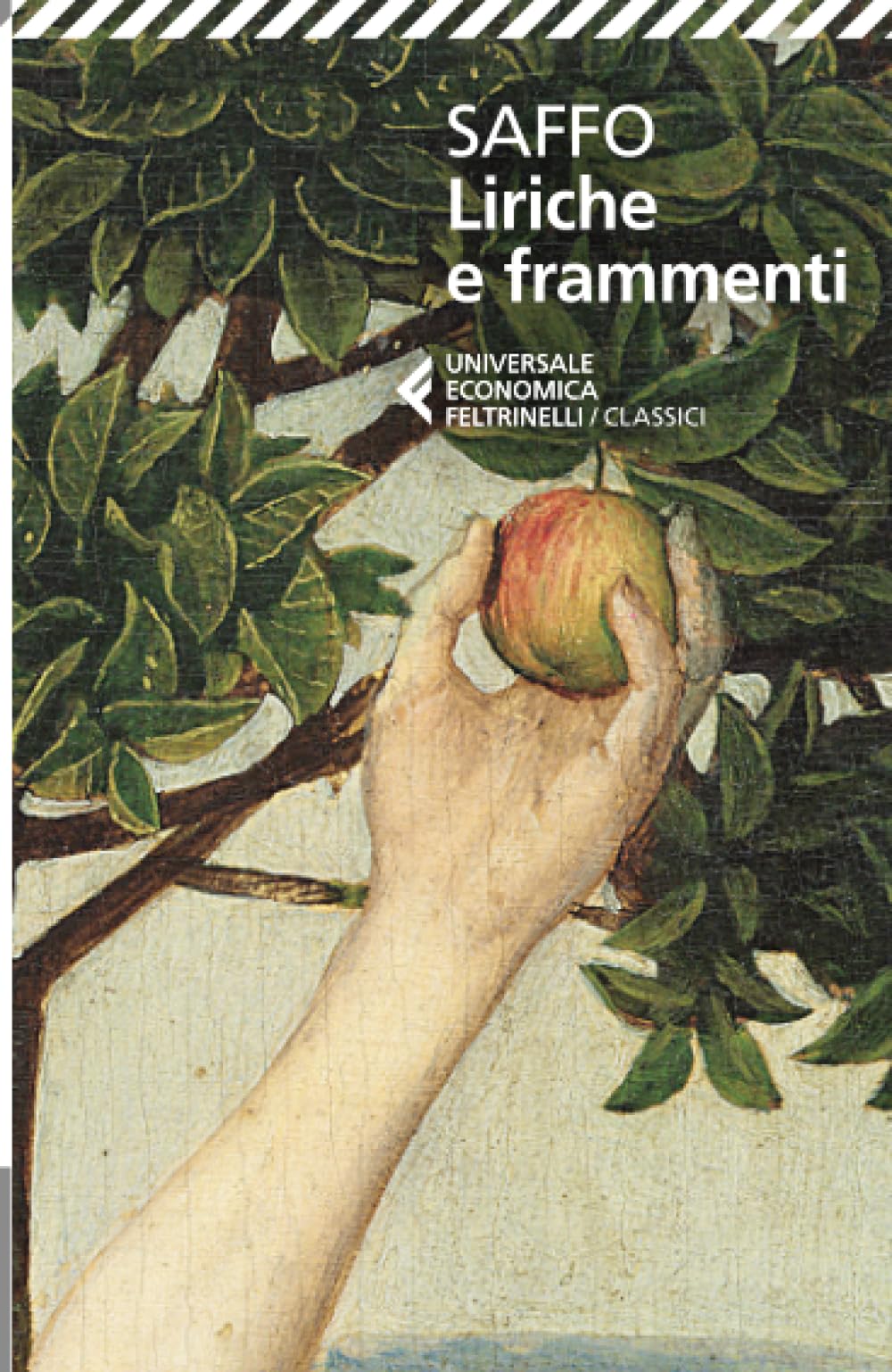
“Donne” di Charles Bukowski (Tea), traduzione di Simona Viciani
Sei. Charles Bukowski, Donne. Nessun dubbio, trattasi di scureggione, ma almeno non era un ipocrita.
No?
Vabbè fate come volete, c’è stato un tempo in cui lo leggevano tutti. È andata così. RIP.
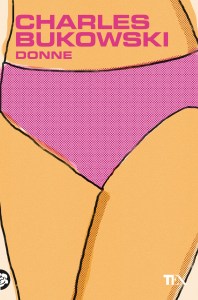
“I racconti” di Edgar Allan Poe (Garzanti) e “I Racconti” di Franz Kafka (Bur)
Sette. Ma ovviamente Lectures on Quantum Mechanics di Steven Weinberg. Va bene era l’ultimo scherzo. Il mio settimo e ultimo libro sono due libri: i racconti di Edgar Allan Poe e i racconti di Kafka, e tutto il resto è letteratura. En passant, mi fanno molto ridere quelli che, assumendo un tono mistico, affermano che “il racconto in fondo è il genere più alto della letteratura”. Poi si mettono a fare paragoni, che so, con la musica da camera, con l’orologeria svizzera, oppure corrugando la fronte e cercando le ragazze nel pubblico si accaldano nell’illustrare quanto sia difficile concentrare un’immagine, un’emozione, un colpo di teatro, senza sbavature, senza eccessi, nelle poche pagine di un racconto. E poi. Ecco, io la penso allo stesso modo (gigionismi inclusi).
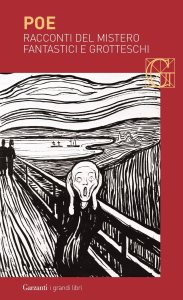
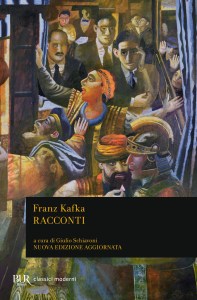
Seguici su Instagram, Telegram, WhatsApp, Threads, YouTube Facebook e X. Grazie
Correlati
