Nel 2025 il Premio Nobel per la Medicina è stato conferito a Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica, ovvero i meccanismi che impediscono al nostro sistema immunitario di reagire in modo eccessivo contro i tessuti sani del corpo. Ma di che cosa si tratta esattamente e perché rappresenta una questione cruciale per la salute?
La tolleranza immunitaria è un tema sempre più centrale nella ricerca biomedica, perché riguarda la capacità del sistema di distinguere tra ciò che deve attaccare e ciò che deve invece proteggere. La premiazione del Nobel per la Medicina 2025 rappresenta un riconoscimento sull’importanza di studiare non solo come il sistema immunitario combatta gli agenti esterni, ma anche come mantenga il controllo in grado di preservare l’equilibrio dell’organismo.
Approfondisci:
Cosa mangiare per la salute del microbiota: la dieta della longevità
Che cos’è la tolleranza immunitaria
La tolleranza immunitaria indica lo stato in cui il sistema immunitario non reagisce contro antigeni propri o innocui, pur restando in grado di difendere l’organismo da virus, batteri e altri agenti patogeni. In altre parole, è ciò che permette al corpo di evitare di aggredire se stesso.
Durante lo sviluppo dei linfociti, nei principali organi linfoidi come timo e midollo osseo, il sistema elimina o inattiva le cellule che riconoscono in modo anomalo le proprie strutture. Questo processo prende il nome di tolleranza centrale. Una volta che i linfociti maturano ed entrano in circolo, subentra un secondo livello di controllo, la cosiddetta tolleranza periferica, che agisce attraverso meccanismi complessi di “autocontrollo”: alcuni linfociti vengono disattivati, altri eliminati, altri ancora regolati da cellule specializzate.
Negli ultimi anni l’attenzione dei ricercatori si è concentrata proprio su questi meccanismi periferici, perché è in questa fase che possono verificarsi errori capaci di generare malattie autoimmuni, allergie o fenomeni di rigetto nei trapianti.
Approfondisci:
La nuova frontiera contro i tumori? Potenziare le difese immunitarie prima di operare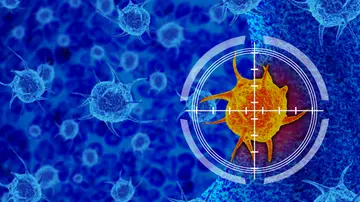
Il legame con il Nobel 2025: i “guardiani” del sistema
Il Nobel 2025 è stato assegnato per aver identificato e descritto il ruolo delle cellule T regolatorie, note come Tregs, che agiscono come veri e propri “freni” del sistema immunitario. Shimon Sakaguchi, già nei primi anni Novanta, individuò una popolazione di linfociti T capaci di prevenire le reazioni autoimmuni, scoprendo che senza di loro il sistema immunitario tendeva a perdere il controllo.
Successivamente, Mary Brunkow e Fred Ramsdell hanno individuato il gene FOXP3, indispensabile per lo sviluppo e la funzione di queste cellule regolatorie. Mutazioni di questo gene sono associate a gravi sindromi autoimmuni sia negli animali sia nell’uomo. Queste scoperte hanno chiarito che il corretto equilibrio fra attivazione e inibizione è essenziale quanto la capacità di difesa: un sistema immunitario efficace non è solo quello che reagisce, ma anche quello che sa fermarsi al momento giusto.
Approfondisci:
Perché bere poca acqua aumenta il rischio di malattie: “Ecco i segnali della disidratazione”
Meccanismi molecolari e cellulari della tolleranza
I meccanismi della tolleranza immunitaria si fondano su una rete coordinata di cellule e segnali. Le cellule T regolatorie ne sono il cardine: attraverso la produzione di molecole come interleuchina-10 e TGF-β, modulano l’attività di altre cellule immunitarie, limitando le reazioni infiammatorie. Inoltre, consumano fattori trofici fondamentali per l’attivazione linfocitaria, impedendo un’eccessiva proliferazione di cellule reattive.
Il gene FOXP3 rappresenta il regolatore principale di questa funzione. Senza la sua attività, le cellule T regolatorie perdono la loro identità e non riescono più a mantenere l’equilibrio del sistema. Anche le cellule dendritiche e le cellule B possono contribuire alla tolleranza diventando “tollerogene”, cioè in grado di indurre una risposta controllata invece che una reazione aggressiva.
A questa rete di controllo partecipano inoltre segnali co-inibitori come CTLA-4 e PD-1, che agiscono come interruttori molecolari per evitare risposte eccessive. Tutto questo avviene in un sistema dinamico, che si adatta costantemente alle condizioni dell’organismo. Infezioni, infiammazioni o alterazioni genetiche possono rompere l’equilibrio e scatenare una risposta immunitaria incontrollata.
Approfondisci:
Difese immunitarie e artrite grave: scoperte alterazioni silenti
Perché la tolleranza immunitaria è cruciale per la salute
Una tolleranza immunitaria efficiente è ciò che permette al sistema di difendere l’organismo senza danneggiarlo. Quando questi meccanismi si alterano, possono comparire malattie autoimmuni come artrite reumatoide, sclerosi multipla, diabete di tipo 1 o lupus. Al contrario, se la tolleranza è eccessiva, al contrario, il sistema può abbassare le difese, favorendo la sopravvivenza di cellule tumorali o interferendo con la risposta alle infezioni.
Nel campo dei trapianti, la tolleranza rappresenta l’obiettivo più ambizioso: riuscire a far accettare un organo donato senza dover ricorrere a una soppressione farmacologica continua del sistema immunitario. Anche le malattie infiammatorie croniche, come le allergie o le patologie intestinali, sono oggi rilette alla luce di alterazioni nei meccanismi di tolleranza.
Le frontiere della ricerca e le sfide future
La ricerca contemporanea sulla tolleranza immunitaria è in piena espansione. Gli scienziati stanno sviluppando terapie cellulari basate su cellule T regolatorie, con l’obiettivo di ripristinare l’equilibrio immunitario nei pazienti con malattie autoimmuni o sottoposti a trapianto. Si studiano inoltre vaccini “tollerogeni”, in grado di educare il sistema immunitario a riconoscere come innocui determinati antigeni, come quelli coinvolti nelle allergie.
Tecniche di imaging molecolare permettono oggi di osservare in tempo reale l’evoluzione della tolleranza nei tessuti, offrendo nuove prospettive per comprendere e misurare i processi regolatori. Tuttavia, restano aperte molte sfide: ottenere una tolleranza stabile a lungo termine, evitare che la regolazione eccessiva riduca le difese contro tumori o infezioni, e soprattutto personalizzare gli approcci terapeutici in base alle caratteristiche genetiche e immunologiche di ciascun individuo.
La tolleranza immunitaria, un tempo considerata un semplice “freno” al sistema, oggi è riconosciuta come una componente attiva e intelligente della difesa dell’organismo: un equilibrio sofisticato che rende possibile la salute stessa e su cui c’è ancora molto da comprendere.
