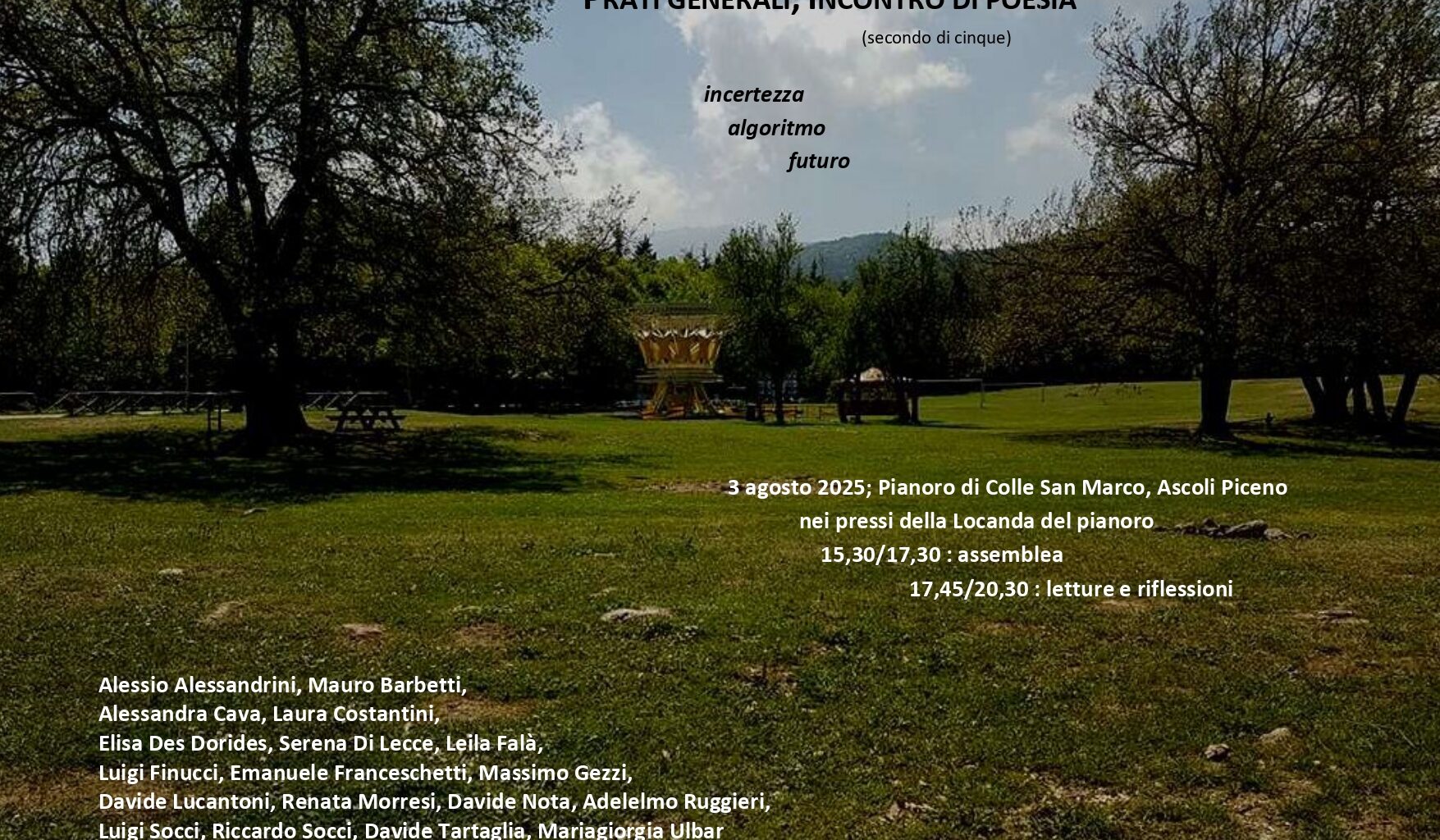Da qualche giorno assistiamo a una bolla di commenti, da parte di chi scrive romanzi, su quanto sia frustrante e inutile e pure dispendioso andarsene in giro per l’Italia a presentare i propri libri a un pubblichetto di una manciata di persone a dir tanto. Noi che facciamo poesia ci siamo fatti due risate, memori delle decine di passaggi su gomma e rotaia rubati al sonno per arrivare in piazzetta a Roccacannuccia a ‘presentare’ ‘la’ ‘poesia’ a tre signore fermatesi a mangiare il gelato. Va così, i libri si stampano, magari si scrive bruciando, le poesie avvampano. Ma il peso specifico di quest’arte è diventato quello della neve. Non ci importa granché della querimonia annosa circa l’irrilevanza del genere o dei suoi praticanti. Anzi, spesso abbiamo pensato che va proprio bene così: non essere cooptati da nessuna forza. Guadagnare un’altra tacca alla nostra (a volte imperscrutabile) esperienza. Senonché, questa desertificazione fa il gioco dell’ideologia della GPU (Grande Poesia Universale), tutta ornamento e salvezza, grandi ego ipertrofici e vacue sfide nell’acquario. Mentre si fa strame di forme di vita, scuola, quartiere, studio, incontro, complessità, pensiero critico, progetti, esperienze divergenti o sotterranee, sensibilità sommesse, memorie di luoghi, corpi imprevisti, voci nuove, dissenso, legami tra culture, amicizie, stranezze senza marketing e altre cose da poter immaginare, del passato, nel futuro, mica solo questo. Quanto ancora potremmo allungare questa lista?
“Cosa possiamo fare?
Come vogliamo farlo?
Chi dovrebbe ascoltarci?
Che dobbiamo aspettarci?”
Sono le domande che ci eravamo posti ai prati generali dello scorso anno, il 15 settembre 2024 a Fermo. Non c’era/c’è un che di irrimediabilmente fuori dal tempo in queste domande? Domande altissime in un reale così greve che sembrano quasi domande improprie. Il bello era farcele – una ventina di poeti ‘vicini di casa’ – consapevoli di essere al di là di ogni istituzione, centro, potere. In un parco di provincia, senza patrocini, finanziamenti, pubblicità. Neanche un volantino. Scambiandoci idee, dunque, stando in ascolto, provando a leggere e dialogare in modo multiforme. Non si può dire che ci somigliamo, né per formazione, né per età, occupazione, posizioni ma neanche scritture. E allora? Qualcosa da dire e fare ci è rimasta, a ogni modo. Siamo in procinto di riaprire il prato.
Adelelmo Ruggieri, Alessio Alessandrini, Mariagiorgia Ulbar, Renata Morresi
L’invito è dunque a:
Prati generali, Incontro di poesia
(secondo di cinque)
Pianoro di Colle San Marco, Ascoli Piceno
3 Agosto 2025, dalle 15,30 in poi

(Una lettera di Lorenzo Mari, che l’anno scorso ha aperto i lavori)
CIP E CIOP
Una lettera
Car* amic*,
e già questo inizio potrà fare storcere il naso a qualcuno, ma va bene così…
Scrivo a voi e insieme scrivo a me stesso – e, proprio per questo motivo, rivendico intanto di poter prendere una forma, per quanto provvisoria – una lettera che cerca di cogliere il senso del laboratorio iniziato sui Prati Generali di Fermo, nel tentativo di mantenerne vivo un potenziale trasformativo – per tutt*, a partire in primo luogo da me stesso: ne avevo bisogno, e voi avete risposto a questo mio bisogno; ne ho ancora bisogno… – che rimanga sempre aperto verso esiti imprevisti.
Gli interrogativi posti – Cosa possiamo fare? Come vogliamo farlo? Chi dovrebbe ascoltarci? Che dobbiamo aspettarci? – mi portano, innanzitutto, a interessarmi di nuovo al noi che viene postulato in ciascuna e in tutte e quattro le domande suggerite da Renata Morresi e Adelelmo Ruggieri.
Ora, pensare in termini di noi non risolve di per sé il problema dell’ego ipertrofico, del problema dell’autore-personaggio, sempre esistito, eppure modificato e amplificato in modi nuovi da un uso più social che sociale. Pensare a noi, pensare-noi, non è una panacea: ogni incontro può ridursi a una riunione di tanti io ipertrofici. (O tante monadi, per fare teoria della lirica.) Un’impressione che può benissimo uscire anche da uno specifico lavoro in termini di noi, ossia dalla lettura di tutti i contributi finora pubblicati nell’ambito dell’indagine che Gianluca Rizzo e io abbiamo inaugurato nel 2022 su Le Parole e Le Cose, con un questionario sul pronome di prima persona plurale in poesia.
Chi leggerà potrà trarre le proprie conclusioni su questo lavoro, che resta in fieri, e sulle varie declinazioni di noi che ne sono finora emerse. Gianluca e io abbiamo maturato, nell’ultimo anno, l’intenzione e il progetto di una pubblicazione cartacea che segni un ulteriore passo in questa elaborazione individuale/collettiva: non una (ennesima) antologia di poesia, ma una selezione di testi – non necessariamente “poetici”… – di chi ha già dato il proprio contributo; testi che diano ascolto ai tanti noi già espressi, non solo al proprio, e cerchino di dedurne qualcosa d’altro.
Ascolto è, in fondo, una parola chiave per noi: sembra banale, ma talvolta non lo è. Non lo è nemmeno la parola progetto, o progettazione, come si può leggere in questa citazione da “Per una definizione di avanguardia” (1966) di Elio Pagliarani apportata da Gianluca al nostro testo introduttivo per il questionario, e dove alla parola “nuovo” si può facilmente sostituire la parola “noi”, per i nostri scopi:
Molti fra i più impegnati dell’avanguardia […] ritengono […] che la finalità e/o funzione dell’arte sia quella dell’opposizione […] Ma qui preme far rilevare che l’opposizione è una modalità e non una finalità. […] Allargando l’orizzonte, […] la negazione si è specificata come contestazione. Contestazione dei significati, dei significati precostituiti, che lo scrittore trova nella lingua […]. Contestazione dei significati precostituiti e usurati della langue, e progettazione di nuovi significati. Progettazione e non fondazione di nuovi significati, perché la fondazione di nuovi significati relativamente alla lingua è opera della collettività, della società nella storia […]. Progettare il nuovo, perché non basta negare […].
Progettare, progettare continuamente – così come studiare, studiare continuamente… – sono parole d’ordine (o di disordine) che per me risuonano con tutt’altro autore e posizione teorica: Fred Moten, in Undercommons, e nella raccolta poetica La sonora reticenza, alla cui traduzione ho avuto la fortuna di collaborare (in una sua poesia, i projects sono “progetti” e “proiezioni”, ma anche, grazie alla polisemia del termine nell’inglese statunitense e vernacolare, anche le “case popolari”). Non sono due imperativi categorici né ideologici – l’accusa di ideologismo è talvolta la più ideologizzata di tutte, non sapendo nemmeno di esserlo – sono piuttosto due “modalità”, affinché l’opposizione non sia la “finalità” ultima, e riposante in sé stessa, dell’agire, anche poetico.
E sull’opposizione, o la resistenza (parola ormai fuori tempo massimo?), mi vorrei soffermare a lungo, ma non lo farò, anche perché nel corso dell’incontro si è cercato a più riprese di smontare la contrapposizione destra-sinistra – talvolta, e con buone ragioni, in favore della scrittura, dello “scrivere bene”…. Pur ricordando che i Prati generali nascono anche da un’idea di politica culturale diversa da quella in atto a livello locale e regionale (ma anche nazionale, trans/locale, ecc.), anche io ho cercato di svicolare dalla polarizzazione destra/sinistra. È verissimo, in fondo: oggi quella dicotomia sembra una cosa del Novecento, buona per i dazebao degli anni Sessanta/Settanta (e bisognerebbe dire, a tal proposito, che alcuni “dazebao” erano e continuano ad essere poeticamente eccellenti), eppure un fare poetico che si intreccia con una determinata politica culturale – sia essa di “destra” o di “sinistra”, a livello partitico – corre alcuni rischi, primo fra tutti quello di confermare un io ipertrofico ai danni non solo di sé, o di noi, ma anche di una latente “domanda di giustizia” come quella formulata esplicitamente, a un certo punto, da Renata.
E anche io mi sono inserito nella scia della decostruzione di questo binarismo ricorrendo ai lavori collettivi – curati insieme a Rosaria Lo Russo e Luciano Mazziotta – portati avanti tra il 2023 e il 2024, tra Firenze e Bologna, sull’opera di Furio Jesi. Se oggi rileggiamo Cultura di destra (1979) non lo facciamo soltanto per tracciare con maggior nettezza la genealogia culturale e politica – perlopiù nota, salvo il caso rumeno – dei fascismi e neo-fascismi europei, ma anche per vedere nella cultura di destra – assai presente anche, e soprattutto, in quella che superficialmente si auto-considera come “cultura di sinistra” – la cristallizzazione e l’assolutizzazione di valori che invece sono immersi nella storia e nelle sue contingenze. Fra questi, c’è la Poesia con la P maiuscola, così come dev’essere scritta ogni volta che la si invochi come territorio puro da contaminazioni (ideologiche, ad esempio… ma non solo!), intrinsecamente divergente e costitutivamente resistente: invocazione che spesso può nascondersi, in modo anche molto subdolo, dietro quella della “scrittura buona” (che invece, ripeto, è il primo orizzonte del fare poetico, per sé e per noi; primo, perché è quello più vicino al nostro naso). La poesia può morire, in un certo senso deve morire, se vogliamo fare festa – altro concetto-cardine, per Furio Jesi – e portare una traccia di quella festa dentro la nostra – buona – scrittura. Altrimenti rifaremo la Poesia con la P maiuscola, che è “cultura di destra” e, soprattutto, qualcosa di diverso da quello di cui ho, forse abbiamo, bisogno.
Portare una traccia della festa dentro al lavoro della poesia è come portare il silenzio dentro la voce, o l’invisibile dentro il visibile. (Dentro, o forse fuori: la questione, comunque, è dialettica…) Se ci preoccupiamo dell’invisibilità e della mancanza di ascolto, non è il “dare voce a chi non ha voce” – così paternalista! – che risolverà le nostre preoccupazioni: al contrario, si può più produttivamente dare voce a chi ha già avuto voce – magari flebile, o una voce che non ci è giunta, per vari motivi, in una lingua e con un volume che potessimo udire – traducendola. Tradurre poesia, ma tradurre anche le pratiche di ascolto che hanno luogo fuori dagli incontri di poesia, e che superano le linee di esclusione che la pubblicazione di poesia o l’organizzazione di eventi poetici continua a perpetuare, essendo chiaramente marcata la Poesia, ancora oggi – e lo si può dire per una semplice osservazione empirica, fuori di ogni posizionamento woke o anti-woke – come territorio bianco, borghese, maschio, cis, abile, non-animale, ecc.
Non basta, insomma, fare le quote rosa agli incontri o nelle pubblicazioni antologiche, non è mai bastato ed è anche un po’ peloso (pelo di bianco, borghese, maschio…). Né bastano le traduzioni esistenti di poesia – non basteranno mai, com’è ovvio, se ci si mette di fronte all’immane prolificità della letteratura-mondo… Perché continua a esserci un mondo fuori dalla porta del nostro circuito poetico – circuito che talvolta assomiglia così tanto, e così disperatamente, alla “terra e bar” convocata da Jacopo Curi.
Molte di queste faccende ruotano attorno alla presa di parola, sulla quale è forse opportuno interrogarsi ogni qual volta ci si para un microfono davanti per una lettura di poesia.
D’altro canto, però, non è nemmeno un problema da prendere troppo sul serio: in fondo, si potrebbe migliorare la nostra posizione rispetto alla politica culturale, come proponeva Marco Di Pasquale a tavola, creando un sindacato di chi scrive poesia (una Confederazione Italiana dei Poeti), che chieda, ad esempio, la dignità di rimborsi e compensi per lo spostamento delle persone, e un sindacato di chi organizza poesia (Confederazione Italiana Organizzatori di Poesia), per liberarsi dall’assillo di chi non è stat* invitat*…
Io mi iscriverei immediatamente a entrambe, ma conviene ricordare che si ha comunque a che fare con due sindacati, con CIP e CIOP… E questo fa – anche – molto ridere.
Al di là di questo, e uso un noi esortativo che riguarda soprattutto me e i mei bisogni: ascoltiamo, progettiamo, interroghiamoci sulla presa di parola.
Forse non vale nemmeno la pena di farlo per la Poesia, ma contro di essa.
Lorenzo Mari