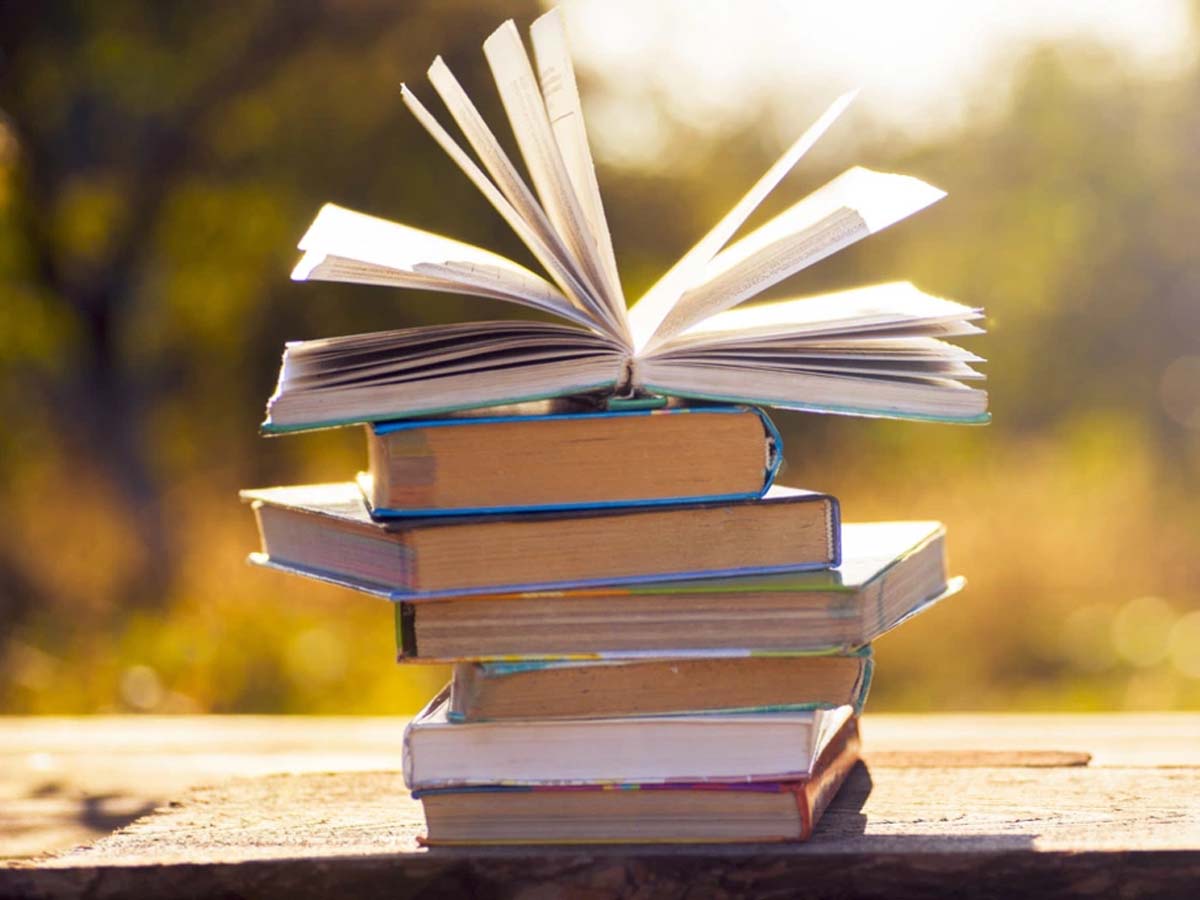La poesia non è esattamente al centro degli interessi dei già pochi lettori della nostra bella Italia, ma stavolta vorrei iniziare i miei consigli con l’invito alla attenta lettura di una poetessa di chiara fama, Emily Dickinson: non solo per la bellezza assoluta dei suoi versi, ma perché la sua stessa vita può essere letta come fusione assoluta di esistenza e poesia, nel suo caso l’elezione del reale giardino di casa a universo di bellezza, ricordo di qualcosa di più remoto, che va oltre le nostre vite individuali. Contro i falsi valori della società del suo -e del nostro- tempo, Emily sceglie il colloquio intimo con i fiori, le creature minuscole del piccolo Eden, memoria di una bellezza assoluta, per la quale si può anche morire, come in una sua celebre lirica che inizia proprio con “Morii per la bellezza”. Di questa struggente, profonda, comunione con il Tutto abbiamo numerose edizioni, da quelle della Newton Compton alla più recente dell’editore Fili d’Aquilone “Vi intreccerò in eteree collane”, con la attentissima traduzione di Giuseppe Ierolli.
E, a proposito di riscoperta della bellezza dei sentieri nelle montagne, o colline, vicino casa, ecco un libro che ci offre la possibilità di capire l’importanza dell’ambiente che ci circonda: “Il richiamo della montagna” (Feltrinelli) di un esperto della narrazione della natura, Matteo Righetto. È il racconto di una possibilità, quella che ancora potrebbe salvare l’uomo, non solo attraverso una ecologia razionale e scientifica, ma il recupero dell’amore verso i luoghi che nascondono la vera bellezza e il vero senso delle nostre vite. Lo aveva già capito il Pascoli di prima dell’era atomica e dell’ecologia, nel Fanciullino: dovremmo tornare bambini per riscoprire l’essenza vera del mondo, nascosta nella semplice, abissale, perfetta bellezza di un fiorellino ai nostri frettolosi piedi.
Visto che siamo nel Giubileo dei Giovani, come non andare ad un romanzo, “La luna e i falò” di Cesare Pavese, assai conosciuto, certo, ma che nasconde il segreto di un personaggio apparentemente minimale, rispetto al narratore che torna dall’America con la speranza di ritrovare ciò che vorrebbe, e non la realtà trasformata dal tempo, o al personaggio che crede nell’impegno politico e nella militanza ideologica: Cinto è un povero ragazzo, claudicante, che fa conti salatissimi con una miseria che allora non significava solo impossibilità di comprare al centro commerciale, ma proprio fame, mortale fame, come purtroppo torna ad accadere ai nostri giorni di nuove guerre. La nostalgia di un “paese che vuol dire non essere soli” diviene reale condivisione, e il povero ragazzo rimasto orfano e senza una casa trova una casa grazie all’interessamento dei due protagonisti. Cinto è il segno della speranza che rimane oltre il tragico destino del suo creatore. Noi lo abbiamo letto nell’edizione Einaudi.
Se vogliamo capire un po’ di più il grande tema della letteratura come vita, nel senso di aiuto e cura, allora, tra i tanti, consiglierei un libro dello storico, politico e docente canadese Michael Ignatieff, dal titolo “Sulla consolazione”, pubblicato qualche anno fa da Vita e Pensiero, in cui emerge la possibilità di trovare senso, anche quello che sembrerebbe perduto, in alcune testimonianze scritte, come quelle di Anna Achmatova, soprattutto alla luce delle Scritture. Una possibilità salvifica nel qui e nell’ora messa in rilievo anche dal sacerdote Francesco Buono nel recentissimo “Và, tuo figlio vive. Sentieri di speranza nel lutto” – di cui parliamo in modo più dettagliato in un altro articolo sulla homepage del Sir -, edito da San Paolo.
Buona estate amici lettori, e che il libro ci dia nuove speranze.