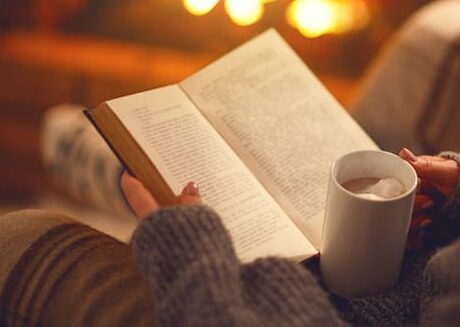L’anniversario di Hiroshima e Nagasaki ci ricorda, casomai ci fosse sfuggito, quanto la specie umana sia stata e sia vicina all’autodistruzione. Ogni giorno i titoli dei media descrivono un mondo feroce dove la catena delle atrocità rimane ben salda, di generazione in generazione, a dimostrazione che in giro non c’è molta empatia, qualsiasi cosa voglia dire questa parola la cui fortuna negli ultimi vent’anni si è rivelata inversamente proporzionale alla sua pratica. Piangere e disperarsi è inutile; impegnarsi per contrastare queste derive è, come minimo, faticoso; tanto vale adottare la sana politica dello struzzo, chiudere gli occhi e immergersi in una bolla di serenità, da cui ogni cattiveria sia tenuta ben lontana.
Ecco spiegato, in poche parole, il motivo del successo dei cozy books, i «libri confortevoli», nati in Giappone e adesso diffusi ovunque, Italia inclusa, come testimoniano, per esempio, un paio di titoli presi dalle ultime uscite di Garzanti, La piccola agenzia dei ricordi di Ren Kaburagi o Il negozio di libri usati di Jiro di Hika Karada. «Un rifugio emotivo popolato di librerie, caffè e gatti», sintetizza molto bene su El País Laura Fernández, che per esplorare il fenomeno ha tra l’altro parlato con Anik Lapointe, direttrice editoriale di Salamandra, sigla iberica che fa capo al gigante globale Penguin Random House, tra le prime in Spagna ad avere intercettato i cozy books: «Sono storie senza sorprese – spiega Lapointe – dove anche i conflitti si risolvono con delicatezza, e in cui i dettagli quotidiani – un piatto cucinato con amore, una conversazione piacevole, una semplice rivelazione personale – assumono un significato speciale».
A chi poi cerca un minimo di suspense, senza privarsi del necessario comfort, l’industria editoriale risponde con i cozy crimes, i gialli tranquilli, che Sarah Weinman sul New York Times descrive così: «Spensierati nei toni e privi di violenza e sangue, questi libri gentili e spiritosi sono l’antidoto perfetto per questi tempi difficili». Non una novità, scrive Weinman, citando vecchi titoli di questo genere (uno per tutti, The Cat Who Could Read Backwards di Lilian Jackson Braun, del 1966, uscito nei Gialli Mondadori nel 1991).
Un genere, in effetti, inventato a tavolino come espediente di marketing, appiccicando l’etichetta di cozy crimes ai vecchi gialli a enigma perlopiù britannici contrapposti ai rudi hard-boiled americani.
Se si tratterà di una moda passeggera o se i disastri planetari indurranno anche i più resistenti all’escapismo, è da vedere. Certo, guardando i titoli esposti nella maggior parte delle librerie oggi, si capisce almeno in parte la molla che il primo gennaio 2024 ha spinto un rispettabile cattedratico britannico Daniel Karlin, professore emerito di letteratura inglese all’università di Bristol, a prendere un proposito inconsueto: «passare un anno senza leggere un solo libro, giornale, periodico, rivista o saggio accademico – in effetti, qualsiasi cosa stampata su carta che non richiedesse ‘ufficialmente’ che io lo leggessi (come una visita medica o la notifica di una multa per eccesso di velocità). Niente poesia o narrativa; niente storia o filosofia; niente biografia, memoir o diario; niente Bibbia (o bigliettino amoroso); nessuna opera di saggistica (politica, scienze sociali, gastronomia)».
Chi desidera sapere come Karlin sia sopravvissuto all’assenza totale dalla parola scritta, non ha che da leggere il resoconto del suo anno vissuto pericolosamente sul Times Literary Supplement. Qui ci limiteremo a rivelare che non solo è sopravvissuto al suo esperimento, ma che non ha neppure sofferto di crisi da astinenza – un fatto che per la verità ha sorpreso anche lui.