di Leonard Berberi
Ogni giorno nel mondo ci sono 130 mila voli di linea, circa 300 mila piloti ai comandi che trasportano oltre 14 milioni di passeggeri. I piloti hanno turni particolari, molte responsabilità e uno stipendio che non subito gratifica
La voce, da classico statunitense, sbuca forte e chiara dagli altoparlanti dell’aereo. «Buongiorno a tutti, è il comandante che parla. Manca la firma ad alcuni fogli e poi siamo pronti a muoverci per questo volo da Milano Malpensa per New York-JFK», esordisce. «Il tempo lungo la rotta è bello, avremo qualche leggera turbolenza sopra le Alpi, per il resto nulla da segnalare. Dovremmo atterrare poco dopo mezzogiorno, ora locale, se fate i bravi. E dovete farlo perché stasera non voglio perdermi il compleanno di mia figlia», continua, tra l’ilarità di molti. «E proprio perché finora vi state comportando bene, invito i genitori con i bimbi a fare un salto in cabina di pilotaggio per una visita». E giù applausi.
Da qualche tempo, a partire degli Stati Uniti, il lavoro dei piloti è diventato anche questo. «Molti colleghi europei non sono entusiasti all’idea, ma inizieranno a farlo anche loro», racconta il comandante — un ex marine — mentre il velivolo ha da poco superato lo spazio aereo irlandese ed è sopra l’Oceano Atlantico. «Alla fine essere trasparenti conviene a tutti e in questo periodo c’è molta ansia di volare», sottolinea riferendosi alle diverse tragedie avvenute. L’ultima, a giugno, ha visto coinvolto un Boeing 787 di Air India precipitato 32 secondi dopo il decollo dopo lo spegnimento intenzionale dei motori per mano del comandante, stando ai resoconti degli investigatori. «E del resto stare dentro a un cilindro a 10-12 mila metri di quota e a 800-900 chilometri orari di velocità resta ancora qualcosa di “innaturale” per l’essere umano, non siamo fatti per volare, ma voliamo lo stesso».
Ogni giorno nel mondo ci sono 130 mila voli di linea, circa 300 mila piloti ai comandi che trasportano oltre 14 milioni di passeggeri. Se si includono anche i jet privati i decolli quotidiani toccano picchi di 250 mila, secondo Flightradar24. Tutti arrivano da una lunga formazione, sono sottoposti ad aggiornamenti costanti e devono gestire situazioni a volte imprevedibili. Si parte sedendosi a destra, nella cabina di pilotaggio, come primi ufficiali. Ci si sposta poi a sinistra, una volta che si diventa comandanti. I piloti hanno turni particolari, molte responsabilità e uno stipendio che — dopo alcuni anni — inizia ad essere buono. «Oggi per diventare pilota, in Europa, bisogna fare una scuola di volo per due anni, due anni e mezzo», racconta Danilo Recine, vicepresidente dell’Anpac e lui stesso comandante di Airbus sulle tratte intercontinentali. E il costo per studiare non è certo basso: «Attorno a 100-120 mila euro». «Ottenuta la licenza bisogna poi aggiungere le abilitazioni che sono specifiche per il tipo di aereo che si intende pilotare, facendo il cosiddetto “passaggio macchina”», prosegue. E qui si tratta di altri 25 mila euro, per esempio per gli Airbus A320 o Boeing 737 — i più usati nel mondo — «e si fa tutto sui simulatori di volo». Poi tocca all’«addestramento in linea», qualcosa come 30-40 voli sui jet. Quando entrano in una compagnia i piloti vengono sottoposti anche a un test sulla personalità. Una serie di domande, anche stupide, per capire se il candidato è affidabile oppure no, anche se gli stessi piloti e gli psicologi dell’aviazione ritengono che non sia sufficiente.
Il passaggio da primo ufficiale a comandante di solito si fa seguendo una «lista di anzianità» di assunzione nel vettore e solo se la compagnia ha bisogno. «Si effettua il “corso comando” tra simulatore e attività di volo ma anche visite con uno psicologo», sottolinea il vicepresidente dell’Anpac. «È un’attività intensa che serve a vedere se il candidato è in grado di gestire le situazioni complicate». Poi ci sono sei mesi di prova, con un test in mezzo. Test «che non superano tutti — il 10% non ce la fa — e a quel punto si torna primi ufficiali».
I turni sono fissati dalle norme dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa). «Comandanti e primi ufficiali non possono volare più di 900 ore all’anno, per un totale di 2 mila ore di servizio complessivo che include tutto quello che c’è prima, dopo e durante i viaggi», spiega Recine. Poi ci sono altri vincoli: «Massimo 60 ore di servizio a settimana e ogni 168 ore bisogna fare due notti di riposo». Per esempio: «Fermarsi alle 22 di un lunedì e riprendere non prima delle 6 di mercoledì». La low cost Ryanair adotta lo schema «5/4»: i piloti lavorano per cinque giorni di fila, riposano per i successivi quattro. Nel complesso chi effettua voli brevi e medi lavora per 12-14 ore al giorno per massimo quattro voli. Sul lungo raggio i turni salgono a 16-17 ore (con tre piloti che si danno il cambio e riposano alternandosi) o 18 ore (se i piloti sono quattro).
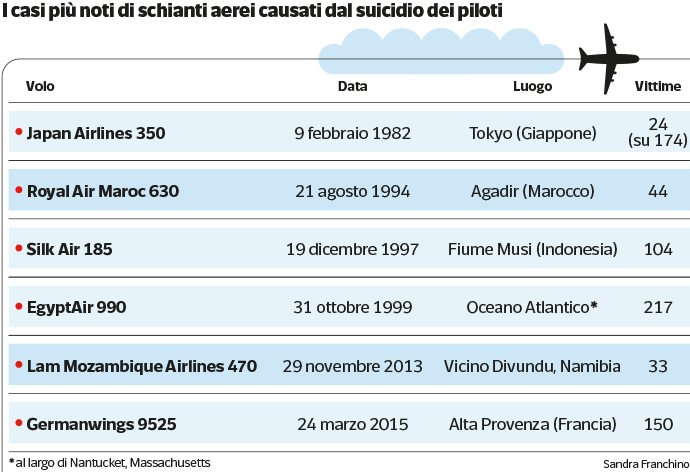
Sui collegamenti intercontinentali una volta arrivati a destinazione il riposo è di 24-26 ore, poi si torna in cabina per il viaggio in direzione opposta. C’è, in tutto questo, anche una questione “oriente-occidente”. Chi ha volato prima a oriente e poi deve farlo verso occidente — ad esempio Roma-Tokyo, Tokyo-Roma e poi Roma-New York — o viceversa ha tre notti obbligatorie minime di riposo a Roma. «Questo anche per attenuare le conseguenze del fuso orario». E ora l’argomento più “delicato”. Quanto guadagna un pilota? «Dipende», risponde Recine. «C’è chi ha un contratto con una significativa parte fissa, il 70-75% dello stipendio annuale: è il caso dei contratti di easyJet e questo garantisce entrate stabili anche durante i periodi in cui si vola di meno, come l’inverno. Altri vettori sono più concentrati sulla componente variabile (40-45% del totale) che risente dei periodi di picco minimo e massimo. Ma molto dipende anche dall’anzianità e dal grado: comandanti e primi ufficiali non ricevono lo stesso stipendio».
In Italia di che cifre si parla? «Si va da uno stipendio di ingresso di 30 mila euro all’anno per un primo ufficiale a 90-100 mila euro per un comandante con la massima anzianità». Insomma nulla a che fare con i 400-500 mila euro offerti dai vettori cinesi. «Ma loro hanno disperato bisogno di piloti». Il tipo di attività ha conseguenze anche sulla vita privata. Chi vola per una low cost o che effettua collegamenti brevi «sa che la sera torna a casa», dice Recine. «I colleghi del lungo raggio, invece, imparano da subito ad abituarsi al fatto che succedono cose a casa e non ci sono perché sono a Tokyo o Buenos Aires. A un certo punto ci si abitua». Dall’altro canto però c’è la stabilità organizzativa. Ma è vero che comandanti e primi ufficiali mangiano pasti diversi in volo? «Assolutamente sì» risponde secco Recine. «Non solo differente da quello offerto ai passeggeri, ma anche dagli altri piloti in cabina —: si chiamano “pasto A” e “pasto B” perché se dovesse accadere qualcosa a uno, non succede all’altro». Sui passeggeri il vicepresidente dell’Anpac prova a essere diplomatico. «Diciamo che in generale è cambiato il loro atteggiamento… ed è cambiato in peggio. Le persone viaggiano sempre più spesso, hanno familiarità con l’aereo, non sono intimoriti. Per questo da parte di qualcuno c’è un atteggiamento sprezzante, maleducato. E qui c’entrano anche i social».
9 agosto 2025 ( modifica il 9 agosto 2025 | 12:59)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
