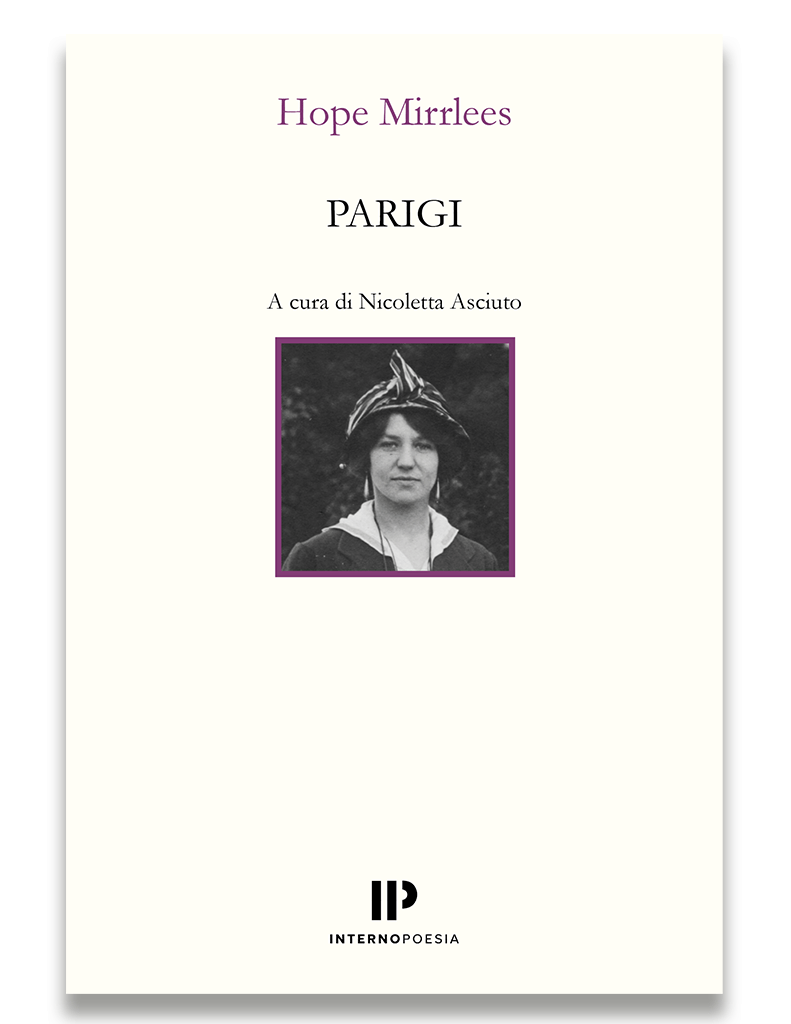di Anna Toscano
In un piccolo libricino di liriche di Wislawa Szymborska, uscito per Adelphi nel 2012 col titolo Basta così nella traduzione di Silvano de Fanti, è contenuta la poesia “La Mappa”, a ben guardare questo testo chiude proprio la silloge come una sorta di lascito. “La Mappa”, infatti, ci parla di luoghi vicini e lontani che possiamo osservare chini su un tavolo: lei piatta, la mappa, parla di montagne e fiumi, di alture e pianure, alberi e vulcani. Dice tutto la mappa, con rigore e disciplina, ma anche nasconde molto ed è per questo che ci sfida a guadare meglio, a grattare la superficie, a togliere le bugie che racconta come fossero briciole su una tovaglia. “Fosse comuni e improvvise rovine / sono assenti in questo quadro”. Wislawa Szymborska ci invita a grattare la mappa dei luoghi per guardare oltre, allo stesso modo guardiamo lo spazio bianco che racchiude sulla pagina una poesia: la poesia come un luogo, che dice e che tace. D’altronde Szymborska dal cassetto della propria scrivania, luogo pieno di magie, alla stazione della città di N., in cui non giungerà mai, è una poetessa del dove, una poetessa con una forte dimensione spazio-temporale.
Le mappe dicono e non dicono, permettono di tracciare percorsi, di far sentire i suoni dei luoghi, di scavalcare confini, di immaginare posti impossibili come la luna, di disegnare traiettorie portando con sé pietre nelle tasche. Alcune poete hanno fatto questo a inizio del secolo scorso, hanno messo in versi i territori che attraversavano e composto guide in rima, mischiando l’ordine razionale al caos fantastico, come le mappe.
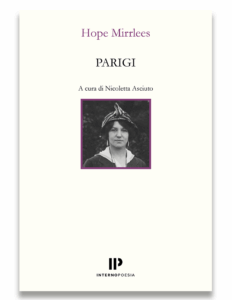
In questi giorni rivede la luce un libro dimenticato da decenni, si intitola Parigi, a cura di Nicoletta Asciuto, pubblicato da Interno Poesia. La sua autrice, Hope Mirrlees, nata sul finire dell’Ottocento in Inghilterra, studiosa, traduttrice, scrittrice e poeta, frequenta, tra Londra e Parigi, gli intellettuali della sua epoca e con loro si confronta e si misura seppur con la sua indole ribelle e riservata al contempo. Parigi è un poema modernista dedicato alla capitale francese, in 445 versi con citazioni in francese, greco, latino e russo, in cui Ovidio e Rue du Bac possono incontrarsi sulla stessa pagina. La prima edizione di questo poema viene pubblicata dalla Hogarth Press: Virginia e Leonard Woolf sono fortemente attratti dalla sperimentazione linguistica e grafica dell’allora sconosciuta Mirrlees. Ne stampano 175 copie nel 1920. Nei decenni successivi il mondo anglosassone ha alcune volte dimostrato interesse per questa autrice, con una ristampa nel 1973 e una nel 2007, diversi articoli e studi: ma è solo negli ultimi anni che Mirrlees sta uscendo dalla polvere dell’oblio grazie anche al suo romanzo fantasy, Lud nella nebbia, che rivive in questi mesi in nuove ristampe, come quella italiana per Cliquot. L’edizione di Interno Poesia ci porta con Parigi, dopo oltre un secolo, un’opera viva e vivace, talvolta ruvida e sarcastica, in cui una poeta di inizio Novecento riversa tutta la sprezzante libertà che chiede alla sua vita.
Giudicata spesso bizzarra e poco socievole, rispolverando questo libro, alla luce della sua vita e delle altre sue opere in prosa e in poesia, si scopre una donna forte e poco incline ai compromessi sia nella vita sia nella scrittura. Al netto dei pettegolezzi, che spesso si rivelano maldicenze, sulla sua vita sentimentale, sulle sue relazioni con altre donne, sulle sue frequentazioni, e libera dai luoghi comuni, Mirrlees si rivela oggi come una grande studiosa e un’autrice visionaria. La sua Parigi, uscita due anni prima di The Waste Land di T. S. Eliot, diviene la nostra Parigi, e verso dopo verso assistiamo alla messa in scena di questo luogo partendo dalla mappa e grattando grattando si assiste a una proiezione di immagini e pensieri: dalla città eterna per bellezza e arte fino alle zone di morte: “Della storia d’amor perduta / vergata da qualche Ovidio, schiavo riluttante / nel Paese delle Favole, nessuno ne conosce il nome; era il segreto della corporazione dei pittori italiani. / Passarono la loro vita ad illustrarla….”.
Negli stessi anni un’altra poeta scrive in versi il proprio “Baedeker”, una guida di viaggio dolorosa e allucinata quanto magica. È Mina Loy, anche lei inglese nasce a fine Ottocento, e in The Lost Lunar Baedeker mette in versi la sua vita alla ricerca di una identità, prendendo avvio da una scrittura che nasce dal suo modo di guardare, ascoltare, il mondo e sé stessa. Ripubblicato in Italia da Rina Edizioni nel 2022, riporta alla luce il lavoro di una artista che con decenni di anticipo ha visto ogni cosa: grazie alla sua sensibilità ha visto la frantumazione del corpo, la fine della servitù dell’immaginario, lavorando con un corpo, il suo, che è un corpo del post umanesimo che va oltre a identità, generi e ruoli. The Lost Lunar Baedeker raccoglie versi che vanno dal 1914 agli anni Cinquanta del secolo scorso e traccia la mappa della sua esistenza attraverso città, paesi, superando l’inferno per arrivare sulla luna. Come per Szymborska e Mirrlees, Loy gratta la mappa, attraversa con la sua scrittura il sentimento di inappartenenza che la angustia per vedere cosa ci sia sotto. Donna che non cerca il consenso con la sua opera, anzi graffia la superficie, si scontra su molte cose nel suo cammino senza mai tirarsi indietro: donna tradita, umiliata, schernita, richiusa, dimenticata, rinasce ogni volta grazie alla sua scrittura e alle sue opere d’arte. Sono versi nei cui luoghi stazionano personaggi reali o di carta, artisti, passanti lungo la strada o vecchine alla finestra. Come nella sua vita, anche in poesia le partenze sono molte, partenze dopo una caduta, dopo una reclusione, partenze per ricominciare – “Sono il centro / Di un cerchio di dolore / Che eccede i propri limiti in ogni direzione” – la scrittura come ago e filo per suturare i pezzi di una vita che non combaciano più. Ma Loy, come Mirrlees e molte altre, non intraprende queste partenze e questi percorsi solo per sé, a suo uso, ma per parlare alle altre donne in una comunanza di lotta e speranza. Non possiamo parlare ancora di sorellanza, ma certamente di ricerca di una unione anche solo di sguardi per salvarsi: “Gli occhi di un migliaio di donne / Inchiodati sull’irrealizzabile / Cospargono la toeletta della cartomante / Scheggiano marmo di Carrara / Su cui sparpaglia / Le colorate mappe del destino / Nell’angolo di una poco propizia camera da letto […]”.
Parigi e The Lost Lunar Baedeker sono anche mappe del corpo in quanto le loro autrici ci hanno riversato loro stesse attraverso la scrittura, quel corpo che loro avevano inteso in anticipo come territorio di battaglia e di arte. Lo stesso corpo, come le mappe, lo hanno graffiato per vedere cosa ci fosse sotto. Talvolta il corpo si è rivelato composto da pezzi di pietra che si frantumano in mille pezzi e allora ognuno va raccolto, messo in tasca – “Pietre per le mie tasche”, scrive anni dopo Karen Press. Un corpo pagliaccio, un corpo mutante, un corpo che sceglie scrive Mina Loy: “[…] Siamo pagliacci sacri / che si nutrono di vento e stelle / e delle polverose pasture della miseria / Le nostre volontà si modellano / sopra bizzarre discipline / al di là delle vostre leggi / Potete partorirci / o sposarci / le possibilità della vostra carne / non sono il nostro destino-“ […].