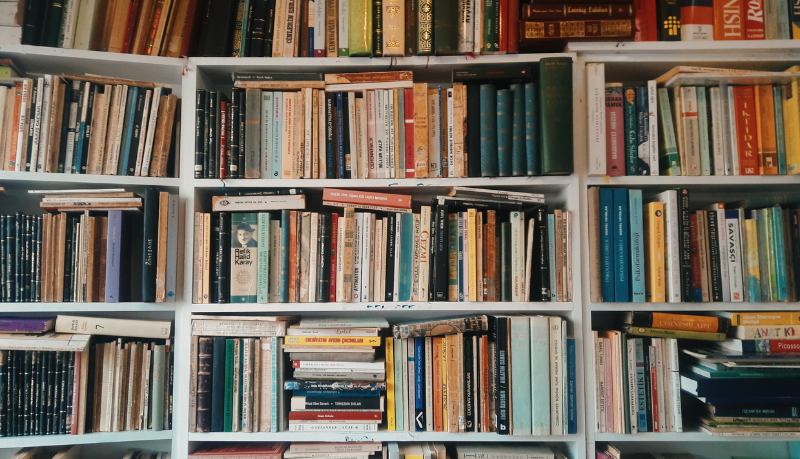20 Ago Una lettura polimorfa
Posted at 10:01h
in Angolo del Cardinal Gianfranco Ravasi
by Alessandro Pancalli
da Il Sole 24 Ore – 17 agosto 2025 – di Gianfranco Ravasi.
Ugo Foscolo confessava a Vincenzo Monti: «Io cultor di pochi libri sono». Mallarmé, al contrario, non esitava a dichiarare: «La carne è triste, ahimè, e io ho letto tutti i libri», anche perché «il mondo è fatto per finire in un bel libro». Ho convocato questa duplice citazione – che potrebbe essere ulteriormente infoltita – per segnalare un atteggiamento testimoniato da molti.
Per alcuni la lettura di un libro è come una strada maestra che non ammette deviazioni o ramificazioni sino alla fine; per altri (inter quos et ego) l’atto di leggere è polimorfo perché si procede in contemporanea lungo gli itinerari di libri diversi, in una sorta di bulimia bibliografica. Seguendo questo secondo approccio, cercherò di segnalare – non recensire – un ventaglio di testi recenti che mi sono pervenuti e che ho sparpagliato sulla mia scrivania. Naturalmente tra essi intercorrono sotterranei fili di omogeneità.
In capo a questa che è poco più di un’elencazione pongo un volume dedicato a un orizzonte policromo, spesso esplorato, nel quale l’autore, Carmelo Dotolo, un docente universitario a Roma e a Urbino, si è avviato con molta originalità. Tra l’altro, egli propone un raffinato capitolo ermeneutico che considera «la lettura come percorso di riscrittura di Sé e del mondo», cosicché il leggere divenga persino un «poter-essere altrimenti». Entriamo nel cuore di questo saggio intitolato Generare un mondo diverso (Il Portico, pagg. 265, €22,00).
Attraversando la letteratura biblica, «interpretata e trasformata», scavando nell’orizzonte religioso delle Scritture Sacre e tenendo conto sempre che la letteratura è «un’esperienza che modifica» e che il narrare è un «prendersi cura dell’umano», l’autore ha costruito una mappa non esaustiva ma emblematica dell’immaginazione biblica selezionando tre gangli o snodi capitali: la Torah, il Regno, il Messia. A dire altro negheremmo il piacere di una lettura che, in ultima analisi, ha lo scopo di incrociare l’immaginario scritturistico teologico con la pesantezza dell’esistenza offrendosi come codice interpretativo e metamorfico di quest’ultima.
In contemporanea, però, mi sono lasciato attrarre da una scrittrice che confesso di aver già amato in molte sue pagine, come penso sia accaduto a tanti lettori, Marylinne Robinson, nata a Sandpoint nel 1943, i cui romanzi sono stati tradotti da Einaudi, a partire dal famoso Gilead (2008). Ora propone un suo Leggere Genesi (Marietti 1820, pagg. 288, €18,00) che ho seguito con curiosità, nonostante una netta soggettività dell’autrice nella rilettura di un’opera che non è solo “in principio” alla Bibbia, ma anche alla creazione e alla storia e che è stata sempre una stella polare dell’arte, della letteratura, del pensiero e persino della scienza.
Facendo sconto alla libertà ermeneutica e anche a qualche semplificazione e ingenuità, Robinson parte con una griglia teologica specifica sin dalla prima riga: «La Bibbia è una teodicea, una meditazione sul problema del male», tant’è vero che «fin dall’origine l’impeccabile Creazione di Dio va incontro a una serie di alterazioni, deterioramenti che consentono l’anomalia di una creatura manchevole». Tuttavia, procedendo nella lettura, si intuisce già con Noè e soprattutto con Abramo che l’amore di Dio per questa creatura incespicante non cessa così che «la grazia modifica la legge e la legge non può limitare la grazia».
Mentre avanzavo in queste pagine che dicono tanto altro, sono andato fuori pista attratto da un miraggio contenuto nel saggio di un famoso critico, sceneggiatore (ad esempio, Taxi Driver o l’esasperata Ultima tentazione di Cristo) e regista (American Gigolò) statunitense, Paul Schrader (1946). Di scena è, allora, un’altra arte, la settima, e la ricerca è esplicitata nel titolo Il trascendente nel cinema (Marietti 1820, pagg. 280, €28,00), con un’imponente e preziosa prefazione di una nota personalità della cultura italiana, Gabriele Pedullà.
L’attrazione per questo saggio – che è di una ricchezza documentaria e di una finezza analitica indiscussa – è fiorita in me perché nella triade di registi che si sono inerpicati sui sentieri d’altura della trascendenza, ho trovato due veri e propri amori fin dalla mia giovinezza. Escludendo il giapponese Ozu che poco conosco, ecco due giganti, Robert Bresson e Carl Dreyer. Di quest’ultimo basti solo pensare che rimasi conquistato, appena maggiorenne, dal suo Ordet (La Parola), visto in danese coi sottotitoli inglesi. E da lì fu spontaneo seguire l’intera sua straordinaria filmografia; lo stesso vale per Bresson e per un altro grande della cinematografia, il russo Andrej Tarkovski che nelle pagine di Schrader è pure presente, vagliato attraverso il filtro teorico di Gilles Deleuze.
A concludere, ecco un’altra incursione condotta in simultanea nell’orizzonte cinematografico con un saggio “apologetico”, il cui titolo evoca un film visionario considerato provocatorio, anzi, blasfemo quando apparve sugli schermi: L’ingiusto processo al Gesù di Scorsese di Pierluigi Di Pasquale (Baldini+Castoldi, pagg. 201, €19,00). Il film in questione è la citata Ultima tentazione di Cristo (1988) con la sceneggiatura proprio di Schrader e che era sulla falsariga dell’omonimo romanzo di uno dei massimi scrittori greci del ‘900 Nikos Kazantzakis. Nei giorni della sua diffusione nelle sale ero in viaggio negli Stati Uniti e fuori dai cinema gruppi di cristiani integralisti inalberavano croci e Madonne con canti e preghiere di riparazione. A distanza di decenni chi leggerà le pagine molto appassionate e documentate di questa strenua difesa troverà molte sorprese e comprenderà l’approdo successivo di Martin Scorsese attraverso i suoi dialoghi con papa Francesco.