Negli ultimi 50 anni, il numero medio di spermatozoi negli uomini è diminuito a un ritmo dell’1% all’anno. Dal 2000 il calo si è addirittura accelerato, superando il 2% annuo. In parallelo, anche la fertilità complessiva della popolazione mondiale mostra lo stesso andamento come documentano numerose ricerche scientifiche.
A lanciare l’allarme è Shanna Swan, professoressa di medicina ambientale e sanità pubblica alla Icahn School of Medicine del Monte Sinai di New York che da anni studia la relazione tra sostanze chimiche e salute riproduttiva. Secondo quanto riportato Guardian fattori come l’obesità, la sedentarietà o l’invecchiamento delle popolazioni non spiegano da soli l’entità del fenomeno: “Il declino è in gran parte, ma non interamente, dovuto alle tossine ambientali che interferiscono con gli ormoni steroidei”.
 Bicchieri di plastica monouso su sfondo azzurro
Bicchieri di plastica monouso su sfondo azzurro
Gli studi e i dati
Nel 2017 Swan e i suoi colleghi hanno pubblicato una meta-analisi che documentava un calo della conta spermatica di quasi il 60% tra il 1973 e il 2011 negli uomini di Nord America, Europa e Australia. Sei anni dopo, lo studio è stato aggiornato fino al 2018 includendo anche dati provenienti da Africa, Asia e Sud America. Il risultato è stato ancora più allarmante: il declino è significativo in tutto il mondo, senza distinzioni tra paesi occidentali e non. Ancora più preoccupante è la velocità con cui il fenomeno si sta accentuando. Se dal 1973 la riduzione annua era circa dell’1%, dopo il 2000 i dati mostrano un’accelerazione oltre il 2% annuo.
Il ruolo degli additivi plastici
Il crollo della fertilità maschile coincide con la crescita esponenziale dell’uso della plastica dal secondo dopoguerra. Gli scienziati hanno individuato un legame diretto tra due additivi largamente utilizzati e la salute riproduttiva: ftalati e bisfenoli. Gli ftalati rendono le plastiche morbide e flessibili e sono presenti in contenitori per alimenti, bottiglie, pellicole e dispositivi medici. I bisfenoli invece rendono le plastiche rigide e resistenti, come nel caso delle bottiglie dure o delle resine epossidiche. Il problema è che queste sostanze chimiche sono interferenti endocrini: gli ftalati abbassano i livelli di testosterone, i bisfenoli aumentano gli estrogeni.

L’esposizione in gravidanza è particolarmente rischiosa: Swan ha dimostrato che nei feti maschi l’assorbimento di ftalati durante periodi critici dello sviluppo può portare ad anomalie anatomiche, note come “sindrome da ftalati”: genitali meno sviluppati, riduzione della distanza ano-genitale e, da adulti, una minore conta spermatica.
Minaccia come il cambiamento climatico
Un rapporto pubblicato da Deep Science Ventures e rivisto dalla stessa Swan ha definito l’inquinamento chimico “una minaccia della stessa grandezza del cambiamento climatico”, ma con un’attenzione pubblica e politica molto inferiore.
Nonostante la gravità del problema, i negoziati internazionali per un trattato globale sulla plastica si sono conclusi a Ginevra senza alcun accordo. Dopo quasi due settimane di discussioni, le pressioni dei paesi produttori di petrolio e gas hanno impedito l’inclusione di limiti alla produzione e di controlli sugli additivi chimici. Eppure quasi 100 nazioni avevano chiesto l’introduzione di un obbligo legalmente vincolante per eliminare progressivamente le sostanze più pericolose.
 piatto, forchetta, coltello e cucchiaio in plastica monouso bianca su ripiano color petrolio
piatto, forchetta, coltello e cucchiaio in plastica monouso bianca su ripiano color petrolio
Italia ed Europa: cosa si sta facendo?
In Europa, la legislazione sugli interferenti endocrini è frammentata e procede a piccoli passi. Alcuni ftalati (DEHP, DBP, BBP e DIBP) e il bisfenolo A sono già stati limitati o vietati in determinati prodotti, come giocattoli, biberon e materiali a contatto con alimenti. Tuttavia, le deroghe sono ancora molte e spesso gli additivi proibiti vengono sostituiti da altri composti simili, la cui sicurezza non è garantita.
L’Italia è tra i principali consumatori europei di plastica monouso, sebbene negli ultimi anni si siano moltiplicate campagne e normative per ridurne l’uso, come il divieto di piatti e posate monouso in plastica non compostabile. L’Istituto Superiore di Sanità e diverse università hanno condotto studi sugli ftalati nelle urine della popolazione italiana, trovando livelli di esposizione diffusi, soprattutto tra i bambini.
La ricerca ha anche mostrato che una parte significativa dell’esposizione deriva dagli imballaggi alimentari: bottiglie, pellicole, contenitori per fast food o take-away. Nonostante le misure europee, in Italia resta difficile per il consumatore sapere con certezza quali prodotti contengano additivi a rischio.
Principali additivi plastici usati in Europa e in Italia
Uso principale
Effetto noto/sospettato
Stato normativo UE/Italia
Consigli per ridurre additivi plastici
Preferire contenitori in vetro o acciaio per conservare e trasportare alimenti e bevande. Evitare di riscaldare cibi in contenitori di plastica, specialmente nel microonde. Ridurre il consumo di cibi confezionati e preferire alimenti freschi. Limitare l’uso di bottiglie di plastica monouso, sostituendole con borracce riutilizzabili. Prestare attenzione a etichette e diciture come “senza BPA”, anche se non sempre equivalgono a sicurezza assoluta (spesso vengono sostituiti con analoghi come BPS). Smaltire correttamente la plastica per evitare contaminazioni ambientali che possono tornare nella catena alimentare.
IStock, Depositphotos, AdobeStock
© Riproduzione riservata -Foto: IStock, Depositphotos, AdobeStock
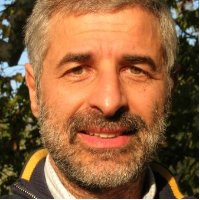
Giornalista professionista, direttore de Il Fatto Alimentare. Laureato in Scienze delle preparazioni alimentari ha diretto il mensile Altroconsumo e maturato una lunga esperienza come free lance con diverse testate (Corriere della sera, la Stampa, Espresso, Panorama, Focus…). Ha collaborato con il programma Mi manda Lubrano di Rai 3 e Consumi & consumi di RaiNews 24
