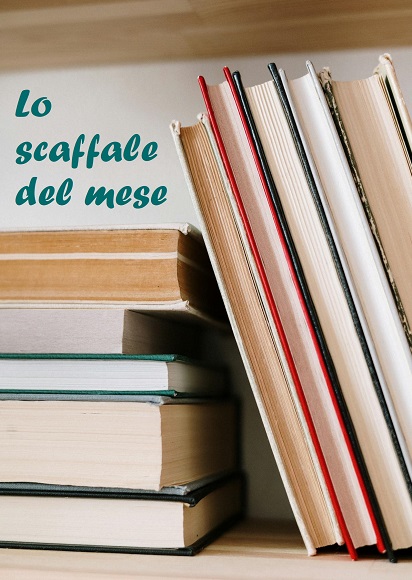Ci sono libri che non leggiamo solo per la trama o per lo stile, ma perché tra quelle pagine troviamo riflessi di noi stessi. A volte ci sorprendono, altre volte ci offrono conforto. Tre opere molto diverse per epoca e stile — Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, Kitchen di Banana Yoshimoto e La più amata di Teresa Ciabatti — condividono un tema che coinvolge tutti: la solitudine e il desiderio di connettersi con gli altri.
3 libri sulla solitudine
Le notti bianche: un incontro che illumina. Nel 1848, Dostoevskij scrive questo breve romanzo che ha la delicatezza di un sogno. Il protagonista è un giovane sognatore, incapace di affrontare la realtà, finché non incontra Nasten’ka. Insieme trascorrono quattro notti a condividere desideri, paure e speranze. Non sarà una storia d’amore destinata a durare, ma un incontro che lascerà un segno indelebile.
Ho sempre visto Le notti bianche come il Dostoevskij “più gentile”. Qui non c’è la pesantezza dei suoi grandi romanzi, ma una storia che parla al cuore con una dolcezza disarmante. Ci ricorda che anche un legame fugace può trasformare la vita di chi si sente invisibile. Non è un caso che il famoso film omonimo del 1957 con Marcello Mastroianni riesca a catturare tutta la poesia sospesa di questa narrazione.
Kitchen: cucinare per sentirsi vivi. Con Banana Yoshimoto, ci immergiamo nella Tokyo degli anni ottanta. Mikage, la protagonista, ha appena perso la madre e, poco dopo, anche la nonna che l’ha cresciuta. Si ritrova all’improvviso sola, ma scopre un rifugio inaspettato: la cucina. Non è solo un luogo fisico, ma uno spazio simbolico dove può ritrovare calore e continuità.
Quello che rende speciale Kitchen è la leggerezza con cui affronta il dolore. Non è mai un romanzo pesante; al contrario, mostra come gesti semplici, come cucinare o condividere un pasto, possano diventare atti di resistenza contro la solitudine. Yoshimoto ci insegna che la famiglia non deve necessariamente essere legata al sangue, ma può nascere da incontri che generano affetto e cura reciproca. Ogni volta che leggo questo libro, rifletto su quanto sia universale il bisogno di “casa”: non un luogo fisico, ma una profonda sensazione di appartenenza.
La più amata: guardare in faccia le proprie ferite. Con Teresa Ciabatti, il discorso diventa più incisivo. La più amata è un romanzo autobiografico in cui l’autrice esplora la sua infanzia e il complesso rapporto con il padre, una figura carismatica ma ingombrante. È un racconto che non risparmia nulla, mettendo a nudo le parti più dolorose delle relazioni familiari.
Qui, la solitudine non deriva dall’assenza, ma dalla presenza di legami distorti e soffocanti. È quella solitudine che si prova tra le mura di casa, circondati da persone che dovrebbero amarci, ma che invece ci lasciano ferite difficili da guarire. La più amata non offre consolazione, ma una scrittura astuta e senza filtri che costringe il lettore a confrontarsi con le proprie ombre. Non è un libro semplice, ma è uno di quelli che ti rimangono dentro.
Tre voci, un unico battito
Mettere insieme Dostoevskij, Yoshimoto e Ciabatti può sembrare azzardato, ma le loro opere dialogano sorprendentemente bene. Sono tre modi diversi di raccontare la stessa condizione umana:
- la solitudine romantica di Dostoevskij, che si apre per un attimo alla speranza;
- la solitudine quotidiana di Yoshimoto, affrontata con piccoli gesti di cura;
- la solitudine radicale di Ciabatti, che nasce dalle ferite più intime.
Tre linguaggi diversi per dire che non c’è un unico modo di essere soli, né un unico modo di cercare connessione.
Perché leggerli oggi
Viviamo in un’epoca iperconnessa, eppure mai come oggi si parla di solitudine. Forse è proprio per questo che questi tre libri, scritti in tempi e luoghi così diversi, continuano a risuonare con noi. Ci ricordano che il bisogno di connessione è qualcosa di universale e che, anche nei momenti più bui, possiamo trovare un legame con gli altri. Personalmente, ciò che mi lasciano è la consapevolezza che la solitudine non è solo un vuoto da riempire: può diventare un passaggio, un modo per scoprire quanto abbiamo bisogno degli altri. E forse questo è il dono più grande della letteratura: farci compagnia e farci sentire meno soli.
Foto di cottonbro studio da Pexels
Navigazione articoli