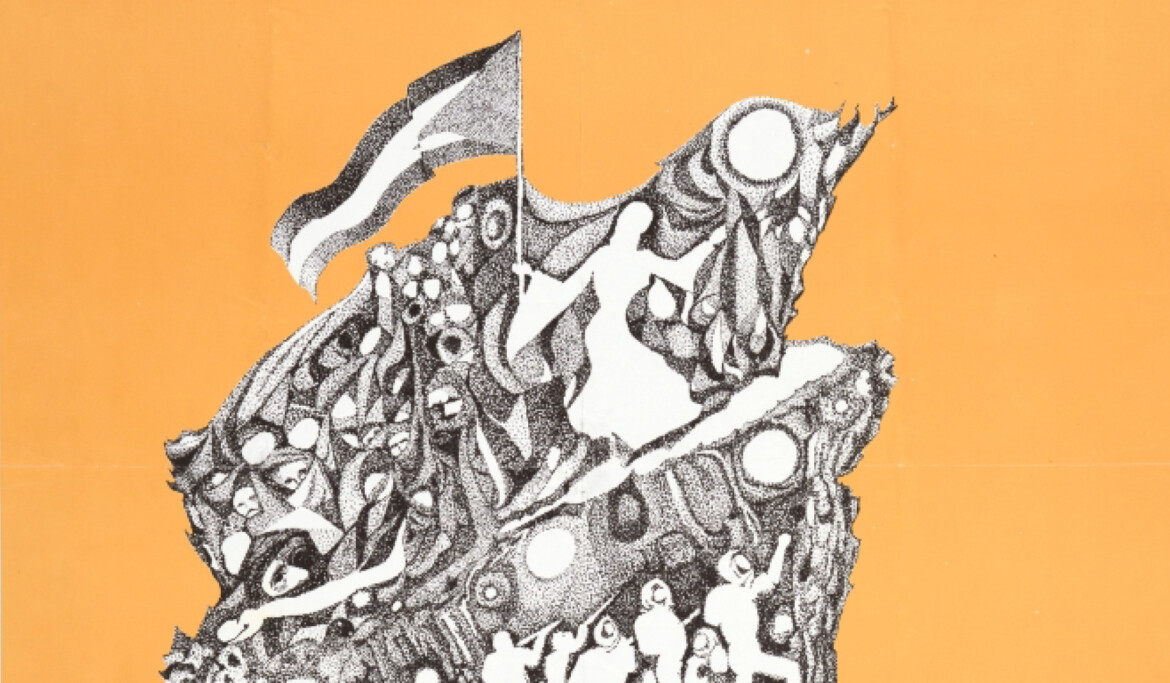In Palestina/Israele, crescendo ti rendi conto che la lingua è molto più di uno strumento da utilizzare solo per raccontare o comunicare. Può essere attaccata, può essere distrutta, può essere maltrattata. La questione è quindi: come ci si può fidare della lingua quando è essa stessa causa di dolore, quando ti abbandona e devi affrontare la crudeltà nella solitudine, senza parole?
Questo mi ha spinta a indagare le forme narrative praticabili in questa lingua, a sondare le infinite possibilità che si nascondono tra i suoi molteplici strati, e quelle che possono affiorare dall’amore che provi per lei, dall’amore che lei può ancora provare per te.
VERO È CHE LA LINGUA è spesso costretta in un’unica, principale forma narrativa, razionale, chiara e comprensibile. Ma cosa succede quando non siamo più capaci di usare questa forma? Che lingua affiora in questo caso? Come si fa a scrivere con una lingua muta o ferita? Tutte queste domande mi perseguitavano prima di cominciare a scrivere il mio romanzo, con tutti i suoi elementi; da una parte perseguire una forma narrativa della lingua che fosse accettabile, dall’altra una forma narrativa che sminuiamo perché non riusciamo quasi mai ad accedervi, e forse nemmeno vogliamo farlo.
Se dovessi analizzare razionalmente Un dettaglio minore, direi che in una parte esplora una certa forma letteraria, inseguendo le orme di una lingua a noi accessibile, mentre nell’altra prova a mettersi sulle tracce di una lingua con cui non riusciamo mai a entrare in contatto. Ora che ho finito di scriverlo, capisco meglio i problemi che mi hanno portata alla forma e al contenuto letterari di questo romanzo, inclusi la struttura e lo stile narrativo, entrambi modellati da particolari esperienze linguistiche.
In breve, creare collegamenti con eventi reali non è la forza che muove la mia scrittura letteraria, né in generale, né nel caso specifico di Un dettaglio minore. Fin dove può arrivare la lingua oggi? Continuo a chiedermelo, e ho paura. Paura. Detesto la paura, fin dall’infanzia, perché vedevo la gente attorno a me agire in base a essa. Per questo ho cominciato presto ad allenarmi contro la paura.
DA PICCOLA mi ero anche chiesta quale fosse la mia paura più grande. L’avevo identificata in un punto della nostra casa, dove la mia immaginazione di bambina aveva stabilito che abitasse il mostro quando faceva buio. Per esercitarmi a sconfiggere i miei timori, implorai i miei genitori di lasciarmi sola in casa per una sera. Furono abbastanza pazzi da assecondarmi, o forse ero stata talmente insistente da convincerli. Proprio accanto al punto in questione c’era un interruttore. Spensi tutte le luci della nostra grande casa e, al buio, cominciai a camminare, consapevole che più mi avvicinavo a quel punto, più mi avvicinavo al mostro, ma anche all’interruttore della luce. Ricordo ancora l’ultimo scatto che ho fatto con la mano, immaginando che il mostro me l’avrebbe azzannata prima che riuscissi a raggiungere l’interruttore.
Ma il mostro non lo fece, fu così gentile da lasciarmi accendere le luci e sparire. Questo ricordo mi è rimasto impresso, mi suggerisce come procedere tra le mie paure, inclusa la paura di scrivere. Con due cose però questo metodo non funziona. Due paure: una riguarda il mondo, l’altra la lingua. Ho paura che non arriverà mai il giorno in cui, guardandoci attorno, potremo dire che oggi è meglio di ieri. La seconda paura invece è perdere la lingua, svegliarmi un giorno e non averla più.
NEGLI ULTIMI MESI queste due paure sono tornate. Ed entrambe mi perseguitano anche attraverso la morte di alcuni scrittori che mi hanno fatto comprendere più a fondo la vita: Mohanned Younis, Gilles Deleuze, Gherasim Luca, Primo Levi, Sylvia Plath. Tutti morti suicidi.
Ho come la sensazione che il loro atto finale sia la conferma che queste due paure non sono il risultato della mia immaginazione, ma indicano i limiti della realtà; i limiti della lingua.
* Adania Shibli, «La lingua rubata. Di letteratura, Palestina e silenzio. Una riflessione e un dialogo con Maria Nadotti», traduzione di Nausikaa Angelotti e Daniela Marina Rossi, Collana «Alfabeti Babel». Una coedizione Babel Festival/ Edizioni Casagrande, 56 pagine chf 8./ euro 8.00.
Il libro sarà disponibile in Ticino il 12 settembre in occasione di Babel Festival 2025; in Italia a fine settembre.
*
SCHEDA. «Babel Festival», a Bellinzona fino al 14
Babel Festival di Letteratura e Traduzione di Bellinzona (11-14 settembre) arriva quest’anno alla ventesima edizione dedicata alle lingue che lo hanno formato e ne hanno ispirato la ricerca nella traduzione e nel plurilinguismo, in primis l’italiano poi le altre lingue svizzere: francese, tedesco romancio.
Tra gli e le ospiti: Alessandro Piperno, Fabio Bacà, Catherine Lovey, Claudia Quadri, Lukas Bärfuss, Ubah Cristina Ali Farah, Emanuela Anechoum. Per informazioni più dettagliate: www.babelfestival.com