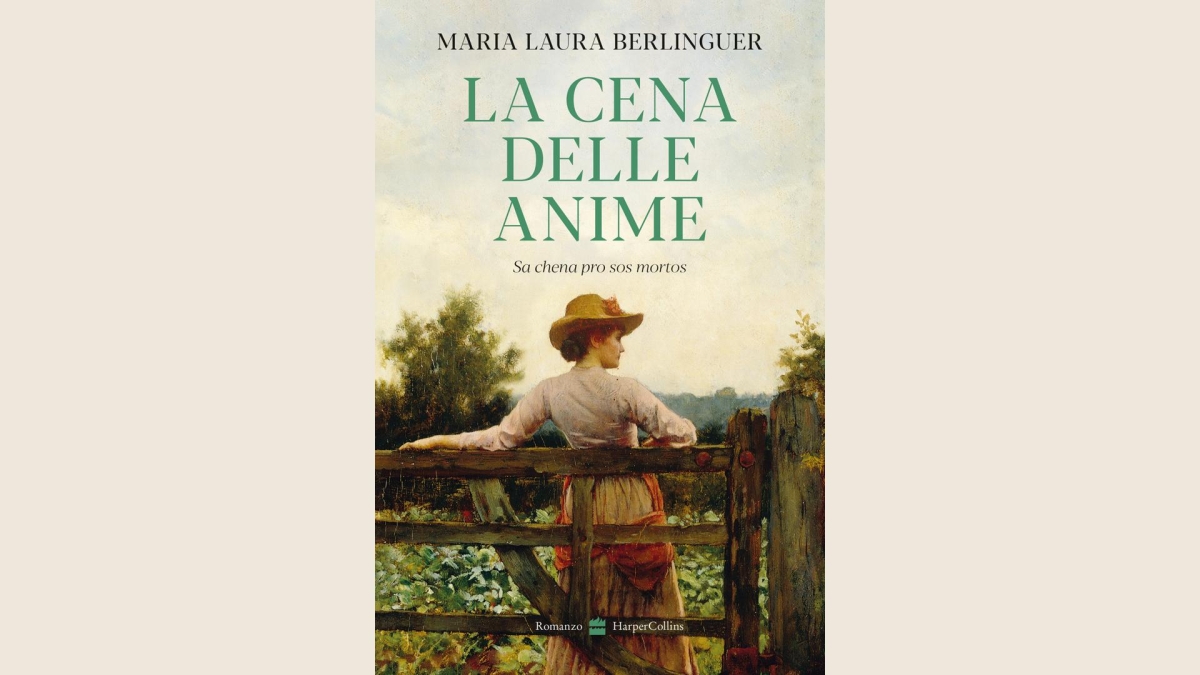di Isabella Fantigrossi
Saggi (tra cui uno di Andrea Camilleri, autore del Commissario Montalbano di cui ricorre il centenario), romanzi che portano in una Sardegna insolita, ma anche testi che aiutano i genitori a destreggiarsi nella sana alimentazione infantile: ecco le letture con cui ripartire
Veg: Cambiamo il mondo con la forchetta
Torna in libreria la pediatra Carla Tomasini, su Instagram (dove viene seguita da più di 500 mila follower) Pediatra Carla. Dopo aver spiegato alle famiglie italiane i principi dell’autosvezzamento con un libro ancora oggi best seller, ecco un godibilissimo saggio con ricette su quella che è ormai ritenuta dalla comunità scientifica l’unica alimentazione sana per l’ambiente e per l’uomo, quella basata in tutto o quasi sul consumo di cibi vegetali (Uppa Edizioni, 336 pagine, 18,90 euro).
Itinerari: I posti segreti dei funghi
Dove li hai trovati? È questa la classica domanda, a cui in genere non segue risposta, rivolta ai migliori cercatori di funghi. Ecco allora una coraggiosa guida di due di loro, il giornalista del Corriere Maurizio Donelli e il figlio Giacomo, fondatore della start-up Zonzers, dedicata ai posti segreti dove trovare porcini, ovoli e gallinacci: dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, 100 itinerari italiani corredati dalle informazioni più utili (Mondadori, 272 pagine, 22,90 euro).
Bambini: Viaggio sul pianeta nutrix
Una storia illustrata arricchita da approfondimenti sugli alimenti della piramide alimentare. Laboratori del gusto per scoprire nuovi sapori e texture. E poi una serie di ricette da realizzare con i genitori per imparare a combinare diversi ingredienti. Ecco il nuovo libro di Verdiana Ramina, una delle dietiste più amate in Italia, pensato per insegnare ai bambini e alle loro famiglie a creare pasti equilibrati e gustosi (Gribaudo, 64 pagine, 18,90 euro).
Scienza: A cena su marte
Quando l’uomo realizzerà l’impresa di raggiungere Marte, che cosa mangeranno? Quali saranno gli alimenti disponibili in un ambiente desertico, con una gravità un terzo della nostra e con una temperatura di oltre 60 gradi sotto zero? Gli scienziati Fraser e Newman ci mostrano come immaginare comunità autosufficienti in luoghi apparentemente inospitali ma anche come mettere in discussione il nostro sistema alimentare (ilSaggiatore, 264 pagine, 24 euro).
Giappone: Tokyo è una grande cucina
A Tokyo è impossibile mangiare male. Ma Flavio Parisi quando, vent’anni fa, si trasferì in Giappone, non lo sapeva. Fu però una scoperta quasi immediata: mentre cominciava la sua vita da insegnante di italiano per i cantanti d’opera di Tokyo e imparava i rudimenti della lingua, scopriva una bruciante, quanto inaspettata, passione: per la cucina giapponese. Ecco la sua guida raccontata alla scoperta della Tokyo culinaria (Utet, 256 pagine, 19 euro).
La «munnizza» di Andrea Camilleri
Basta verdura! «Una sera, verso la fine del gennaio 1943, si scatenò una specie di rivolta familiare capeggiata dallo zio Massimo. Ci unimmo tutti al grido: “Basta verdura!”. Fatto sta che due sere dopo, venuta l’ora di cena, quando fummo tutti seduti, nonna Elvira arrivò dalla cucina. Guardammo la nonna increduli, come a chiederle che cosa fosse quella specie di magnifico, alto panettone variopinto. Ricordo ancora l’impressione che mi fece il primo boccone. Una squisitezza! Una delizia! Sentii il petto che mi si slargava. Mia nonna aveva inventato un suo piatto! Quella volta stessa lo battezzò “la munnizza” perché, come la mondezza, conteneva una quantità di cose diverse tra loro».
È il racconto che fa Andrea Camilleri nell’unico suo testo interamente dedicato al cibo (sebbene tantissimi siano i riferimenti al cibo nei suoi romanzi, soprattutto nella saga del commissario Montalbano. «Le cose che non posso fare io, che non posso mangiare io, le faccio mangiare a Montalbano», disse in un’intervista del 2007.). «La munnizza», dunque, fu il suo contributo, allora inedito, all’antologia «Le ricette del cuore» pubblicata da Blu Edizioni nel 2008. Si trattava di una raccolta di contributi di grandi personaggi — da Camilleri a Lidia Ravera, da Cristina Comencini a Paolo Giordano —, curata da Carla Sacchi Ferrero, che raccontavano la loro ricetta della memoria per devolvere i diritti d’autore al Banco Alimentare. Camilleri, per la verità, aveva citato per la prima volta il piatto di nonna Elvira nel gennaio del 2000 durante una trasmissione radiofonica su Radio Rai2.
Fatto sta che, oggi, in occasione del centenario della nascita dello scrittore, che si è celebrata lo scorso 6 settembre, Henry Beyle — casa editrice milanese specializzata in piccoli testi stampati su carte di pregio in tirature limitate (intonsi, in modo da affidare al lettore il privilegio del taglio dei singoli fogli col procedere della lettura) — ha scelto di pubblicare il racconto di Camilleri sotto il titolo «Un’invenzione gastronomica». La «munnizza» era diventato il piatto di casa della famiglia Camilleri, nove affamate bocche che nella seconda metà del 1942 si erano trasferite nella grande casa di campagna, non lontano da Porto Empedocle. Andrea ha diciassette anni. I tempi sono magri, durante la guerra il cibo scarseggia sempre. E nonna Elvira, cuoca sopraffina sempre ricordata dallo scrittore — «mater familias, ai tempi belli cuoca sopraffina di arancini sublimi, a mezzogiorno qualcosa riusciva ad arrangiarlo per tacitare le nostre nove (tanti eravamo) affamate bocche» — deve industriarsi per trasformare il poco che c’è in ricette indimenticabili (la «munnizza» lo divenne, Camilleri l’ha preparata per tutta la vita). «Il vero problema consisteva nel pasto serale. Non si scappava dalle verdure, quelle dell’orto amorosamente curato e quelle selvatiche che si trovavano in abbondanza nel nostro campo». Così un giorno, su richiesta dello zio Massimo, ecco arrivare in tavola una specie di pasticcio, composto per strati alternati, di verdure cotte e crude, almeno otto o dieci tipi diversi, posizionate sopra una base di gallette del marinaio. Questa specie di panettone colorati viene poi condito e ricoperto da acciughe, capperi, sarde, fettine di uova sode, fette di arance, di patate lesse e da olive. Dopo una vita di assaggi, Camilleri (che sapeva cucinare per davvero, come raccontarono le figlie Andreina e Mariolina) consigliava di lasciare riposare la «munnizza» dopo la preparazione e di mangiarla il giorno dopo, «quando tutta questa roba si è amalgamata a dovere». «Ogni volta che la rifaccio — diceva lo scrittore — assaporo il piacere di tornare indietro nel tempo. Anche se la verità è che i sapori del passato sono irripetibili». Il testo di Henry Beyle è disponibile in una doppia edizione di lusso: in 500 copie cucite a mano in carta Cordenons e in 100 copie numerate in cofanetto.
La cena delle anime, il rito che parla di noi
Quattro donne. Iride Dessì, che torna a casa, a Padria, dopo lunghi anni lontano, per la morte del padre. Tata, la governante che si è presa cura di lei quando era bambina e che custodisce preziosi segreti di famiglia. E poi Mimì Oppes, la trisavola di Iride, intrappolata in un matrimonio infelice ma viva grazie all’amore clandestino con il famoso brigante Emanuele Manca. E la sua amica inglese Elizabeth Hope, donna libera ed indipendente. Sono loro le quattro protagoniste dell’ultimo romanzo di Maria Laura Berlinguer, La cena delle anime, già in corso di traduzione in Francia, Germania, Olanda, Spagna e Svezia. Una saga familiare costruita su due piani temporali che continuamente si alternano, il 1866 in cui vissero Mimì ed Elizabeth e il 2022 di Iride e Tata. E che si apre e si chiude con la misteriosa cena delle anime a cui allude il titolo. Un antico rito sardo, vivo ancora in alcune zone dell’isola, «sa chena pro sos mortos»: cioè l’usanza di apparecchiare la tavola per i propri defunti nella notte tra l’1 e il 2
novembre. Tra dolci, pani, ricette delle feste e tovaglie ricamate, le famiglie imbandivano le loro tavole per mantenere un legame, una connessione, con i propri cari, per riallestire un ponte tra vivi e morti, che tornano nelle case come spiriti benevoli, come custodi affettuosi. Ed è proprio quella cena delle anime che fa capire al lettore qual è la quinta, nascosta, protagonista del romanzo: la memoria familiare che, se resta viva, aiuta a guardare avanti. Iride alla fine, scoprendo la verità su Mimì e sulla sua famiglia, ritrova se stessa. Come dire che, conoscendo il proprio passato, si può costruire un futuro più autentico. La stessa Maria Laura Berlinguer, 59 anni, figlia di Paolo cugino di Enrico Berlinguer, che per anni si è occupata di comunicazione e relazioni istituzionali prima di dedicarsi alla scrittura, ha guardato al suo passato per costruire la trama del suo romanzo. Le tre spade votive di Padria di cui si racconta nel libro, oggi conservate al Museo nazionale archeologico Sanna di Sassari, erano appartenute a Vincenzo Dessì, antenato dell’autrice, archeologo e collezionista sardo. È, dunque, questa la Sardegna che fa da sfondo al romanzo di Berlinguer. Una terra lontana anni luce dallo stereotipo di isola vacanziera e, allo stesso tempo, distante dalla tradizione pastorale che ha fatto da sfondo a tanti romanzi scritti da autori sardi. La Sardegna delle anime di Maria Laura Berlinguer è colta, popolata da donne e uomini borghesi e illuminati che, nel diciannovesimo secolo, viaggiavano, discutevano di filosofia, arti, scienza e animavano salotti letterari. Una Sardegna raffinata che ha sempre guardato al suo passato per immaginare il proprio domani. Proprio come durante la cena delle anime.
Per ricevere tutte le notizie più imperdibili del mondo food
iscriviti alle newsletter di COOK
19 ottobre 2025 – 07:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA