di Alessia Calzolari
Il medico specialista in medicina anti-aging e medicina funzionale torna in libreria con un volume dedicato alla longevità
Filippo Ongaro è stato il primo italiano a certificarsi in medicina anti-aging e medicina funzionale negli Stati Uniti e con il suo Metodo Ongaro aiuta dal 2018 le persone a cambiare abitudini per vivere meglio e più a lungo. I capisaldi del metodo sono nutrizione, nutraceutica, allenamento e lavoro interiore. Oggi, 9 settembre 2025, esce il suo tredicesimo libro: Il mindset della longevità, edito da Vallardi. Un’opera che si inserisce in un tema sempre più dibattuto, studiato e «pubblicizzato», e continua a suscitare tanto interesse nel pubblico.
Dottor Ongaro, perché il tema della longevità ci affascina così tanto e cos’è che ancora non sappiamo per poter davvero vivere a lungo e in salute?
«C’è ancora tanto che non sappiamo, ma soprattutto c’è tanto che non facciamo. C’è un enorme gap tra la teoria e la pratica. Il campo della longevità è associato a una costante ricerca di novità, ma il primo passo sarebbe intanto iniziare ad applicare ciò che già sappiamo: è inutile focalizzarsi sull’ultimo studio appena pubblicato, magari che si basa su un modello animale, ma di cui non sappiamo poi gli effetti reali a lungo termine. Si ha sempre l’impressione di non saperne mai abbastanza per poter iniziare a potersi occupare della propria salute».
Se ne parla, quindi, sempre di più, ma facciamo fatica ad applicare i consigli che gli esperti danno. Perché?
«Se mi avvicino al tema della longevità adesso, incappo in nozioni che possono apparire estreme, come il digiuno o il bagno nell’acqua ghiacciata. Mi spavento ancora prima di partire, c’è una sorta di shock e sembra tutto troppo complicato. Dovrei fare un sacrificio per aggiungere un’abitudine, che mi costa fatica, a una quotidianità, che già mi mette sotto sforzo. In più non vedo neanche dei risultati immediati. Ci sono delle ragioni neurobiologiche dietro a questo comportamento: parliamo di incongruenza temporale, perché cerchiamo il piacere immediato.
In realtà quello che fa la differenza sono quelle piccole abitudini che diventano quotidiane e che vengono mantenute per lungo tempo. Per farlo devo creare un nuovo sistema di gratificazione e non vedere più lo sport o la sana alimentazione come sacrificio o disciplina. Le neuroscienze ci aiutano anche in questo, cioè a dosare il cambiamento e renderlo, così, efficace soprattutto per chi parte da zero».
Quale potrebbe essere un cambiamento minimo da apportare facilmente?
«Chi non ha mai fatto sport può partire con il camminare 10 minuti al giorno, tutti i giorni per qualche mese. È ovvio che non è il livello di attività fisica ottimale, ma basta per iniziare se si parte da una situazione di sedentarietà. Diventerà poi un’abitudine, che porterà a gratificazione e poi sarà facile aumentare gradualmente il livello di attività fisica. Anzi, sarà la persona stessa a cercare di fare progressivamente sempre più movimento».
E se volessimo applicare questa strategia all’alimentazione?
«Niente diete drastiche, ma micro-cambiamenti. Quindi si può iniziare dall’inserire le verdure a ogni pasto, poi quando questo è diventato automatico si sostituiscono i cereali raffinati con quelli integrali. Quando anche questo è diventato semplice si può provare a passare al piatto unico: metà piatto di verdura e metà tra cereali e integrali e proteine, quindi pesce, carne, legumi, uova e latticini. Anche qui, di fatto, la chiave è la gradualità, così da non creare “scossoni” che possono portare il cervello ad andare nella direzione opposta».
Se si torna però la sera tardi e stanchissimi dal lavoro, forse è più allettante un gelato sul divano che non andare in palestra o mangiare un piatto unico. Qual è l’impatto del nostro assetto socio-culturale sulla salute?
«La rivoluzione tecnologica ci aveva promesso che avremmo avuto più tempo, ma non è stato così. Bisogna allora compiere azioni concrete per prevenire di tornare a casa esausti: fare abbastanza pause, anche solo di un minuto, mangiare e bere a sufficienza e poi inserire magari all’inizio della giornata ciò che la sera non riusciamo a fare. È più facile compiere decisioni difficili al mattino, anziché alla sera: si parla di fatica decisionale, cioè la qualità delle decisioni diminuisce all’aumentare del numero di decisioni prese. Per questo stesso motivo è più facile essere attenti all’alimentazione a colazione, che non la sera, quando cerco energia e dopamina e il cibo risponde a questi due bisogni».
Quali sarebbero tre tip che darebbe a chi non ha mai fatto niente e vuole iniziare a instaurare delle abitudini per la longevità?
«Fallo al mattino, inizia con dosi modeste e non pensare a stravolgere la tua alimentazione, ma inizia semplicemente a iniziare ogni pasto con una porzione di verdure».
Quando è troppo tardi per iniziare a prendersi cura della propria longevità?
«I dati ci mostrano che dal punto di vista biologico ci sono benefici su corpo e cervello a qualsiasi età: una persona sedentaria di 50 anni, ad esempio, recupera due anni di inattività con due mesi di palestra. Grazie alle neuroscienze sappiamo anche che il nostro cervello non smette mai di apprendere. Se si supera l’inerzia iniziale ci sono grandissimi benefici emotivi, in qualità del sonno e nel livello di energia anche negli anziani dati da una blanda attività fisica. Chiaramente, però, prima si inizia, più sarà potente il risultato. La longevità è un tema da trentenni».
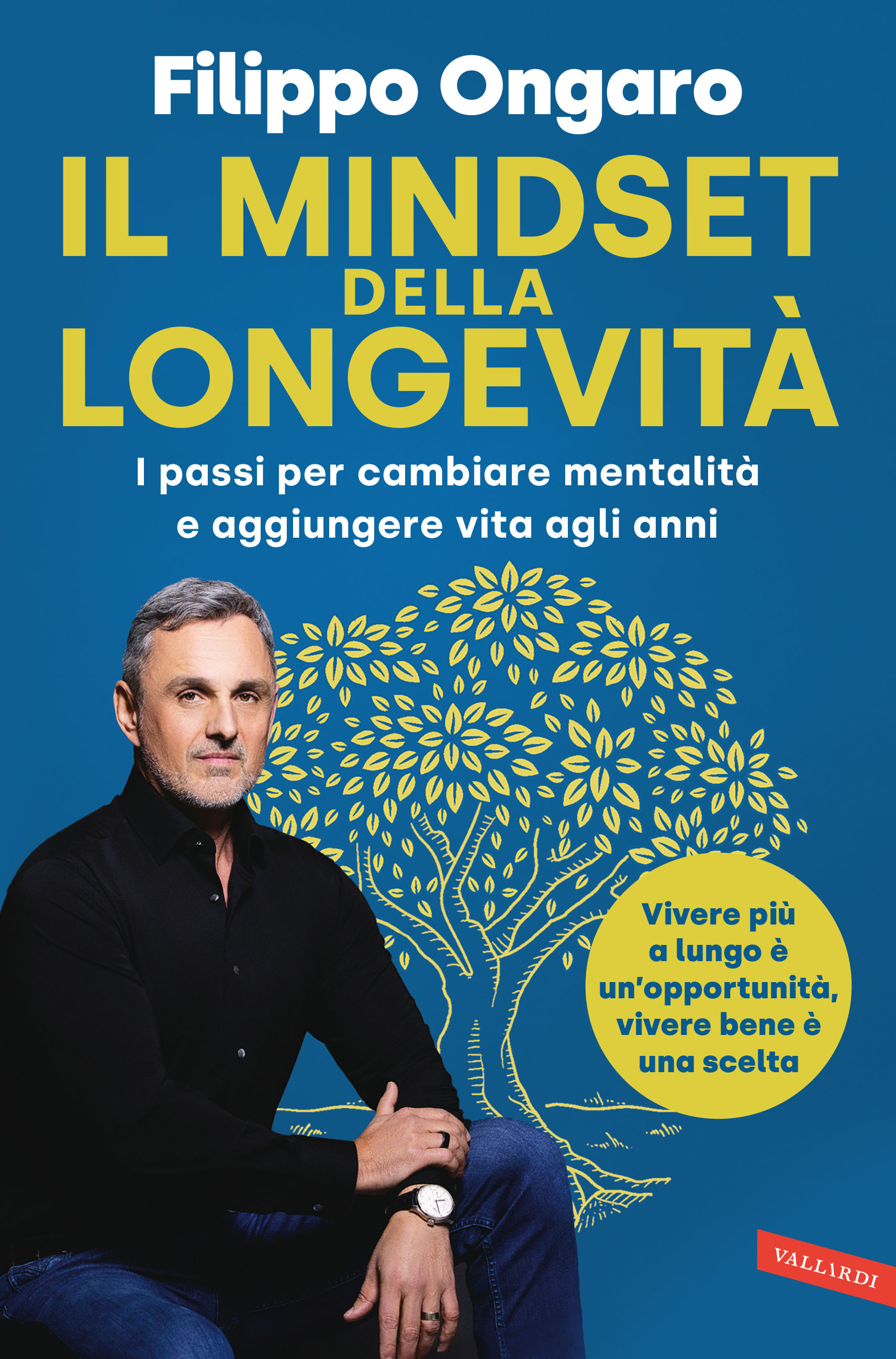
Ci racconta un po’ del suo ultimo libro, Il mindset della longevità?
«In questo libro parlo di temi che riguardano più la psiche e il nostro mondo interiore. Mi sono reso conto che le persone che seguono un certo regime di alimentazione e allenamento non usano mai termini come disciplina, sforzo, fatica. Questi vocaboli appartengono, invece, al lessico di chi ha uno stile di vita più sedentario e meno attento alla propria dieta. Ho cercato di capire quali sono le variabili che fanno la differenza nel mindset (la mentalità, ndr), che è plastico: anche in questo caso piccole abitudini portano a modificare il proprio approccio al cambiamento, grazie a un processo di auto-riflessione e comprensione delle cose. Insomma, cercare di acquisire in maniera rigida ed estrema dei comportamenti di per sé salutari è, alla fine, un boomerang».
9 settembre 2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA
